Davar Acher – Babbo Natale e il nostro disagio
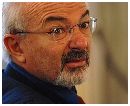 E’ un sentimento condiviso, mi sembra, anche se non ne parliamo: durante le feste che concludono l’anno civile, si sente un disagio ebraico. Non certo per la festività cristiana, io credo, che tutti quanti sappiamo rispettare senza difficoltà, senza condividerla ma senza provare per essa sentimenti negativi. A turbarci non è certo la nascita e la circoncisione avvenute venti secoli fa di un bimbo ebreo che i cristiani venerano come messia e terza “persona” della divinità. Siamo ovviamente in disaccordo sul punto teologico, ma su quello psicologico ci sentiamo gentilmente estranei, non coinvolti, amichevolmente lontani. E naturalmente rispettosi, perché il Cristianesimo è un grande fenomeno religioso che sarebbe poco sensato non considerare seriamente anche in occasione delle sue feste più solenni.
E’ un sentimento condiviso, mi sembra, anche se non ne parliamo: durante le feste che concludono l’anno civile, si sente un disagio ebraico. Non certo per la festività cristiana, io credo, che tutti quanti sappiamo rispettare senza difficoltà, senza condividerla ma senza provare per essa sentimenti negativi. A turbarci non è certo la nascita e la circoncisione avvenute venti secoli fa di un bimbo ebreo che i cristiani venerano come messia e terza “persona” della divinità. Siamo ovviamente in disaccordo sul punto teologico, ma su quello psicologico ci sentiamo gentilmente estranei, non coinvolti, amichevolmente lontani. E naturalmente rispettosi, perché il Cristianesimo è un grande fenomeno religioso che sarebbe poco sensato non considerare seriamente anche in occasione delle sue feste più solenni.
Ci sono invece altri fatti ricorrenti che invece ci riguardano per forza, cui però non possiamo sfuggire come abitanti di questo paese o semplicemente del mondo occidentale. Elementi poco o nulla religiosi, e molto invece rilevanti nella sfera delle relazioni interpersonali e dei consumi. Le luminarie, gli abeti, le zampogne, i messaggi di auguri, le vetrine illuminate e strapiene di merci. E naturalmente per la corsa ai regali, i cartoncini di auguri, le mutande rosse che negli ultimi anni sembrano diventate obbligatorie per i giovani a capodanno. Gli oroscopi del nuovo anno, superstizione intorno alla superstizione. Il consumo di cibi lussuosi e poco sani. Lo champagne.
E ancora quelle strane creature mitiche che sono i babbi Natali: bizzarra trasformazione, dicono gli storici di un mitico hagios Nikolaos – letteralmente santo vincitore del popolo, forse mai esistito forse vescovo di Myra in Licia – in San Nicola “da Bari”, San Nicola il grande, San Niccolò, Sinterclass, Santa Klaus, Santa e basta, Weinnachtman, Pére Noel; passato in ultimo negli anni Trenta dal tradizionale verde alla divisa della pubblicità della Coca cola) e ormai diffuso in tutto il mondo.
In un delizioso articolo sul tema, scritto giusto sessant’anni fa, Claude Lévi Strauss definiva il vecchio dalla barba bianca trasportato dalle renne “un re” in quanto “è vestito di scarlatto” e spiegava che “non è un essere mitico, poiché non c’è mito che renda conto della sua origine e delle sue funzioni; e non è nemmeno un personaggio di leggenda, poiché non è collegato a nessun racconto semistorico. Appartiene piuttosto alla famiglia delle divinità. E’ la divinità di una sola fascia di età della nostra società e la sola differenza tra Babbo Natale e una vera divinità è che gli adulti non credono in lui, benché incoraggino i propri figli a crederci.” (“Babbo Natale giustiziato”, Sellerio Editore, Palermo)
Tutta questa – diciamo – sfrenata creatività paganeggiante si prolunga in quella che circonda capodanno, che sarebbe la festa della circoncisione di Gesù, ma è festeggiata con pupazzi di “vecchie” bruciate, stoviglie scaraventate in strada, conti alla rovescia collettivi, obbligo in certi ambienti di ubriacatura e sesso propiziatorio, abbigliamenti bizzarri (una cosa nuova, una cosa vecchia, una cosa rossa, ecc.) e poi ancora con l’Epifania, “l’apparizione”, trasformata linguisticamente nella “Befana” e miticamente in una vecchia semidivinità stregonesca, che scende dai camini e porta carbone. E’ un fatto strano ma certo che questi strani riti o superstizioni non imbarazzano più che tanto i buoni cristiani i quali potrebbero a buon diritto sentirle come una dissacrazione della loro fede; ma all’ebreo medio creano più di qualche problema, un senso di estraneità, un disagio.
Come rispondere ai gentili auguri degli amici, senza far troppo i pedanti e dire “grazie ma io non ci credo”, e però neppure assimilarci a quelle che a noi paiono bizzarre superstizioni? Come non contraccambiare il clima benevolo e augurante senza fare i guastafeste? Certo, dal delirio consumistico è facile star lontani (anche se un certo contagio ci è arrivato con i “mercatini di Hannukka). Ed è ovvio per un ebreo rispettare ma non prendere parte alle cerimonie religiose vere, come le messe di mezzanotte. E’ certamente educato fare gli auguri ai cristiani, come loro li fanno a noi per le nostre feste.
Ma di fronte alla dimensione civile, collettiva e coinvolgente, apparentemente non religiosa, del cambiamento di data che ogni anno dovrebbe rinnovare il mondo e migliorarlo, come sosteneva il venditore d’almanacchi di Leopardi, come evitare di augurare ad amici e colleghi “buon anno commerciale”, come facevano i nostri nonni, e magari accettare di divertirsi molto laicamente come fanno tutti intorno a noi? Di guardare i fuochi d’artificio, essere coinvolti nell’attesa televisiva di mezzanotte, di stare in compagnia? Se non vanno in Israele, come molti preferiscono, è quel che capita, io credo, a una buona parte degli ebrei italiani e occidentali. Non spetta certamente a me giudicare i gradi di questi compromessi. Ma io sento che comunque il disagio resta – segno di una distanza rispetto a uno dei momenti più comunitari e indifferenziati, più rituali e “antichi” dunque, della società in cui viviamo. E penso che questo disagio sia una buona cosa, perché ci rimanda alla nostra differenza e alla nostra identità.
Ugo Volli
