Qui Milano – Ripensare la Memoria
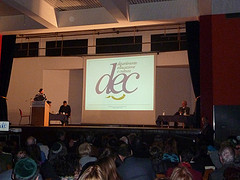 Il Giorno della Memoria è stato istituito dal Parlamento con la legge 211 del 2000. Sin dal primo momento un ampio dibattito ha attraversato il mondo ebraico italiano circa il ruolo da assumere nei confronti di questa ricorrenza, e sul significato da attribuirle. Domande che dopo un’esperienza ormai decennale l’ebraismo italiano continua a porsi. E, se l’incontro di ieri organizzato dalla Comunità ebraica di Milano e dal Dipartimento educazione e cultura dell’UCEI con la collaborazione di Kesher, non pretendeva di dare delle risposte, come ha sottolineato l’assessore alla cultura della Comunità Daniele Cohen in apertura, sicuramente ha fornito importanti spunti di riflessione, sotto punti di vista differenti, data la diversa esperienza degli oratori, rav Roberto Della Rocca, direttore del Dec, David Bidussa, storico e saggista, Michele Sarfatti, direttore del Centro di documentazione ebraica contemporanea, Sonia Brunetti Luzzati, vicepreside della scuola ebraica di Torino e pedagogista, Haim Baharier, studioso del pensiero ebraico.
Il Giorno della Memoria è stato istituito dal Parlamento con la legge 211 del 2000. Sin dal primo momento un ampio dibattito ha attraversato il mondo ebraico italiano circa il ruolo da assumere nei confronti di questa ricorrenza, e sul significato da attribuirle. Domande che dopo un’esperienza ormai decennale l’ebraismo italiano continua a porsi. E, se l’incontro di ieri organizzato dalla Comunità ebraica di Milano e dal Dipartimento educazione e cultura dell’UCEI con la collaborazione di Kesher, non pretendeva di dare delle risposte, come ha sottolineato l’assessore alla cultura della Comunità Daniele Cohen in apertura, sicuramente ha fornito importanti spunti di riflessione, sotto punti di vista differenti, data la diversa esperienza degli oratori, rav Roberto Della Rocca, direttore del Dec, David Bidussa, storico e saggista, Michele Sarfatti, direttore del Centro di documentazione ebraica contemporanea, Sonia Brunetti Luzzati, vicepreside della scuola ebraica di Torino e pedagogista, Haim Baharier, studioso del pensiero ebraico.
Davanti a una platea completamente gremita, rav Della Rocca ha introdotto la serata ‘Luoghi della Memoria e Percorsi di identità’ parlando di uno dei pilastri su cui si è costituita la religione ebraica, la centralità della vita, prendendo le mosse da uno degli episodi più drammatici della Torah, il sacrificio di Isacco. “Se Abramo avesse portato a termine il sacrificio di suo figlio sarebbe diventato il più grande degli eroi, ma D-o non lo permise. Nell’ebraismo non c’è la vocazione al martirio, per quanto catastrofica possa essere, è necessario scegliere la vita”. Il rav ha concluso soffermandosi su un altro fondamento dell’ebraismo, l’attitudine a ricordare il passato, senza una dimensione istituzionalizzata “perché per noi ogni giorno è il Giorno della Memoria, perché quando recitiamo lo Shemah e mettiamo i teffillim, ricordiamo a noi stessi e al mondo chi siamo e da dove veniamo”. Dalla straordinaria capacità di ricordare “un altro tentativo di etnocidio, sistematico e progettuale, avvenuto in una terra chiamata Mizraim (Egitto), quaranta secoli fa” ha preso le mosse anche l’intervento di Haim Baharier, che, come figlio di due sopravvissuti ad Auschwitz, ha però esortato a trovare “un nuovo linguaggio e un nuovo approccio per ricordare, smettendo di essere ossessionati dai fatti e dalle immagini”.
I contributi di David Bidussa e Michele Sarfatti si sono concentrati su una differente prospettiva, e in particolare sul ruolo che il Giorno della Memoria ha assunto nella società civile del nostro paese, e sul contributo che gli ebrei italiani possono dare in questa prospettiva. “L’ebraismo ha già il suo Giorno della Memoria, Yom Ha Shoah, che coincide con l’insurrezione nel Ghetto di Varsavia – ha ricordato il professor Bidussa – Il 27 gennaio si dovrebbe riflettere su ciò che accade quando le ideologie diventano potere pubblico. L’Italia sulla Shoah non fa analisi, la guarda come qualcosa di altro da sè, pur se avvenuta sul proprio territorio. Per questo si è scelta una data non italiana. E oggi sembra che ci sia sempre più urgenza di riempire il calendario con giorni dedicati alla memoria di qualcuno, perché altrimenti il paese pare privo della capacità di ricordare. Ma la cosa grave è che tutto questo non si traduce nella creazione di un’etica pubblica. Se l’ebraismo può assumere un ruolo in questo Giorno della Memoria è quello di domandare la nascita di una morale pubblica, non solo per noi stessi, ma anche per tutti coloro che sono accanto a noi”. Un’esortazione condivisa da Michele Sarfatti che come direttore del Cdec ha raccontato alcuni dettagli sulla genesi del Giorno della Memoria. “Furono presi in considerazione diversi momenti, ma alla fine fu scelto il 27 gennaio perché la si considerava una data che riguardava tutta Italia, e non una singola città e perché si riteneva necessario che la ricorrenza fosse legata all’aspetto più terribile della tragedia che colpì gli ebrei, la deportazione nei campi di sterminio – ha spiegato il professore – A distanza di alcuni anni non sono sicuro che sia stato un ragionamento giusto. Soprattutto penso che sia pericoloso l’assunto che l’unicità della Shoah riesca ad emergere nella maniera corretta con l’unicità del Giorno della Memoria, che assume nei confronti delle altre date commemorative un peso preponderante. E allora rischia di passare un messaggio sbagliato, quello di un ‘privilegio’ concesso agli ebrei. Per evitarlo è molto importante che ci facciamo carico di tante Memorie, di quello che accadde a noi e quello che accadde agli altri. Questa deve essere oggi la nostra sfida”.
Ma la forte attenzione alla Memoria della Shoah può essere rischiosa se non affrontata nel modo giusto, specie quando si tratta il tema nelle scuole, come ammonisce Sonia Brunetti “Il problema di fronte a cui ci troviamo è che è impossibile capire cos’è stata la Shoah partendo dai campi di sterminio – ha evidenziato – perché non si può capire una storia, la Storia, partendo dalla sua conclusione. Per un percorso didattico serio servono tempo e impegno, che purtroppo non sempre gli insegnanti hanno la possibilità o la volontà di mettere in campo. E d’altra parte, senza un’adeguata preparazione, persino le visite ad Auschwitz, i viaggi della Memoria, che pure possono essere esperienze importanti, rischiano di diventare una semplice gita scolastica”.
A concludere l’incontro è stato un intervento del rabbino capo di Milano Alfonso Arbib “Penso che questa serata sia stata interessante perché capita raramente di riflettere in questo modo sulla Memoria. Vorrei aggiungere solo una considerazione: come dobbiamo stare attenti a non trasformare il Giorno della Memoria in un surrogato di identità nazionale, dobbiamo evitare che lo stesso meccanismo si produca con l’identità ebraica”.
Rossella Tercatin
