Qui Roma – Una famiglia, la nostra storia
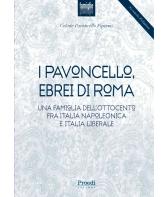 Nato come dissertazione finale del Corso triennale in Studi ebraici, il piccolo volume di Celeste Pavoncello, “I Pavoncello, Ebrei di Roma” è la storia di una famiglia ebraica romana: una famiglia “qualunque”, “che in questo modo vuole rimarcarne tanto la tipicità quanto il radicamento, profondo e forte, in un contesto particolarissimo, e a sua volta carico di storia”. Così Enzo Campelli parla del libro di Celeste Pavoncello che racconta la storia della sua famiglia che va dalla nascita del capostipite, Angelo Samuele (1806), alla costruzione del Tempio Maggiore (1904).
Nato come dissertazione finale del Corso triennale in Studi ebraici, il piccolo volume di Celeste Pavoncello, “I Pavoncello, Ebrei di Roma” è la storia di una famiglia ebraica romana: una famiglia “qualunque”, “che in questo modo vuole rimarcarne tanto la tipicità quanto il radicamento, profondo e forte, in un contesto particolarissimo, e a sua volta carico di storia”. Così Enzo Campelli parla del libro di Celeste Pavoncello che racconta la storia della sua famiglia che va dalla nascita del capostipite, Angelo Samuele (1806), alla costruzione del Tempio Maggiore (1904).
Celeste, come ti sei cimentata con la storia della tua famiglia?
Ho voluto approfondire lo studio di qualche cosa che mi riguardasse da vicino. Quando ho preso la mia prima laurea in Scienze Politiche ho fatto uno studio sulla famiglia Ovazza, e sul periodico “La Nostra Bandiera”, lo studio della storia delle famiglie mi ha sempre affascinato e giunta a cinquanta anni mi sembrava il momento di parlare della mia
 Chi sono i Pavoncello?
Chi sono i Pavoncello?
I Pavoncello, costituiscono una famiglia del ghetto come tante altre, non abbiente, formata principalmente da “bottegari”, da coloro cioè che costituiscono lo zoccolo duro della Comunità, che sono garanti della tradizione ebraica. Dalla nascita di Angelo Samuele in poi, assistiamo a una sequenza di eventi che caratterizzarono la storia della Comunità: le difficoltà e i problemi legati alla vita nel ghetto, l’emancipazione ed il passaggio dal commercio degli abiti usati ad attività più gratificanti. A fianco alla storia della famiglia il lettore potrà ricavare una molteplicità di notizie comuni anche alle altre famiglie del ghetto: sugli usi dotali, ad esempio, o sulle transazioni relative allo jus gazzagà, le scelte matrimoniali, con patto dotale e dopo dieci anni del divorzio delle stesse persone, uno dei documenti che più mi ha colpito è stata una “conversione forzata” in punto di morte, presso l’ospedale Santo Spirito nel 1870, ma anche sul comportamento religioso e sulle caratteristiche dei processi di stratificazione e di mobilità sociale che hanno interessato gli ebrei romani e la loro Comunità a partire dai primi decenni dell’Ottocento, nonché – infine – sulle specificità, spesso impervie, del percorso successivo all’uscita dal ghetto. Va da sé che i Pavoncello registrati come Mosè, Abramo e Sabato Leone venissero nella vita quotidiana, sulla scia dell’emancipazione post 1870, chiamati rispettivamente Marco, Alberto e Settimio. In questo lavoro si è preferito utilizzare l’onomastica ufficiale e non quella famigliare. Mi preme precisare che nella seconda edizione sono presenti nell’albero genealogico i nomi di alcuni Pavoncello che non comparivano nella prima edizione. Questo poiché inizialmente ci si è attenuti solo ai dati forniti dall’Archivio Storico della Comunità, i cui registri anagrafici possono essere consultati solo fino al 1891 (la documentazione novecentesca è infatti in corso di riordino). I nomi ora aggiunti (riportati con carattere diverso) sono il risultato di una ricerca condotta attraverso fonti orali. Un’ultima precisazione: la ricostruzione qui condotta è di tipo verticale, cioè è stata privilegiata la linea maschile in senso patrilineare, per cui rimangono esclusi da queste pagine una serie di altri Pavoncello che appartenevano ai rami cadetti.
Di quali fonti ti sei avvalsa?
Questo scritto è frutto di una ricerca essenzialmente di tipo archivistico. Si tratta di fonti di prima mano, le quali hanno richiesto la consultazione di scritture tipologicamente molto diverse fra loro. A essere indagate sono state per prime le carte conservate presso l’Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma, dove mi sono avvalsa della competenza e della disponibilità di Claudio Procaccia, di Silvia Haia Antonucci e di Giancarlo Spizzichino. La ricerca è quindi proseguita con i protocolli notarili custoditi presso l’Archivio Capitolino, l’Archivio di Stato di Roma e presso l’Archivio del Vicariato, rivelatisi una miniera di informazioni capaci di gettare luce su questioni non solo patrimoniali, ma anche religiose e sentimentali.
Lucilla Efrati
