Davar acher – Il frutto di una scelta
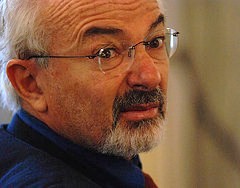 La riflessione sull’esilio, e al rapporto sempre problematico di “occupazione” della terra, che ne è una conseguenza, si può integrare con quella sul linguaggio. Come noi sappiamo e ripetiamo nella nostra memoria culturale di non essere indigeni di Eretz Yisrael, di averla acquisita faticosamente e proprio per questo di esservi legati tanto che la nostra identità di popolo dipende da questo rapporto, così accade in un certo senso con la lingua. L’ebraico non è stato per almeno due millenni il linguaggio delle comunità ebraiche sparse per il mondo; abbiamo la certezza che non lo era nemmeno negli ultimi secoli della residenza ebraica antica in Eretz Yisrael: per esempio le “spiegazioni” degli aiutanti di Esdra della Legge di nuovo proclamata a Jerushalaim, dopo il ritorno dall’esilio babilonese, erano probabilmente già una traduzione in aramaico, dello stesso tipo prima solo orale e poi scritto nei Targumim che il Talmud discute a lungo.
La riflessione sull’esilio, e al rapporto sempre problematico di “occupazione” della terra, che ne è una conseguenza, si può integrare con quella sul linguaggio. Come noi sappiamo e ripetiamo nella nostra memoria culturale di non essere indigeni di Eretz Yisrael, di averla acquisita faticosamente e proprio per questo di esservi legati tanto che la nostra identità di popolo dipende da questo rapporto, così accade in un certo senso con la lingua. L’ebraico non è stato per almeno due millenni il linguaggio delle comunità ebraiche sparse per il mondo; abbiamo la certezza che non lo era nemmeno negli ultimi secoli della residenza ebraica antica in Eretz Yisrael: per esempio le “spiegazioni” degli aiutanti di Esdra della Legge di nuovo proclamata a Jerushalaim, dopo il ritorno dall’esilio babilonese, erano probabilmente già una traduzione in aramaico, dello stesso tipo prima solo orale e poi scritto nei Targumim che il Talmud discute a lungo.
Pure l’ebraico è continuato a vivere per due millenni e mezzo non solo come lingua liturgica ma anche come idioma dei dotti e veicolo di scambio fra le diverse comunità. E’ stato sempre tenuto vivo, in esso sono stati composti trattati e poesie sinagogali, essa è stata studiata da decine di generazioni che parlavano altri idiomi come un segno di identità e un modo essenziale per accedere alla realtà dal punto di vista ebraico: qualcosa di ben più essenziale e caratterizzante della sopravvivenza medievale del latino.
Il ritorno in Israele produsse, com’è noto, la straordinaria impresa di Eliezer Ben Jehuda di farne una lingua non solo viva ma anche quotidiana, adatta alla realtà di una nazione moderna, capace di rendere tutta l’enciclopedia contemporanea. Non è il solo caso in cui una lingua colta sia diventata d’uso: tutto il processo di costruzione delle nazioni in Europa è passato per processi del genere, dall’italiano “inventato” da Dante e rimasto quasi solo scritto fino a un secolo e mezzo fa, al tedesco di Lutero, al greco moderno – demotiki sì, cioè popolare, ma adottato da tutta una popolazione frammentata e privata di identità linguistica comune dal dominio turco.
Potrei continuare, ma il caso dell’ebraico è certamente più radicale, proprio perché connesso a un grande fenomeno di immigrazione/colonizzazione, progettato da un individuo ben preciso e formalmente deciso in funzione di una rottura fra il popolo ritornato e la lunga parentesi dell’esilio. Senza l’opera di Ben Yehuda, oggi gli israeliani, se pur ci fossero, parlerebbero un po’ yiddish, un po’ arabo, le lingue europee per la cultura (ricordo che ci fu un grande conflitto intorno alla lingua da usare nelle lezioni del Technion, l’istituzione universitaria di eccellenza per la scienza: all’inizio era il tedesco e solo dopo un duro confronto fu adottato l’ebraico). Sembra una stranezza, ma sono fatti recenti e ben documentati. Ed è chiaro che un’Israele senza ebraico sarebbe stato qualcos’altro, molto meno autonoma e identificata.
Ora il punto significativo è che l’adozione dell’ebraico, come l’alyà furono decisi. Non avvennero spontaneamente, furono il frutto di una scelta. E’ un carattere generale della storia ebraica il suo non svolgersi nei momenti capitali “naturalmente”, ma per via di decisioni, rotture, scelte difficili. Questo è vero della nostra storia sacra (il lekh lekha di Abramo, l’esodo dall’Egitto, l’istituzione del regno sono alcune di queste scelte), ma è vero anche della storia profana e più documentata, dalla resistenza all’ellenizzazione che celebriamo a Pesach a quella al cristianesimo e poi all’Islam che è stata determinante per il nostro destino negli ultimi venti secoli, fino naturalmente al sionismo e alla costruzione dello stato di Israele.
Questa determinazione antica passa e permanente passa anche da sempre e consapevolmente per il linguaggio: i nostri saggi hanno affermato che i discendenti di Jaakov poterono uscire dall’Egitto anche perché “avevano mantenuto nomi ebraici”. Niente è più personale di un nome proprio, sembrerebbe; ma allo stesso tempo esso è spia di una forma di vita collettiva, di un rapporto con la realtà. Ogni linguaggio può certamente esprimere qualunque cosa, lo si sa bene in Israele dove con le stesse radici di trenta secoli fa si parla di fisica nucleare o di Internet e di marketing. Ma la ricerca linguistica conferma che i diversi linguaggi filtrano in maniera diversa la realtà, sottolineandone caratteristiche diverse, e dunque interagendo con la forma di vita che li esprime.
L’ebraico, la sua lunga esistenza, è anche frutto della decisione di Israele a conservarlo come un tesoro e farlo sempre rivivere; ma Israele, la cultura ebraica, il suo modo sottile di analizzare il mondo, la sua attenzione alle relazioni e alla responsabilità, la sensibilità alle piccole ma decisive ambiguità del reale e delle azioni umane, hanno certamente a che fare con la struttura radicale dell’ebraico, con la sua scrittura consonantica, con l’edificio complesse ed elegante dei “modi” verbali, con l’essenzialità dei suoi tempi/aspetti, con la logica degli schemi vocalici che modificano il senso delle radici, con una certa naturale laconicità densa del suo stile. Voluto e conservato da Israele, l’ebraico lo identifica e lo conserva.
Ugo Volli
