Il ritorno di Dylan. Torah, Midrash e un appuntamento in Italia
 Settanta candeline appena soffiate sulla torta di compleanno non gli hanno fatto passare la voglia di cantare e neanche quella di andare in giro per il mondo con la sua chitarra. Così Bob Dylan in queste ore sta di nuovo preparando le valige e si appresta ad iniziare la sua nuova tournée europea, che lo porterà fra pochi giorni, lunedì 20 giugno, allo stadio di Tel Aviv-Ramat Gan e subito dopo, mercoledì 22, all’Alcatraz di Milano per l’unico appuntamento con il pubblico italiano. E fioriscono ancora nuove iniziative. In questi giorni arriva in libreria una raccolta di testimonianze Play a song for me a cura di Giovanni Cerutti (Interlinea edizioni) con molti testi di ammiratori di Dylan di cui i lettori troveranno alcuni esempi in queste pagine.
Settanta candeline appena soffiate sulla torta di compleanno non gli hanno fatto passare la voglia di cantare e neanche quella di andare in giro per il mondo con la sua chitarra. Così Bob Dylan in queste ore sta di nuovo preparando le valige e si appresta ad iniziare la sua nuova tournée europea, che lo porterà fra pochi giorni, lunedì 20 giugno, allo stadio di Tel Aviv-Ramat Gan e subito dopo, mercoledì 22, all’Alcatraz di Milano per l’unico appuntamento con il pubblico italiano. E fioriscono ancora nuove iniziative. In questi giorni arriva in libreria una raccolta di testimonianze Play a song for me a cura di Giovanni Cerutti (Interlinea edizioni) con molti testi di ammiratori di Dylan di cui i lettori troveranno alcuni esempi in queste pagine.
«Io sono le mie parole» aveva scritto il menestrello – spiega oggi Cerutti – e in occasione dei suoi settant’anni sono qui raccolte le voci di compagni di strada (come Joan Baez, innamorata di «lui e la sua chitarra e le sue splendide, sconnesse, mistiche parole», Allen Ginsberg e Fernanda Pivano) e di chi è cresciuto con le sue canzoni (da Richard Gere a Bob DylanBruce Springsteen, per il quale è stato «il fratello che non ho mai avuto»). Non mancano cantautori come De André e Guccini («Dylan è le nostre idee di allora, le nostre discussioni di politica e di musica»), con una canzone tradotta da Patrizia Valduga e testi di Stefano Benni e Carlo Feltrinelli, senza dimenticare il rapporto di Dylan con Obama, di cui scrive Carrera: «Hey! Mr. Tamburine man, play a song for me!» con una divertente e semisconosciuta finta lettera scritta dallo stesso Dylan alla madre della Baez, riemersa dai cassetti della folksinger.
Nuovi studi continuano anche a decodificare la profonda ispirazione ebraica del grande cantautore americano. “Che ne sia consapevole o meno – spiega Seth Rogovoy, critico musicale e autore di Bob Dylan, Prophet, Mystic, Poet – Bob Dylan, profeta, mistico, poeta (Scribner, New York) – l’uso che fa Dylan dei modelli del discorso profetico ebraico come uno dei suoi mezzi di comunicazione primari non determina solo il contenuto delle sue canzoni, ma anche lo stile espressivo, che è molto più vicino a una declamazione che a una melodia”. “Attraverso la sua carriera – continua – che abbia Bob Dylanparlato dell’ingiustizia sociale in Blowin’ in the Wind e Hurricane, delle ansietà della Guerra fredda in A Hard Rain is Gonna Fall e Masters of the War, dell’accoglienza dei veterani rientrati dal Vietnam in Clean-Cut Kid o dei politici corrotti in Political World e in Disease of Conceit, Dylan non ha fatto altro che tornare alla tradizione profetica per infondere nelle sue canzoni una misura di impatto e di dignità che con molta evidenza distacca la sua opera da quella di tutti gli altri suoi colleghi dell’era del rock. Bono, la voce del gruppo irlandese degli U2, lui stesso fortemente ispirato da una vena di cristianità intensamente legata alle origini ebraiche, riconosce che Dylan ‘è sempre stato un critico della modernità, perché in fondo lui viene da un luogo antico’”.
“Una delle maniere più soddisfacenti di accostarsi alle liriche di Dylan – prosegue Rogovoy – è quello di leggerle come il lavoro di una mente poetica immersa nei testi ebraici e impegnata nel processo di costruzione del Midrash, un genere di elaborazione formale o informale dei Testi che è utile a chiarire o elaborare il loro messaggio recondito. Forse uno degli esempi migliori in questo senso lo troviamo in una delle composizioni di Dylan più note: Highway 61 Revisited, la sua personale reinterpretazione della Akeidah, il sacrificio di Isacco. La statale 61 è la principale via di comunicazione fra New Orleans e Duluth in Bob DylanMinnesota, il luogo natale di Dylan. L’uomo da cui il cantate era nato portava il nome di Abram”. Ma gli esempi sono molto numerosi. Quando nel 1982 suo figlio Samuel raggiunse l’età della maggiorità religiosa e festeggiò il Bar Mitzvah a Gerusalemme, poco dopo questo viaggio nacque una composizione ispirata a una dura linea sionistica. L’album Infidels mostra una copertina con Dylan protetto dagli occhiali scuri sotto la luce brillante di Gerusalemme e all’interno lo stesso cantante che guarda verso le mura della Città vecchia. Fra le varie canzoni, la celebre Neighbourhood Bully sostiene apertamente le ragioni dello Stato di Israele nei confronti delle aggressioni dei vicini (“Lo sovrastano un milione contro uno / non ha dove mettersi in salvo, nessuna via per fuggire”) e in questa forte identificazione nazionale con il popolo ebraico non mette in questione la sua dichiarata appartenenza alla sinistra, ma non non si lascia mettere in imbarazzo nemmeno dagli esiti tragici della prima guerra del Libano, dei massacri nei campi di Sabra e Chatila. Dopo una lunga crisi, alla fine degli anni ‘80, Dylan fa un grande ritorno sulla scena con uno degli album più forti di tutta la sua carriera: Oh Mercy, che riflette una riflessione ben radicata nella visione ebraica della vita. Da questa svolta prende il via il cosiddetto Never Ending Tour che lo avrebbe portato senza più interruzioni a tenere un centinaio di apparizioni pubbliche ogni anno. Con Everything is broken traspare una lettura cabalistica del mondo che ha bisogno di riparazione. Political Word trasmette una vivida descrizione del Kiddush Hashem, il martirio religiosamente ispirato che affrontarono coloro che morirono ad Auschwitz proprio negli anni in cui Dylan era venuto alla luce. Quando Dylan accetta il prestigioso Lifetime Achievement Award ai Grammy Awards del 1991 presenta nel suo discorso di accettazione una parafrasi del Salmo 27 ispirata agli insegnamenti di un grande maestro dell’ebraismo tedesco del diciannovesimo secolo, Samson Raphael Hirsch.
“Dylan – aggiunge Rogovoy – ha continuato a a trovare ispirazione nelle Scritture ebraiche fino ai tempi più recenti. Il suo Time Out of Mind (1997) è un catalogo di riflessioni sulla morte dove riappaiono molti temi contenuti nel Pirké Avot (le Massime dei padri) e nel Cantico dei cantici del re Shlomo. ‘Sono malato d’amore’ è il pianto di un uomo invecchiato che si confronta con la gente solo salendo sulla scena per uno dei suoi concerti del Never Ending Tour. Oggi molti attendono di incontrarlo in una sinagoga, quando l’avvicinarsi dello Yom Kippur lo fa sostare nella sua eterna peregrinazione artistica lontano da casa. E molti, sfiorandolo durante la preghiera, hanno forse immaginato, al momento di invocare l’iscrizione nel Libro della vita, di sentire fra le tante voci anche quella che scandisce Tryin’ to Get to Heaven. Una preghiera fin qui esaudita con una carriera straordinaria e milioni di ascoltatori commossi e ispirati. Ora, continua a cantare Dylan. puoi chiudere il libro e smettere di scrivere. Ho attraversato la valle della solitudine cercando di giungere al Cielo prima che si chiudessero le porte”.
g.v.
Menestrello dell’inquietudine umana
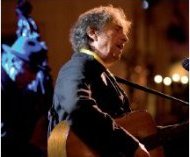 In uno scritto pubblicato nel 1998, Alessandro Pizzorno mette in evidenza come la pervasività dei media nelle società contemporanee abbia finito per configurarli come vere e proprie istituzioni dotate dell’autorità di assegnare riconoscimenti pubblici senza tenere conto delle tradizionali sfere di competenza. In conseguenza di ciò si strutturano due sfere all’interno delle quali viene definita la percezione della qualità di opere e persone: una composta dal gruppo dei pari, in grado di valutare tecnicamente le competenze, l’altra, sempre più prevalente, dove predomina una forma di riconoscimento indifferenziato. In questa seconda sfera, l’immagine di Bob Dylan ha attraversato fasi diverse, in cui si sono alternati momenti nei quali ha occupato il centro della scena ad altri nei quali la sua figura è stata considerata decisamente marginale. Ma tra chi a diverso titolo fa parte della prima sfera, la rilevanza del suo lavoro è sempre stata un punto di riferimento preciso. E non solo, come sembra più naturale, tra chi scrive canzoni o del mondo della canzone si occupa, ma anche tra chi frequenta altre forme espressive e, più in generale, si confronta con la condizione umana nelle sue diverse dimensioni. L’insieme delle sue canzoni ci restituisce una visione del mondo precisa e potente, nella quale sono descritte con rara profondità le inquietudini dell’uomo contemporaneo, la sua difficoltà di stabilire un rapporto autentico con se stesso e con il mondo che lo circonda. Che canti dei rivolgimenti epocali dei tempi che stanno cambiando, o che prenda coscienza che le risposte sono inafferrabili, che indaghi con dolore infinito il mistero di una relazione che finisce, o che evochi con incanto una donna con la bocca di mercurio, che contempli dalla torre di vedetta il vano affaccendarsi del mondo, o che concluda rabbioso e impotente che viviamo in un mondo dove il coraggio non trova più cittadinanza, che danzi al ritornello di un usignolo o che cerchi l’essenza dei tempi moderni, siamo ogni volta trasportati in luoghi cruciali della nostra esperienza, dove ci vengono mostrati punti di vista inediti di quello che siamo diventati e di quello che saremmo potuti diventare.
In uno scritto pubblicato nel 1998, Alessandro Pizzorno mette in evidenza come la pervasività dei media nelle società contemporanee abbia finito per configurarli come vere e proprie istituzioni dotate dell’autorità di assegnare riconoscimenti pubblici senza tenere conto delle tradizionali sfere di competenza. In conseguenza di ciò si strutturano due sfere all’interno delle quali viene definita la percezione della qualità di opere e persone: una composta dal gruppo dei pari, in grado di valutare tecnicamente le competenze, l’altra, sempre più prevalente, dove predomina una forma di riconoscimento indifferenziato. In questa seconda sfera, l’immagine di Bob Dylan ha attraversato fasi diverse, in cui si sono alternati momenti nei quali ha occupato il centro della scena ad altri nei quali la sua figura è stata considerata decisamente marginale. Ma tra chi a diverso titolo fa parte della prima sfera, la rilevanza del suo lavoro è sempre stata un punto di riferimento preciso. E non solo, come sembra più naturale, tra chi scrive canzoni o del mondo della canzone si occupa, ma anche tra chi frequenta altre forme espressive e, più in generale, si confronta con la condizione umana nelle sue diverse dimensioni. L’insieme delle sue canzoni ci restituisce una visione del mondo precisa e potente, nella quale sono descritte con rara profondità le inquietudini dell’uomo contemporaneo, la sua difficoltà di stabilire un rapporto autentico con se stesso e con il mondo che lo circonda. Che canti dei rivolgimenti epocali dei tempi che stanno cambiando, o che prenda coscienza che le risposte sono inafferrabili, che indaghi con dolore infinito il mistero di una relazione che finisce, o che evochi con incanto una donna con la bocca di mercurio, che contempli dalla torre di vedetta il vano affaccendarsi del mondo, o che concluda rabbioso e impotente che viviamo in un mondo dove il coraggio non trova più cittadinanza, che danzi al ritornello di un usignolo o che cerchi l’essenza dei tempi moderni, siamo ogni volta trasportati in luoghi cruciali della nostra esperienza, dove ci vengono mostrati punti di vista inediti di quello che siamo diventati e di quello che saremmo potuti diventare.
L’assoluta fedeltà alla forma canzone, l’amore profondo per la musica e per la tradizione attraverso la quale ha viaggiato nel tempo sono forse la chiave per cercare di spiegare questa capacità così penetrante. Nel piccolo mondo disegnato dall’equilibrio ricreato ogni volta tra parole, musica e canto – performing artist innanzitutto, secondo una fortunata e centrata definizione – Dylan è riuscito a trovare quanto bastava per catturare quanto aveva da dire, senza cercare altre forme espressive dalla tradizione più autorevole e senza sentirsi subalterno a esse.
Gli scritti qui raccolti danno conto del rispetto e dell’amore che ha sempre circondato il lavoro di Dylan tra chi ha incrociato la sua strada condividendone tratti di vita o sviluppando la propria avventura artistica. Ognuno ci riconsegna aspetti diversi della sua personalità e dell’influenza che ha esercitato, ma tutti sono accomunati dalla consapevolezza di essere venuti in contatto con un luogo cruciale della cultura del nostro tempo, una cultura profondamente radicata nell’esperienza umana.
Giovanni Cerutti
Bringing It All Back
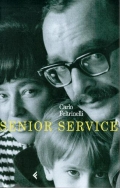 Nasco da genitori con poco orecchio per la musica. Ma se per la madre il ballo è l’occasione preferita, per il padre c’è sempre il fatto della canzone popolare, la Resistenza, i curdi, i guatemaltechi, i messicani… Così, non lontano dal camino, al quarto piano di via Andegari, un giradischi di ottima marca tedesca, squadrato ed essenzialmente elegante, fa la sua bella figura. E ci sono le coste sottili dei dischi allineati: un po’ di classica, molta moderna. Intendo dire, i dischi del Sole, curdi, guatemaltechi e messicani e, certo, le antologie della Folkway Records, della Columbia Library, Cisco, Leadbelly, Big Bill Broonzy… Ma anche After Math, Françoise Hardy, Sgt. Pepper’s, Coltrane, Jannacci, i Rockets, Lotte Lenya canta Brecht, Bringing It All Back Home, Mina. Popular music, insomma, per tutti i gusti e di tutti i generi. Ho stabilito con precisione che, insieme agli inni degli spartachisti, era Sgt. Pepper’s il disco favorito di mio padre, quello con il collage delle facce in copertina. A me, invece, incuriosisce la copertina di Bringing It All Back Home. Lo scopro quando sono già fuori dalla storia del bambino. E non voglio parlare delle canzoni, per la prima volta “elettriche”, ma proprio della copertina. Intanto, la copia scovata nello scaffale porta una dedica misteriosa, con l’inchiostro blu in alto a destra: «Für Giangiacomo, von Manuela». E anche una data: «16.3.66».
Nasco da genitori con poco orecchio per la musica. Ma se per la madre il ballo è l’occasione preferita, per il padre c’è sempre il fatto della canzone popolare, la Resistenza, i curdi, i guatemaltechi, i messicani… Così, non lontano dal camino, al quarto piano di via Andegari, un giradischi di ottima marca tedesca, squadrato ed essenzialmente elegante, fa la sua bella figura. E ci sono le coste sottili dei dischi allineati: un po’ di classica, molta moderna. Intendo dire, i dischi del Sole, curdi, guatemaltechi e messicani e, certo, le antologie della Folkway Records, della Columbia Library, Cisco, Leadbelly, Big Bill Broonzy… Ma anche After Math, Françoise Hardy, Sgt. Pepper’s, Coltrane, Jannacci, i Rockets, Lotte Lenya canta Brecht, Bringing It All Back Home, Mina. Popular music, insomma, per tutti i gusti e di tutti i generi. Ho stabilito con precisione che, insieme agli inni degli spartachisti, era Sgt. Pepper’s il disco favorito di mio padre, quello con il collage delle facce in copertina. A me, invece, incuriosisce la copertina di Bringing It All Back Home. Lo scopro quando sono già fuori dalla storia del bambino. E non voglio parlare delle canzoni, per la prima volta “elettriche”, ma proprio della copertina. Intanto, la copia scovata nello scaffale porta una dedica misteriosa, con l’inchiostro blu in alto a destra: «Für Giangiacomo, von Manuela». E anche una data: «16.3.66».
Quanto alla foto al centro dell’album, è meglio dire come la descrive Robert Shelton: «La fotografia è di Daniel Kramer, scattata attraverso un obiettivo ad effetto: un vero saggio di simboli. Dylan accarezza il suo gatto Rolling Stone. Dietro di lui si vedono gli album di Von Schmidt, Lotte Lenya, Robert Johnson. C’è poi l’indicazione di un rifugio atomico, una copia del Time, un ritratto dell’Ottocento. A sinistra sul caminetto si vede The Clown, un collage di vetro che Bob aveva fatto per Bernard Paturel, utilizzando pezzetti di vetro colorato che Bernard stava buttando via».
Con ogni probabilità, il “saggio di simboli” è una creazione del tutto involontaria, così come è frutto di pura suggestione pensare ciò che pensai, e continuo a pensare, della fotografia di Bringing It All Back Home: quella foto l’hanno scattata in casa nostra, proprio nella stanza in cui ci si siede per parlare, vicino al giradischi, riconosco tutto! Quando Manuela (?) regala il disco a mio padre, il 16 marzo 1966, lui forse lo ascolta – un regalo di Manuela si ascolta almeno una volta – e intorno non manca nulla: ci sono camino, Time, sofà, rifugio atomico, disco, ritratto, Ottocento (ma anche Quattrocento), collage, pezzi di vetro, “elettricità”… Ancora oggi si può fare il confronto: sono passati trent’anni e il camino è ancora al suo posto, abbastanza uguale, qualche libro in più e qualche simbolo in meno.
Carlo Feltrinelli, da Senior Service (Feltrinelli, 436 pp.)
Quell’estro difficile da tradurre in italiano
 Comporre in lingua italiana è difficile proprio tecnicamente. Se devi scrivere in metrica hai bisogno di una grande quantità, per esempio, di parole tronche che in italiano non ci sono. A questo punto ti succede, proprio per la necessaria avvenenza estetica del verso, di cambiare talvolta addirittura il significato di ciò che vuoi dire. Il genovese invece è una lingua più agile, puoi trovare un sinonimo tronco che abbia lo stesso significato dello scritto in prosa che tu hai fatto precedentemente al verso (si scrive in prosa perché difficilmente ti viene l’idea in metrica e poi cerchi di adattarla al contesto ritmico). Questa è la differenza fondamentale. Ma non soltanto il genovese, anche il francese ha molte parole tronche e l’inglese non ne parliamo. Per questo è agevolissimo scrivere in inglese (naturalmente per chi lo conosce). Dylan in italiano sarebbe stato lo stesso Dylan, però penso che le sonorità non sarebbero state altrettanto eccellenti. Cioè, l’amalgama fonema e musica non sarebbe stato identico.
Comporre in lingua italiana è difficile proprio tecnicamente. Se devi scrivere in metrica hai bisogno di una grande quantità, per esempio, di parole tronche che in italiano non ci sono. A questo punto ti succede, proprio per la necessaria avvenenza estetica del verso, di cambiare talvolta addirittura il significato di ciò che vuoi dire. Il genovese invece è una lingua più agile, puoi trovare un sinonimo tronco che abbia lo stesso significato dello scritto in prosa che tu hai fatto precedentemente al verso (si scrive in prosa perché difficilmente ti viene l’idea in metrica e poi cerchi di adattarla al contesto ritmico). Questa è la differenza fondamentale. Ma non soltanto il genovese, anche il francese ha molte parole tronche e l’inglese non ne parliamo. Per questo è agevolissimo scrivere in inglese (naturalmente per chi lo conosce). Dylan in italiano sarebbe stato lo stesso Dylan, però penso che le sonorità non sarebbero state altrettanto eccellenti. Cioè, l’amalgama fonema e musica non sarebbe stato identico.
Sicuramente tante cose scritte in rima che suonano talmente bene in Dylan non avrebbero potuto o per conservare la rima e quindi l’eleganza fonetica avrebbe dovuto cambiare diversi significati e sarebbe stato un grosso dramma. Dylan è bello così com’è. Ora questa è un’ipotesi assurda, però penso che in italiano gli sarebbe stato più difficile esprimersi. Forse avrebbe trovato un’altra forma di espressione, la prosa magari, o la poesia senza musica o la declamazione con la musica in sottofondo.
Fabrizio De André, “Passaggi di tempo da Carlo Martello a Princesa” di Doriano Fasoli (Coniglio editore, 346 pp.)
