Memoria
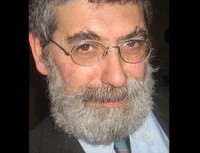 Sono convinto che la memoria non sia un minuto di silenzio. Perciò provo a raccogliere il richiamo di Anna Foa sulla necessità di “costruire un piccolo tassello di un pensiero”.
Sono convinto che la memoria non sia un minuto di silenzio. Perciò provo a raccogliere il richiamo di Anna Foa sulla necessità di “costruire un piccolo tassello di un pensiero”.
Non so cosa accadrà il 27 gennaio in occasione del prossimo giorno della memoria. Ma dopo l’ultima settimana di fatti italiani credo che si debbano almeno osservare tre cose che con quella vicenda hanno una relazione e che, forse, ci consentono di riflettere anche su un possibile contenuto di un percorso che ci accompagni verso quell’appuntamento.
1. Il razzismo in Italia non è un vago ricordo del passato.
2. Non abbiamo una cultura (non dico una retorica, quella ne abbiamo senza timore di esaurimento scorte) dell’antirazzismo;
3. Il razzismo in Italia è destinato a crescere.
E’ importante, tuttavia, che si abbia ben chiaro di che cosa stiamo parlando, altrimenti, le parole avranno ragione della capacità di riflettere sulla realtà concreta che abbiamo davanti.
In Italia non è in atto, né mi pare si possa sostenere che in un tempo breve – medio, si produrrà una legislazione razziale fondata sul concetto di sangue. Dunque quando parliamo di razzismo non parliamo di scene che hanno caratterizzato l’Italia dal 1938, la Germania dal 1933, una gran parte del continente europeo tra 1940 e 1945 durante il cosiddetto “Nuovo Ordine Europeo”. Dunque non parliamo di campi di sterminio, di “viaggi della morte”, di selezione.
Ma l’esperienza e la pratica razziste non sono solo ed esclusivamente scene legate e conseguenti a quelle pratiche.
Perché si diffonda una cultura razzista e xenofoba, occorrono altre cose, per certi aspetti meno impegnative di una legislazione razziale così come l’abbiamo conosciuta negli anni ’30 e ’40 del Novecento.
Provo ad elencarne alcune:
• un tasso di disoccupazione consistente;
• una condizione economica di recessione;
• la convinzione di aver avuto un passato di successo cui ha fatto seguito una crisi sociale diffusa;
• un ceto medio frustrato;
• una provincia lontana dalla capitale che ha la convinzione di essere sfruttata da una classe di signori fannulloni;
• una generazione di 20-30enni che sempre più arrabbiata;
• un’opinione pubblica che crede che la classe politica sia una casta, preoccupata solo di fare i fatti propri, comunque convinta che al governo ci siano esponenti che non difendono gli intessi nazionali;
• L’immagine diffusa che il proprio paese sia diventato il paese di tutti gli stranieri, ma non degli “indigeni” e dunque abbia perso la propria identità;
• il timore che vadano al potere dei tecnocrati che non abbiamo nessun vincolo con “il popolo” e dunque al servizio degli interessi stranieri;
• la diffusione di movimenti politici regionalistici autoritari che coltivano una identità locale e che hanno un’idea della comunità come corpo coeso e compatto, privo di conflitti interni;
• La presenza e la circolazione di un linguaggio, politico, sociale, culturale e valoriale antisistema vicendevolmente scambiabile tra destra e sinistra cui una delle categorie fondamentali è una teoria complottistica della storia;
• I tentativi reiterati delle piazze e delle folle di assalire il Parlamento.
Tutti questi tratti (ma molti altri ne potrei indicare) non appartenevano né all’Italia degli ’30, né alla Germania degli anni ’30. Appartenevano alla Francia degli anni ’30. Un paese che in quegli anni viveva in un regime democratico, in cui i partiti politici erano legali, non c’era una legislazione razziale in atto, la libertà di sciopero non era minacciata, tutti andavano in vacanza e i ristoranti erano pieni. Ma dentro, nel profondo, quella società viveva una crisi strutturale.
Il Governo di Vichy non fu solo l’effetto di una sconfitta militare ma anche, e forse soprattutto, il risultato di una crisi sociale, politica e culturale. E le politiche discriminative, corporative, autoritarie, compreso l’antisemitismo, che adottò discendevano da quella condizione, ma anche da un cultura profonda, non detta, non affrontata che discendeva dall’antidemocrazia della prima metà dell’Ottocento che aveva sempre vissuto come un’offesa la Rivoluzione francese e le sue conquiste politiche e civili.
A me non sembra che i malesseri emersi queste settimane siano così diversi da quel lungo elenco e da quel groviglio di sentimenti
Dunque possiamo risparmiarci la retorica del pericolo nazista (dove tutti faranno a gare per dichiarare la propria estraneità) e invece riflettere con più attenzione su come una società vive, reagisce e si mobilita in una condizione di crisi.
E domandarci, se, in occasione del prossimo 27 gennaio, non sia il caso di capire che cosa significhi la cultura dell’indifferenza rispetto alle condizioni sociali di chi ci è prossimo, come quella della difesa ossessiva della differenza di sé.
David Bidussa, storico sociale delle idee
