La pace impossibile
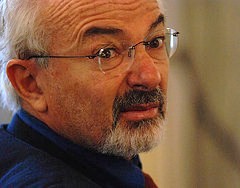 Coloro che criticano Israele – o magari le sue politiche o il suo governo, che poi sono la stessa cosa del popolo, dato che il sistema è democratico, come ha notato qualcuno, e visto che tutti i governi degli ultimi 64 anni sono stati criticati più o meno allo stesso modo – coloro che criticano Israele dentro e fuori del mondo ebraico gli rimproverano soprattutto di non fare la pace con gli arabi. Pochi, solo gli antisemiti più accesi a destra e a sinistra, hanno oggi il coraggio di dire che il popolo ebraico dovrebbe sparire o che esso non abbia diritto a uno Stato. La prima affermazione è stata di moda per secoli, con varianti più o meno sanguinose l’hanno condivisa decine di papi e di santi prima di Hitler e personaggi di grande prestigio come Marx e Voltaire, Kant e Feuerbach. La seconda è un principio universale nel mondo arabo, accennato in qualche documento ecclesiastico, ma raramente reso esplicito oggi in Occidente. Entrambe sono passate di moda, uscite dalla grammatica eufemistica del discorso pubblico occidentale. Dunque, Israele non ha colpa di esistere, ma di non fare la pace, e di qui le colpe accessorie che gli vengono attribuite, dall’ ”uso sproporzionato della forza” difensiva (come se la guerra fosse uno sport equestre con l’handicap) alle “atrocità” contro i “bambini di Gaza” e altre sciocchezze del genere.
Coloro che criticano Israele – o magari le sue politiche o il suo governo, che poi sono la stessa cosa del popolo, dato che il sistema è democratico, come ha notato qualcuno, e visto che tutti i governi degli ultimi 64 anni sono stati criticati più o meno allo stesso modo – coloro che criticano Israele dentro e fuori del mondo ebraico gli rimproverano soprattutto di non fare la pace con gli arabi. Pochi, solo gli antisemiti più accesi a destra e a sinistra, hanno oggi il coraggio di dire che il popolo ebraico dovrebbe sparire o che esso non abbia diritto a uno Stato. La prima affermazione è stata di moda per secoli, con varianti più o meno sanguinose l’hanno condivisa decine di papi e di santi prima di Hitler e personaggi di grande prestigio come Marx e Voltaire, Kant e Feuerbach. La seconda è un principio universale nel mondo arabo, accennato in qualche documento ecclesiastico, ma raramente reso esplicito oggi in Occidente. Entrambe sono passate di moda, uscite dalla grammatica eufemistica del discorso pubblico occidentale. Dunque, Israele non ha colpa di esistere, ma di non fare la pace, e di qui le colpe accessorie che gli vengono attribuite, dall’ ”uso sproporzionato della forza” difensiva (come se la guerra fosse uno sport equestre con l’handicap) alle “atrocità” contro i “bambini di Gaza” e altre sciocchezze del genere.
Il problema vero è dunque: è possibile la pace? Chi la vuol fare e chi no? E’ realizzabile non in astratto, ma concretamente qui, nel mondo imperfetto che condividiamo una pace fra Israele e gli arabi che lo circondano? E’ stata possibile nei vent’anni passati dalle illusioni di Oslo, è possibile ora? Io ne dubito da tempo. Ho visto tregue più o meno fredde, utili comunque, ma mai pace vera, come quella che si è fatta in Europa dopo la Seconda guerra mondiale. Ma di recente ho avuto una controprova interessante: ho partecipato a un incontro collettivo con uno sceicco palestinese, un esponente di primo piano del vecchio sistema tribale soppiantato dall’Olp quando proprio a Oslo l’organizzazione terrorista (allora si sperava a torto: ex-terrorista) fu riconosciuta come “unico rappresentante del popolo palestinese”. Comprensibilmente il capo tribù, presentatosi a noi come un possibile nuovo interlocutore di pace, non era tenero con Oslo, lo presentava come un disastro da superare.
Interessanti sono i suoi argomenti: ogni compromesso territoriale, diceva, è insensato. Perché l’Islam proibisce di cedere un solo centimetro del terreno che gli appartiene, e – secondo lui – l’ebraismo ragiona alla stessa maniera. La prima affermazione è degna di nota, non solo perché è la ripetizione testuale di uno slogan di Hamas ed è confermato da una legge dell’Autorità Palestinese che considera crimine capitale la vendita di terra agli ebrei, ma anche perché si estende oltre Israele, per esempio alla nostra Sicilia, ai Balcani e alla Spagna, dove già qualche iniziativa revanscista negli ultimi anni si è manifestata. La seconda è palesemente falsa, perché tutta la storia di Israele e del sionismo mostra una disponibilità ai compromessi territoriali. La soluzione che lo sceicco proponeva per uscire da questo vicolo cieco della doppia rivendicazione territoriale non è particolarmente originale: uno Stato condiviso “che non sarebbe né vostro né nostro finché non arriverà il Messia a risolvere la questione”. Naturalmente il problema è che non ci sono Stati che non corrispondano a un popolo e dunque la questione diventa demografica: che popolo avrebbe la maggioranza in questa sistemazione?
E qui vien fuori un punto delicato, che è quello del carattere nazionale di Israele. Il senso dell’esperienza storica del popolo ebraico, così come è stato sintetizzato dal sionismo nell’ultimo secolo, è che il solo modo per sfuggire alle persecuzioni e vivere dignitosamente è avere un proprio Stato nazionale, in cui essere ben più che maggioritario. Questa è stata la scelta non solo di grandi profeti e statisti come Herzl e Ben Gurion, ma anche della grande maggioranza del popolo che ha partecipato o almeno sostenuto questa strada e della comunità internazionale che l’ha sostenuto a partire dalla Dichiarazione Balfour e dal Trattato di San Remo fino alla risoluzione dell’Onu del ’47. Può Israele rinunciare alla sua caratteristica di Stato nazionale senza vanificare questa strada e produrre nel popolo ebraico la più grave crisi di identità dopo la caduta del Tempio, duemila anni fa? Evidentemente no, nonostante sia in atto una campagna crescente da parte di settori detti “postsionisti” della politica israeliana molto isolati nel paese, ma ben connessi all’estero: per esempio Haaretz si è espressa per una riforma della “legge del ritorno” e ha iniziato una campagna contro l’inno nazionale “Hatikvà”, per sostituirlo con qualcosa che possa andar bene a tutti gli aspiranti comproprietari del territorio – chissà, qualcosa che parli del cielo e del mare, delle palme e dei falafel. E però questa prospettiva è inaccettabile non solo per gli israeliani, ma anche per il popolo ebraico della diaspora, che sa di aver bisogno di un’Israele ebraica, se non altro come assicurazione sulla vita nei confronti delle minacce crescenti che si trova ad affrontare.
Per questo motivo con forza crescente Netanyahu ha posto sul tavolo della trattativa, come controparte per le concessioni territoriali che potranno essere necessarie, la questione del riconoscimento di Israele come Stato nazionale ebraico, cosa che i palestinesi coerentemente rifiutano: l’Autorità Palestinese, Hamas, nel suo piccolo anche lo sceicco con cui ho parlato: non un centimetro quadrato per uno Stato ebraico sulla terra dell’Islam.
Questa è la ragione per cui la pace non è possibile. La maggior parte degli arabi vorrebbero cacciare gli ebrei in mare, se non peggio. Quelli che non lo vogliono o capiscono di non poterci riuscire, sono disposti a sopportare, più o meno provvisoriamente e limitatamente, la presenza ebraica “fra il fiume e il mare”, ma solo a patto di non doverla accettare che come una parentesi e senza cedere la rivendicazione islamica sul territorio dello Stato. Fuori da ogni intento propagandistico, il minimo che il popolo ebraico vuole – uno Stato ebraico in quelle terre, comunque esteso – è ben di più di quel che i più pacifici degli arabi sono disposti a concedere (una qualche forma di convivenza in uno Stato non ebraico). Il conflitto resta anche se si ignorano gli aspetti emotivi della disputa, che pure sono forti: il nostro sceicco definiva le città dell’Israele moderno (Tel Aviv, Haifa ecc) degli “stupri” e sinceramente e accoratamente (ma senza alcun senso storico) sosteneva che il terrorismo palestinese, che pure gli sembrava “improduttivo”, fosse una risposta all’attacco alla Tomba dei patriarchi.
La pace, quella vera, con il riconoscimento reciproco di confini, identità e diritti non si può fare e le “colonie” non c’entrano niente: per noi, ci ha detto il capotribù, sempre vicino alle dichiarazioni di Hamas e alle pratiche dell’Autorità Palestinese se non alle sue dichiarazioni ipocrite, non c’è alcuna differenza fra Haifa dentro la linea verde e Ariel fuori di essa, fra Gerusalemme Est e Ovest. La sola speranza è di una convivenza abbastanza tranquilla sul territorio, della crescita economica e del contenimento militare della violenza: la politica degli ultimi governi, che sta dando i suoi frutti. Se non sarà distrutta dagli interventi (non solo dell’Iran ecc. ma anche europei, di Obama, “pacifisti” ecc.) che quando possono attizzano i palestinesi, cercando di destabilizzare la situazione e giocando così col fuoco di una nuova guerra possibile, questa è la sola possibilità di convivenza.
Ugo Volli
