Yoram Kaniuk “Così è nato Israele”
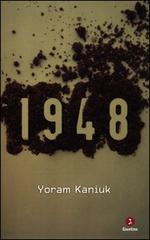 Esce oggi nelle librerie italiane, grazie alla casa editrice Giuntina che ne ha curato la traduzione, l’ultimo attesissimo romanzo dello scrittore israeliano Yoram Kaniuk (ritratto da Giorgio Albertini in basso): 1948 (in ebraico Tashach-5708). Fresco vincitore del Sapir Prize for Literature, il volume si addentra con magistrale poesia nelle vicende, spesso colme di sangue e dolore, che portarono alla nascita dello Stato di Israele.
Esce oggi nelle librerie italiane, grazie alla casa editrice Giuntina che ne ha curato la traduzione, l’ultimo attesissimo romanzo dello scrittore israeliano Yoram Kaniuk (ritratto da Giorgio Albertini in basso): 1948 (in ebraico Tashach-5708). Fresco vincitore del Sapir Prize for Literature, il volume si addentra con magistrale poesia nelle vicende, spesso colme di sangue e dolore, che portarono alla nascita dello Stato di Israele.
Il suo esordio italiano risale a quasi vent’anni fa. Quando Adamo risorto, pubblicato un po’ in sordina da Theoria, folgorò i lettori con quelle pagine superbe e faticose che narrano, in un avveniristico ospedale nel cuore del Negev, ad Arad, la storia dell’uomo che i nazisti avevano trasformato in cane. Da allora i libri di Yoram Kaniuk – Post mortem, Tigerhill, Il comandante dell’Exodus, La ragazza scomparsa – hanno conquistato un loro pubblico appassionato e fedele. Senza però mai sedurre le classifiche di vendita che in questi anni hanno dimostrato di apprezzare molto gli autori israeliani: forse per la sua complessità narrativa o forse perché il personaggio è senz’altro scomodo, anticonformista, impossibile da rinchiudere in canoni o stereotipi preconfezionati. Tradotto ormai in 25 lingue, Kaniuk in Israele è considerato invece una vera e propria icona. Assai popolare e sempre presente nel dibattito pubblico, è noto per le sue prese di posizione coraggiose e spesso fuori del coro: una fama ribadita dalla recente vicenda che a ottobre l’ha visto alla ribalta delle cronache per la battaglia che l’ha portato in tribunale ad affermare il suo diritto a non definirsi ebreo nei documenti d’identità. Mossa radicale ed eclatante che l’ha proiettato sulle pagine di tutti i giornali internazionali. Anche se lui, sommesso, afferma di avere ottenuto la vittoria “solo perché i giudici probabilmente non avevano capito bene cosa stavano facendo”. Tanto che “sono stato il primo e con ogni probabilità sarò l’ultimo a poter cancellare l’appartenenza alla religione di Stato”.
 Il suo ultimo romanzo, 1948, in ebraico Tashach-5708, che lo scorso anno ha ottenuto il prestigioso Sapir Prize for Literature e che Giuntina manda ora in libreria nella traduzione di Elena Loewenthal, s’inserisce a perfezione in questo quadro. In meno di duecento pagine, dense e colme di poesia, Kaniuk racconta il conflitto che portò alla nascita dello Stato d’Israele inoltrandosi nel profondo del dolore della guerra. Ne ritrae il sangue, le morti, l’orrore. E decostruisce la retorica che così spesso avvolge il mito della fondazione denunciando, senza mezzi termini, la deriva che oggi attraversa taluni settori della società israeliana. Un libro stupefacente, capace di avvincere il lettore come un thriller, scritto da chi, allora soldato adolescente (“Avevo diciassette anni e mezzo, ero un bravo ragazzo di Tel Aviv finito in mezzo a un bagno di sangue”), si ritrovò quasi per caso a fondare una Nazione e a mutare lesorti del popolo ebraico. Un libro che lo stesso Kaniuk, raggiunto al telefono nella sua casa israeliana, considera il suo testamento spirituale.
Il suo ultimo romanzo, 1948, in ebraico Tashach-5708, che lo scorso anno ha ottenuto il prestigioso Sapir Prize for Literature e che Giuntina manda ora in libreria nella traduzione di Elena Loewenthal, s’inserisce a perfezione in questo quadro. In meno di duecento pagine, dense e colme di poesia, Kaniuk racconta il conflitto che portò alla nascita dello Stato d’Israele inoltrandosi nel profondo del dolore della guerra. Ne ritrae il sangue, le morti, l’orrore. E decostruisce la retorica che così spesso avvolge il mito della fondazione denunciando, senza mezzi termini, la deriva che oggi attraversa taluni settori della società israeliana. Un libro stupefacente, capace di avvincere il lettore come un thriller, scritto da chi, allora soldato adolescente (“Avevo diciassette anni e mezzo, ero un bravo ragazzo di Tel Aviv finito in mezzo a un bagno di sangue”), si ritrovò quasi per caso a fondare una Nazione e a mutare lesorti del popolo ebraico. Un libro che lo stesso Kaniuk, raggiunto al telefono nella sua casa israeliana, considera il suo testamento spirituale.
Perché la scelta di scrivere ora questo romanzo?
Ci sono voluti quasi sessant’anni. Ci avevo provato già nel 1959, quando lavoravo come marinaio sulla Pan York, una delle navi che portavano i profughi ebrei dall’Europa in Israele. Ma quel testo, che avevo intitolato Uno degli amici di Benny Marshak, uno dei commilitoni di allora, fu rifiutato da tutti: dicevano che non sapevo scrivere. Da allora ho tentato più volte di raccontare quella storia ma non volevo trattarla come un semplice testo narrativo, sentivo il bisogno di essere anche provocatorio. Poi, qualche anno, mi sono ammalato e mi sono trovato in punto di morte. Quando sono riuscito a venirne fuori ho capito che se non avessi scritto allora non lo avrei fatto mai più.
Com’è stato accolto il libro in Israele?
Le persone qui non sanno più da dove veniamo. Un importante ministro, che preferisco non nominare, mi ha detto di recente di aver capito solo dopo averlo letto quanto sia stato difficile combattere quella guerra, senza riserve e con grande scarsità di armi. Credo di aver toccato l’argomento giusto nel momento giusto.
“Sono vecchio e malato, – scrive – penso al nuovo Stato che ha fondato Ben Gurion, oggi ha sessant’anni, i suoi genitori ormai non ci sono più e gli eredi sono stupidi, idioti, ladri, cattivi, hanno dimenticato da dove sono venuti”. E’ un giudizio duro e senza appello. Qual è il suo pensiero sull’Israele di oggi?
E’ venuto meno quello spirito di comunità che una volta caratterizzava Israele. Il Paese è cambiato nel profondo, il solco tra laici e religiosi e tra destra e sinistra si è approfondito in modo drammatico mentre la situazione politica fa sì che ci troviamo a vivere un’atmosfera di costante tragedia. Eppure sono qui, ci vivo e ci morirò: Israele è il mio Paese.
In 1948 lei parla spesso del peso della Shoah sulla vita dello Stato. E’ ancora così forte?
E’ un trauma silenzioso che persiste, aleggia nell’aria ed è difficile non pensarci con tutto ciò che sta accadendo. Non è possibile dimenticare una tragedia come quella, dovranno scomparire ancora alcune generazioni. La nascita d’Israele si deve in gran parte alla Shoah. La cosa strana è però che allora ne sapevamo molto poco. Fu solo dopo la Guerra d’Indipendenza, quando lavorai sulla nave Pan York, che mi ritrovai davanti a migliaia di sopravvissuti ai campi di sterminio e alle persecuzioni. Fu sconvolgente. Di recente, mentre una sera presentavo il libro a Yafo, sono stato avvicinato da una bella donna di ottant’anni. Mi disse che da anni mi pensava e seguiva il mio lavoro e subito capii chi era. L’avevo incontrata in uno di quei viaggi. Era scampata alla Shoah e cercava riparo in Israele. A bordo le avevo regalato una clementina: ricordo la sua commozione e la delicatezza con cui sbucciò quel frutto, per lei prezioso come un gioiello. Episodi e incontri come questo hanno influito nel profondo sulla mia vita.
Il libro 1948 si apre con una dedica. “Ai miei amici, morti e vivi, della brigata Harel, a Hanoch Kosovsky, prode guerriero, che ama colui che sono e mi disapprova, uomo perbene, assassino come noi tutti. Con profondo affetto per tutti coloro che sono stati in quell’inferno di macello e sì, hanno anche fondato uno Stato”. Subito dopo una citazione da Ezechiele “Passai vicino a te, ti vidi mentre dibattevi nel sangue e ti dissi: vivi nel tuo sangue” (16,6). E in tutto il racconto l’elemento dominante è il sangue. Perché quest’insistenza?
Ho scritto ciò che ho visto e vissuto. Oggi è quasi impossibile immaginare cos’è stata quella guerra. Si combatteva notte e giorno ma nessuno di noi era stato addestrato a questo: fummo costretti a impararlo combattendo. Mancavano le armi e le riserve. Gli amici con cui eri cresciuto e i compagni ti morivano intorno senza tregua. Sono stato ferito alle porte di Gerusalemme, ma sono sopravvissuto. E quel che ho visto allora mi ha lasciato un segno indelebile nell’anima.
“I leader di quella generazione – scrive – si aspettavano che fossimo eroi”. In qualche modo allora vi fu affidato il compito di segnare l’avvio di una nuova storia per il popolo ebraico.
Non eravamo eroi. Eravamo solo ragazzi. Io avevo 17 anni e mezzo e lasciai il liceo per arruolarmi. I miei compagni più vecchi erano appena ventenni. Volevamo dare una casa agli ebrei rifiutati dal resto del mondo e massacrati dalle persecuzioni. Ma la verità è che non pensavamo di fondare uno Stato: combattevamo per sopravvivere.
Nel 2009 lei ha condannato la normativa, votata a maggioranza dalla Knesset, che elimina la parola Nakba dai testi scolastici di storia. Per quale motivo?
Nel 1948 ci sono stati anche degli sconfitti e questo va insegnato ai nostri ragazzi. Non possiamo dimenticare che qui vivevano 700 mila palestinesi: hanno una storia e nessun ministero può imporre loro di cancellare la memoria o impedirgli di chiamare come preferiscono quella guerra terribile.
In che modo le guerre, dal 1948 a oggi, hanno influito sul Paese?
La Shoah ha distrutto le nostre famiglie. Le guerre ci hanno segnato nel profondo. Non è facile vivere nelle nostre condizioni. Oggi giorno leggo sui giornali quanto siamo cattivi e terribili, c’è chi non esita a paragonarci ai nazisti, e ciò fa male. E’ vero, non siamo a posto sotto molti punti di vista. Ma nessuno vuole pensare alla nostra storia: cosa c’è di terribile se anche noi abbiamo uno Stato? E perché ci si sofferma sempre sui torti di Israele e non si pensa a quanto accade in altri paesi? Perché non si denuncia il sanguinoso regime siriano? Perché non si parla di quanto sta accadendo in Egitto? E come si sentirebbero i romani se la loro città vivesse per mesi sotto un bombardamento di missili?
Nella Diaspora il 1948 e la nascita dello Stato d’Israele rimangono ancora oggi un mito fondante. Come pensa possa venire accolta la sua narrazione così spesso dissacrante?
So che negli Stati Uniti il libro è molto atteso. Ma mi è difficile dare risposta a questa domanda. Non scrivo mai pensando ai lettori. L’unica speranza è che riescano a capire quanto è avvenuto.
In 1948 a un certo punto lei cita la città di Trieste. Una memoria dei suoi viaggi a bordo della nave Pan York?
Il mio legame con l’Italia è ancora più antico e profondo. Fu mia madre a passare per Trieste quando, nel 1910, lasciò Odessa per andare in Israele. Allora era una bambina di appena sei o sette anni, ma il ricordo le rimase dentro per tutta la vita.
Sa che allora gli emigranti venivano accolti nell’edificio di via del Monte 7 dove ora c’è il Museo della Comunità ebraica triestina?
Non ne sapevo nulla. Ma se mi manda qualche foto sarò felice di vederlo. Potrei ricambiare con uno dei miei disegni. Sa, sono ormai tanti anni che ho abbandonato la pittura per lo scrivere. Ma mi diverto ancora a pasticciare con pennelli e colori.
Daniela Gross, Pagine Ebraiche, Giugno 2012 – twitter @dgrossmoked
