La prova del DNA
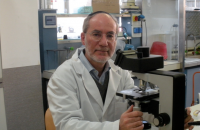 In questi giorni si parla molto del DNA come fonte di prova per identificare il colpevole di un assassinio o di altri crimini. Oltre a queste situazioni di carattere penale ce ne sono altre in cui ci si può chiedere che valore abbia tale prova dal punto di vista della halakhà, la normativa giuridico-religiosa ebraica. La risposta non è univoca, come del resto non lo è neanche per la normativa generale. Dipende per cosa la prova è richiesta e se è affiancata da altri riscontri. Nel mondo ebraico il problema si pose in modo massiccio dopo l’attentato alle Torri Gemelle dell’11 settembre del 2001. Dei molti ebrei che morirono nell’incendio dei grattacieli non c’erano quasi più tracce e l’identificazione dei loro resti risultava impossibile nei modi usuali. Tuttavia, senza una dichiarazione certa di morte, le mogli delle presunte vittime non potevano risposarsi. Si tratta della nota questione delle agunòt, le donne che rimangono “vincolate” perché il marito si rifiuta di concedere il divorzio o perché non si ha testimonianza certa della sua morte. Questo è uno dei più difficili problemi della halakhà, e notevoli facilitazioni vengono messe in atto per arrivare a una soluzione che tuteli la donna. Ad esempio, si accetta come valida anche una testimonianza singola, mentre generalmente sono richiesti due testimoni. Il DNA estratto dai resti di un corpo, se riconducibile in modo pressoché sicuro a quello di una certa persona e se ci sono altri riscontri probatori, è accettato dalle più importanti autorità halakhiche come prova valida per la dichiarazione di morte. L’analisi del DNA viene anche utilizzata per l’identificazione dei resti umani in modo da dargli una degna sepoltura. Uno dei martiri delle Fosse Ardeatine, Marco Moscati z.l., è stato recentemente identificato proprio grazie al suo DNA, così che ora i suoi famigliari possono avere una tomba su cui pregare.
In questi giorni si parla molto del DNA come fonte di prova per identificare il colpevole di un assassinio o di altri crimini. Oltre a queste situazioni di carattere penale ce ne sono altre in cui ci si può chiedere che valore abbia tale prova dal punto di vista della halakhà, la normativa giuridico-religiosa ebraica. La risposta non è univoca, come del resto non lo è neanche per la normativa generale. Dipende per cosa la prova è richiesta e se è affiancata da altri riscontri. Nel mondo ebraico il problema si pose in modo massiccio dopo l’attentato alle Torri Gemelle dell’11 settembre del 2001. Dei molti ebrei che morirono nell’incendio dei grattacieli non c’erano quasi più tracce e l’identificazione dei loro resti risultava impossibile nei modi usuali. Tuttavia, senza una dichiarazione certa di morte, le mogli delle presunte vittime non potevano risposarsi. Si tratta della nota questione delle agunòt, le donne che rimangono “vincolate” perché il marito si rifiuta di concedere il divorzio o perché non si ha testimonianza certa della sua morte. Questo è uno dei più difficili problemi della halakhà, e notevoli facilitazioni vengono messe in atto per arrivare a una soluzione che tuteli la donna. Ad esempio, si accetta come valida anche una testimonianza singola, mentre generalmente sono richiesti due testimoni. Il DNA estratto dai resti di un corpo, se riconducibile in modo pressoché sicuro a quello di una certa persona e se ci sono altri riscontri probatori, è accettato dalle più importanti autorità halakhiche come prova valida per la dichiarazione di morte. L’analisi del DNA viene anche utilizzata per l’identificazione dei resti umani in modo da dargli una degna sepoltura. Uno dei martiri delle Fosse Ardeatine, Marco Moscati z.l., è stato recentemente identificato proprio grazie al suo DNA, così che ora i suoi famigliari possono avere una tomba su cui pregare.
In altri casi, però, la prova del DNA non è valida. Per esempio, il DNA non può essere portato come evidenza per attestare l’illegittimità della prole. Il figlio di un rapporto adulterino o incestuoso (mamzer) si trova in una condizione altrettanto difficile di quella della agunà. In questo caso il DNA non è preso in considerazione. La logica in entrambe le situazioni è in realtà la stessa: la prova del DNA si usa solo per alleviare una condizione, non per inasprirla. La si accetta per evitare la condizione di agunà ma non la si accetta per determinare lo status di mamzer. La fonte per questo approccio si trova nella Mishnà, alla fine del trattato di Eduyot (cap. 8:7, con il commento di Ovadià da Bertinoro, rabbino italiano del ’400-’500), dove si afferma che in futuro (si spera presto), quando il profeta Elia verrà ad annunciare il Messia, avrà fra i suoi compiti anche quello di chiarire lo stato civile delle famiglie. Mentre un’opinione afferma che Elia allontanerà quelle famiglie che con la forza si sono fatte considerare legittime pur non essendolo, un’altra opinione sostiene che il profeta Elia accoglierà coloro che ingiustamente sono stati allontanati, ma non allontanerà chi ormai è entrato a far parte della comunità, se pur con la forza. Le prove, pertanto, si cercano per accogliere, non per allontanare.
La Mishnà di Eduyot termina con il versetto del profeta Malakhì (3:23), che recitiamo al sabato sera e conclude la haftarà del sabato che precede Pesach, lo Shabbat Hagadol: “E farà tornare il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i loro padri”.
Gianfranco Di Segni
Tratto dal limmud organizzato dall’AME (Associazione Medica Ebraica) al Tempio dei Giovani, nell’Ospedale Israelitico dell’Isola Tiberina di Roma, a un mese dalla scomparsa del Dott. Angelo Di Castro, medico ortopedico, mio amico e compagno di classe dai tempi della scuola media. Che il suo ricordo sia di benedizione e di consolazione per chiunque l’abbia conosciuto.
(20 giugno 2014)
