I GRANDI LIBRI DEL 5776 – ‘LA BANCA E IL GHETTO’ Nuova luce su una storia italiana
 L’ultimo lavoro di Giacomo Todeschini, La banca e il ghetto. Una storia italiana, è un libro importante che apre nuove prospettive di interpretazione e ricolloca in una luce nuova la storia degli ebrei italiani tra il XIV e il XVI secolo. Esso pone un nesso molto stretto tra l’affermarsi della banca cristiana in Italia nel XV secolo e la chiusura degli ebrei italiani nei ghetti. Una banca, quella cristiana, che è un’invenzione tutta italiana, il frutto specifico della struttura politica ed economica delle città e degli Stati italiani fra Due e Cinquecento. La storia del prestito ebraico viene interpretata da Todeschini in un’ottica, fin dalla sua origine, di stretto sia pur marginale rapporto con il prestito cristiano, e la sua crescente marginalizzazione si traduce alla fine in una separazione anche spaziale, oltre che economica e finanziaria, dal mondo cristiano: il ghetto. Giacomo Todeschini non è uno storico economico tradizionale, attento solo a privilegiare i flussi monetari e le trasformazioni economiche rispetto alla società e alla cultura. È uno storico sottile, attento alle mentalità, ai sistemi interpretativi, al modo in cui le funzioni economiche e finanziarie sono percepite nel Medioevo che ha tanto studiato, e ai rapporti tra i sistemi ideologici cristiani e quelli ebraici. Nulla di puramente fattuale nelle sue interpretazioni, ma mentalità, culture, percezioni che
L’ultimo lavoro di Giacomo Todeschini, La banca e il ghetto. Una storia italiana, è un libro importante che apre nuove prospettive di interpretazione e ricolloca in una luce nuova la storia degli ebrei italiani tra il XIV e il XVI secolo. Esso pone un nesso molto stretto tra l’affermarsi della banca cristiana in Italia nel XV secolo e la chiusura degli ebrei italiani nei ghetti. Una banca, quella cristiana, che è un’invenzione tutta italiana, il frutto specifico della struttura politica ed economica delle città e degli Stati italiani fra Due e Cinquecento. La storia del prestito ebraico viene interpretata da Todeschini in un’ottica, fin dalla sua origine, di stretto sia pur marginale rapporto con il prestito cristiano, e la sua crescente marginalizzazione si traduce alla fine in una separazione anche spaziale, oltre che economica e finanziaria, dal mondo cristiano: il ghetto. Giacomo Todeschini non è uno storico economico tradizionale, attento solo a privilegiare i flussi monetari e le trasformazioni economiche rispetto alla società e alla cultura. È uno storico sottile, attento alle mentalità, ai sistemi interpretativi, al modo in cui le funzioni economiche e finanziarie sono percepite nel Medioevo che ha tanto studiato, e ai rapporti tra i sistemi ideologici cristiani e quelli ebraici. Nulla di puramente fattuale nelle sue interpretazioni, ma mentalità, culture, percezioni che 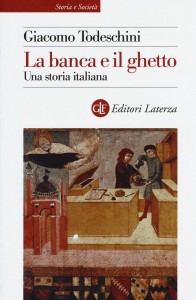 guidano e modificano le funzioni economiche e i rapporti tra diversi mondi culturali. Eppure in questo suo ultimo libro si sente, soprattutto nella seconda parte, quella dedicata al ghetto, la mancanza di un criterio interpretativo religioso che affianchi quello prevalentemente politico ed economico su cui si muove. Economico e naturalmente finanziario, perché è nella crescente divaricazione tra credito cristiano e usura ebraica che cresce l’estraneità dell’ebreo alla città, fino alla ghettizzazione. Politico, perché tale situazione è da lui ricondotta alla mancanza di un potere politico centrale e al frazionamento politico delle città stato rinascimentali italiane. In quest’ottica, però, il ghetto, in cui tanto importante è la funzione conversionistica, appare solo come un mezzo di separazione e marginalizzazione, non di controllo e conversione. Il che, se può forse valere per il ghetto di Venezia, non è certo sufficiente a spiegare la genesi di quello romano e degli altri ghetti cresciuti sulla spinta delle autorità ecclesiastiche. Due terzi del libro sono dedicati all’analisi del prestito ebraico e del suo stretto rapporto con la banca cristiana, della sua realtà nei diversi luoghi in cui si stabilisce attraverso le condotte, del modo in cui è interpretato nella società cristiana. Il quadro che Todeschini ne traccia è attento alle situazioni specifiche e alle differenze, ma in generale vi emerge un’immagine che contraddice nettamente la vulgata secondo cui il prestito ebraico dipendeva sostanzialmente dal bisogno di liquidità delle nuove realtà politiche cittadine ed era segno di una sostanziale convivenza tra il mondo cristiano e quello ebraico. La rilettura che Todeschini fa dei documenti che regolavano la permanenza nelle città dei banchieri ebrei, le condotte, offre piuttosto un quadro di separazione che di convivenza e sottolinea il fatto che si tratta sempre di concessioni ad personam, segnale dell’incapacità da parte cristiana di considerare gli ebrei come gruppo organizzato in forma comunitaria. La visione dominante vede invece una sostanziale convivenza tra ebrei e cristiani nelle città del centro e nord Italia dove vivono gruppi di ebrei prestatori, cancellata poi dall’esaurirsi della funzione finanziaria degli ebrei e dall’emergere della banca cristiana, attraverso la fondazione ad opera dei francescani dei Monti di Pietà. Su questa vulgata semplificatrice si abbatte la scure dell’analisi dell’autore: i banchi ebraici sono fin dal loro crearsi affiancati dai banchi cristiani, con la differenza che adempiono a una funzione assai più marginale di quelli cristiani, cioè al prestito su pegno, destinato a sovvenire ai bisogni delle fasce più basse. Ma soprattutto, assai diverso è il loro rapporto con il potere politico, che resta sempre incerto per gli ebrei, che rimangono stranieri, come restano vive la loro diversità e la loro inaffidabilità, nutrita nell’immaginario cristiano da secoli di propaganda antigiudaica. La cittadinanza è per gli ebrei dimidiata e ambigua, come ambiguo è il contratto che regola la loro presenza in città. Il processo di marginalizzazione crescente degli ebrei italiani si avvia al suo compimento all’inizio del XVI secolo, con l’inizio dell’età dei ghetti, di cui l’autore sottolinea la coincidenza temporale con l’emergere della banca. Separati anche fisicamente dai cristiani, avviati verso la scomparsa della loro funzione di prestatori, gli ebrei vivranno ormai in uno spazio chiuso, quello del ghetto, circondato da mura e guardie. Contrariamente alla storiografia che sottolinea la differenza tra il primo ghetto, quello di Venezia, ghetto essenzialmente volto a separare e creato per volontà del Senato veneto, e quelli successivi, a cominciare dal ghetto romano del 1555, creati essenzialmente per volontà delle autorità ecclesiastiche e subordinati alle loro spinte proselitistiche e di controllo, Todeschini offre una visione d’insieme del fenomeno della ghettizzazione, che non distingue tra i casi di Venezia e di Roma e non enfatizza i contrasti spesso lunghi e serrati tra autorità civili e religiose intorno alla creazione dei ghetti, indici di una resistenza delle autorità civili. Ugualmente non sottolinea la forte carica ideologica, conversionistica, che è alla base della Bolla di Paolo IV, Cum Nimis Absurdum, nel 1555. E neppure Todeschini si sofferma sul fortissimo apparato conversionistico e di controllo sociale esercitato nel cuore del cattolicesimo dalla Chiesa sul ghetto, che a Roma sembra divenuto, soprattutto nei primi cento anni, un laboratorio di esercizio del proselitismo e aver assunto, nel cuore della città e ad essa connesso da mille legami spaziali e sociali, un’importanza che mal si addice a una mera volontà di marginalizzazione. Un’importanza che tuttavia riguarda anche il ghetto di Venezia, pur collocato in una posizione decentrata rispetto al cuore della città, e gli altri ghetti che sorgono poco a poco nelle città italiane dove ancora sussiste una minoranza ebraica. L’esistenza del ghetto è molto presente all’attenzione della città cristiana, anche se la realtà del ghetto romano è quella in cui questa attenzione è più forte e costante. In definitiva, credo che questo libro sia un libro rilevante, destinato ad aprire nuove strade agli studiosi e a rinnovare molta parte della storiografia sugli ebrei italiani. Credo che il quadro tracciatovi dello stretto intreccio tra il prestito ebraico e la banca cristiana nella fase della formazione del sistema finanziario e della discussione delle sue valenze religiose e culturali sia importante e significativo. Considero anche molto suggestiva la continuità che Todeschini afferma tra la marginalizzazione dei prestatori ebrei nelle città e quella delle comunità nei ghetti, cioè il nesso tra banca cristiana e ghetto. Ma credo che all’origine della ghettizzazione controriformistica risiedano, accanto alle modalità della formazione del sistema bancario in Italia, anche motivazioni ideologiche e religiose, le stesse che sono espresse a chiare lettere nelle fonti ecclesiastiche che spingono alla creazione dei ghetti e ne regolamentano l’esistenza, in primo luogo la spinta alla conversione.
guidano e modificano le funzioni economiche e i rapporti tra diversi mondi culturali. Eppure in questo suo ultimo libro si sente, soprattutto nella seconda parte, quella dedicata al ghetto, la mancanza di un criterio interpretativo religioso che affianchi quello prevalentemente politico ed economico su cui si muove. Economico e naturalmente finanziario, perché è nella crescente divaricazione tra credito cristiano e usura ebraica che cresce l’estraneità dell’ebreo alla città, fino alla ghettizzazione. Politico, perché tale situazione è da lui ricondotta alla mancanza di un potere politico centrale e al frazionamento politico delle città stato rinascimentali italiane. In quest’ottica, però, il ghetto, in cui tanto importante è la funzione conversionistica, appare solo come un mezzo di separazione e marginalizzazione, non di controllo e conversione. Il che, se può forse valere per il ghetto di Venezia, non è certo sufficiente a spiegare la genesi di quello romano e degli altri ghetti cresciuti sulla spinta delle autorità ecclesiastiche. Due terzi del libro sono dedicati all’analisi del prestito ebraico e del suo stretto rapporto con la banca cristiana, della sua realtà nei diversi luoghi in cui si stabilisce attraverso le condotte, del modo in cui è interpretato nella società cristiana. Il quadro che Todeschini ne traccia è attento alle situazioni specifiche e alle differenze, ma in generale vi emerge un’immagine che contraddice nettamente la vulgata secondo cui il prestito ebraico dipendeva sostanzialmente dal bisogno di liquidità delle nuove realtà politiche cittadine ed era segno di una sostanziale convivenza tra il mondo cristiano e quello ebraico. La rilettura che Todeschini fa dei documenti che regolavano la permanenza nelle città dei banchieri ebrei, le condotte, offre piuttosto un quadro di separazione che di convivenza e sottolinea il fatto che si tratta sempre di concessioni ad personam, segnale dell’incapacità da parte cristiana di considerare gli ebrei come gruppo organizzato in forma comunitaria. La visione dominante vede invece una sostanziale convivenza tra ebrei e cristiani nelle città del centro e nord Italia dove vivono gruppi di ebrei prestatori, cancellata poi dall’esaurirsi della funzione finanziaria degli ebrei e dall’emergere della banca cristiana, attraverso la fondazione ad opera dei francescani dei Monti di Pietà. Su questa vulgata semplificatrice si abbatte la scure dell’analisi dell’autore: i banchi ebraici sono fin dal loro crearsi affiancati dai banchi cristiani, con la differenza che adempiono a una funzione assai più marginale di quelli cristiani, cioè al prestito su pegno, destinato a sovvenire ai bisogni delle fasce più basse. Ma soprattutto, assai diverso è il loro rapporto con il potere politico, che resta sempre incerto per gli ebrei, che rimangono stranieri, come restano vive la loro diversità e la loro inaffidabilità, nutrita nell’immaginario cristiano da secoli di propaganda antigiudaica. La cittadinanza è per gli ebrei dimidiata e ambigua, come ambiguo è il contratto che regola la loro presenza in città. Il processo di marginalizzazione crescente degli ebrei italiani si avvia al suo compimento all’inizio del XVI secolo, con l’inizio dell’età dei ghetti, di cui l’autore sottolinea la coincidenza temporale con l’emergere della banca. Separati anche fisicamente dai cristiani, avviati verso la scomparsa della loro funzione di prestatori, gli ebrei vivranno ormai in uno spazio chiuso, quello del ghetto, circondato da mura e guardie. Contrariamente alla storiografia che sottolinea la differenza tra il primo ghetto, quello di Venezia, ghetto essenzialmente volto a separare e creato per volontà del Senato veneto, e quelli successivi, a cominciare dal ghetto romano del 1555, creati essenzialmente per volontà delle autorità ecclesiastiche e subordinati alle loro spinte proselitistiche e di controllo, Todeschini offre una visione d’insieme del fenomeno della ghettizzazione, che non distingue tra i casi di Venezia e di Roma e non enfatizza i contrasti spesso lunghi e serrati tra autorità civili e religiose intorno alla creazione dei ghetti, indici di una resistenza delle autorità civili. Ugualmente non sottolinea la forte carica ideologica, conversionistica, che è alla base della Bolla di Paolo IV, Cum Nimis Absurdum, nel 1555. E neppure Todeschini si sofferma sul fortissimo apparato conversionistico e di controllo sociale esercitato nel cuore del cattolicesimo dalla Chiesa sul ghetto, che a Roma sembra divenuto, soprattutto nei primi cento anni, un laboratorio di esercizio del proselitismo e aver assunto, nel cuore della città e ad essa connesso da mille legami spaziali e sociali, un’importanza che mal si addice a una mera volontà di marginalizzazione. Un’importanza che tuttavia riguarda anche il ghetto di Venezia, pur collocato in una posizione decentrata rispetto al cuore della città, e gli altri ghetti che sorgono poco a poco nelle città italiane dove ancora sussiste una minoranza ebraica. L’esistenza del ghetto è molto presente all’attenzione della città cristiana, anche se la realtà del ghetto romano è quella in cui questa attenzione è più forte e costante. In definitiva, credo che questo libro sia un libro rilevante, destinato ad aprire nuove strade agli studiosi e a rinnovare molta parte della storiografia sugli ebrei italiani. Credo che il quadro tracciatovi dello stretto intreccio tra il prestito ebraico e la banca cristiana nella fase della formazione del sistema finanziario e della discussione delle sue valenze religiose e culturali sia importante e significativo. Considero anche molto suggestiva la continuità che Todeschini afferma tra la marginalizzazione dei prestatori ebrei nelle città e quella delle comunità nei ghetti, cioè il nesso tra banca cristiana e ghetto. Ma credo che all’origine della ghettizzazione controriformistica risiedano, accanto alle modalità della formazione del sistema bancario in Italia, anche motivazioni ideologiche e religiose, le stesse che sono espresse a chiare lettere nelle fonti ecclesiastiche che spingono alla creazione dei ghetti e ne regolamentano l’esistenza, in primo luogo la spinta alla conversione.
Anna Foa, Pagine Ebraiche, marzo 2016
