Il rumore del tempo
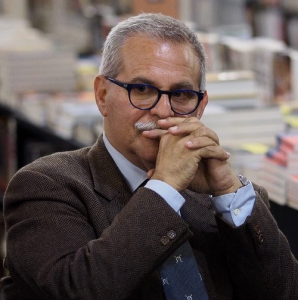 Un uomo passa le notti sul pianerottolo, in piedi accanto alla porta – le orecchie e i sensi tesi al minimo rumore. Sua moglie e la bimba di un anno sono nella sua stanza da letto, a pochi passi. Aspetta. Gira voce che con chi è già pronto la polizia è meno brusca, e poi vuole evitare scene difficili da dimenticare alle sue due donne. Nella sua piccola valigia, insieme a pochi vestiti e il necessario per l’igiene, ha messo tre pacchetti di sigarette; gli serviranno, pensa, durante la prima notte di veglia, per gli interrogatori e quando sarà recluso. O no ? Sarà ucciso subito dopo essere stato portato alla Grande Casa? Alla terza notte di ricordi e terrori, fumerà.
Un uomo passa le notti sul pianerottolo, in piedi accanto alla porta – le orecchie e i sensi tesi al minimo rumore. Sua moglie e la bimba di un anno sono nella sua stanza da letto, a pochi passi. Aspetta. Gira voce che con chi è già pronto la polizia è meno brusca, e poi vuole evitare scene difficili da dimenticare alle sue due donne. Nella sua piccola valigia, insieme a pochi vestiti e il necessario per l’igiene, ha messo tre pacchetti di sigarette; gli serviranno, pensa, durante la prima notte di veglia, per gli interrogatori e quando sarà recluso. O no ? Sarà ucciso subito dopo essere stato portato alla Grande Casa? Alla terza notte di ricordi e terrori, fumerà.
Bastano poche righe a Julian Barnes per dare la chiave del suo ultimo romanzo Il rumore del tempo (Einaudi, traduzione di Susanna Basso). Il protagonista è un uomo che pensa, immagina, ricorda. Ha già avuto una vita piena di emozioni e avvenimenti, già conosce il mondo e le sue apparenze, già sa di essere debole. Ha una sola certezza, la sua musica. È Dmitrij Šostakovič; è il più celebre compositore russo, ma Stalin non ha apprezzato la sua ultima opera e si sa, questo basta e avanza per sparire, a quei tempi, in Russia. Diviso ma unito in tre parti, come una suite musicale in tre movimenti, il libro è una biografia che si fa romanzo in forma di autobiografia: dalla giovinezza alla vecchiaia, Dmitrij si ricorda e si racconta la storia di un uomo ‘poco risoluto’ e di genio chiamato Šostakovič. Sono pensieri e ricordi, immagini di una vita comune ma straordinaria. Il secondo movimento è in aereo, durante i viaggi di andata e ritorno in America; il terzo in automobile, quando tutto o quasi è ormai avvenuto e – se il pericolo non è più imminente – la fine è più vicina e il suo senso, il senso di una intera vita, continua a sfuggirgli.
La lingua piana e affabulante di Julian Barnes (in rete potete ascoltarne la voce, e capire bene il metodo e il tono dei suoi romanzi) si fa narratrice di una storia che solo in apparenza è quella che vi ho sommariamente descritto. Ciò che è in gioco, secondo me, è infatti il conflitto che ogni artista non può evitare, quello fra i suoi due ego, fra la vita e la sua rappresentazione, fra la sua certa mortalità e l’immortalità incerta della sua arte. Di conseguenza, questo è un libro sull’onestà e la falsificazione, sul coraggio e la viltà.
È vero, Barnes sa riempire le sue pagine di particolari e di aneddoti documentati dalle biografie sul compositore e dalle testimonianze che lo stesso Šostakovič ha lasciato, e che forniscono la cornice di una vicenda che è nello stesso tempo personale e politica, umana e storica. Ma ciò che passa – sottile come una vibrazione, persistente come una nota estenuata, efficace come un terremoto – è il mistero della creazione: insondabile per chi ne è artefice, interpretabile per chi ascolta, o legge, guarda.
La spietata, rumorosa macchina sovietica – come ogni altra fabbrica di morte di sempre – è un monumentale esercizio di volontarietà temporale; l’involontarietà di ogni opera d’arte riuscita – indisciplinata, silenziosa forma della disciplina più rigorosa – si libera dalle prigioni e dai rumori del tempo, come una musica che risuona e fa vibrare chi ha (ancora) orecchie e stomaco per udirla.
Ps: Ho riletto Eccomi di Safran Foer. Confermo: pagine bellissime, temi che meritano riflessione e studio, ma come romanzo non è riuscito: è troppo volontario ed esposto, troppo rumoroso. Manca la musica.
Valerio Fiandra
(15 settembre 2016)
