Katherine
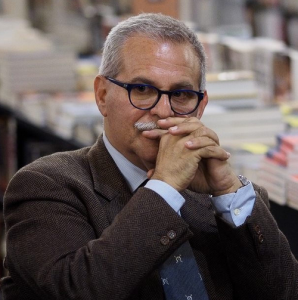 “Quando arriviamo?”. A Katherine piace ricordare sua madre che le chiede di ripetere la domanda che faceva da piccola piccola, quando – appena partita per un breve viaggio o una semplice gita – alla prima fermata (un semplice stop sulla strada o la prima stazione della metropolitana) già voleva arrivare. Alle ultime pagine di questo romanzo misterioso – una spy story interiore – Katherine è a Ugolgrad, un’isola delle Svalbard, l’arcipelago norvegese dell’estremo nord; non molte settimane prima era a Roma, in motorino o a ballare. Ha diciannove anni, la chiamano tutti Kit, è benestante; suo padre è un famoso giornalista, sempre in giro fra una guerra e una rivoluzione; sua madre è morta. Una sera va a vedere per l’ennesima volta un film che le piace molto, Professione Reporter di Michelangelo Antonioni; ascolta la conversazione della coppia inglese seduta davanti a lei, sente nominare una persona e un indirizzo sconosciuti e decide che – invece di Oxford, dove è attesa per un corso universitario – andrà a Berlino, a trovare Klaus Frings in Walter-Benjamin-Platz. Pochi giorni dopo abbandona il computer sotto un arco antico, getta il cellulare nel Tevere, compra un ombrello e va, attratta dal nulla, verso un destino di cui vuole conoscere i contorni solo mentre ne attraversa la tela.
“Quando arriviamo?”. A Katherine piace ricordare sua madre che le chiede di ripetere la domanda che faceva da piccola piccola, quando – appena partita per un breve viaggio o una semplice gita – alla prima fermata (un semplice stop sulla strada o la prima stazione della metropolitana) già voleva arrivare. Alle ultime pagine di questo romanzo misterioso – una spy story interiore – Katherine è a Ugolgrad, un’isola delle Svalbard, l’arcipelago norvegese dell’estremo nord; non molte settimane prima era a Roma, in motorino o a ballare. Ha diciannove anni, la chiamano tutti Kit, è benestante; suo padre è un famoso giornalista, sempre in giro fra una guerra e una rivoluzione; sua madre è morta. Una sera va a vedere per l’ennesima volta un film che le piace molto, Professione Reporter di Michelangelo Antonioni; ascolta la conversazione della coppia inglese seduta davanti a lei, sente nominare una persona e un indirizzo sconosciuti e decide che – invece di Oxford, dove è attesa per un corso universitario – andrà a Berlino, a trovare Klaus Frings in Walter-Benjamin-Platz. Pochi giorni dopo abbandona il computer sotto un arco antico, getta il cellulare nel Tevere, compra un ombrello e va, attratta dal nulla, verso un destino di cui vuole conoscere i contorni solo mentre ne attraversa la tela.
È una fuga o un ritorno ?
Katherine è nata nel freddo, in un laboratorio londinese, per fecondazione in vitro; il grembo di sua madre l’ha accolta e messa alla luce solo otto anni dopo. Il sole e la leggerezza di Roma, dove la famiglia Carlyle si è trasferita, non sono bastati a scongelarla; la predeterminazione della sua vita la forza a contrare ogni programma, a subire la seduzione del non programmabile.
Narrata in prima persona, la storia di “Katherine, o gli inattesi colori del destino”, dello scrittore inglese Rupert Thomson (EnneEnne Editore, traduzione da bisturi e ovatta di Federica Aceto, 17 Euro) vi potrebbe stregare. Uso il condizionale perché è un romanzo che può anche respingere; andrebbe letto come va visto un film di Wenders, o di Lynch – disattivando, fin che è proiettato, il bisogno di capire. Quel che lascia, a libro chiuso, è un sapore che svela e riscalda, non ostante ( o proprio grazie ) il freddo glaciale che lo ha custodito. La lingua di Thomson è precisa, scientifica; la cura di ogni particolare, di ogni personaggio sono da entomologo. Frings, Olav, Eugenji, Mr Cheadle salgono e presto scendono dal palcoscenico che Katherine allestisce, tutti comprimari per l’ininterrotto dialogo con suo padre, stella polare e dark star insieme.
E non sarà certo per caso che, di tutti i luoghi descritti con minuziosa, quasi ossessiva precisione ( il Portico d’Ottavia, il KaDeWe, il Cafè Einstein, le stazioni ferroviarie, gli aereoporti, le stanze d’albergo, i supermercati e le biblioteche – ma l’elenco è sommario ), il solo a non essere vero – a non esistere sulle mappe o per le strade delle città, è proprio quello dove Katherine si ritrova: Ugolgrad, infatti – ho controllato – non c’è. Ma Katherine ci è arrivata.
Valerio Fiandra
(29 dicembre 2016)
