NARRATIVA Che talento, questo Amoz Oz
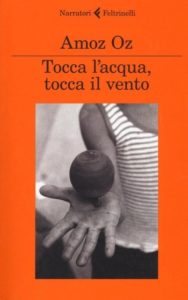 Amos Oz / TOCCA L’ACQUA, TOCCA IL VENTO / Feltrinelli
Amos Oz / TOCCA L’ACQUA, TOCCA IL VENTO / Feltrinelli
Un romanzo dice parecchio di chi l’ha scritto, certo, ma anche di chi l’ha letto, di chi si accinge a farlo, e persino di chi non lo leggerà mai. Ce ne sono alcuni di cui non ricordiamo niente se non quando e dove li abbiamo divorati; di altri sappiamo solo che non ci piacquero ma abbiamo scordato il perché. Mi scuserete allora se stavolta, a rischio di auto-compiacermi, mi soffermerò, almeno di primo acchito, su questo aspetto della faccenda. Come tutti quelli che fanno il mio mestiere mi capita di ricevere libri. Il che è solo in apparenza un vantaggio. Preferisco comprarli. L’acquisto stabilisce tra te e un romanzo una relazione più leale: allo stesso tempo intima e impegnativa. Di solito il numero di pacchi ansiosi di infilarsi in casa mia supera il livello di guardia (e di decenza) a cavallo tra gennaio e febbraio, in concomitanza del Giorno della Memoria, quando gli editori sono soliti pubblicare memoir di poveri cristi scampati alla mattanza hitleriana. L’idea che ci si ricordi di me soprattutto quando si devono smerciare storie di persecuzione mi fa sentire un essere lugubre, un parassita sedentario, una parodia di quel che mai avrei voluto diventare. Ma che posso farci? La cosa più deprimente sono le fotografie seppiate in copertina che dovrebbero celebrare normalità borghesi spazzate via con una schicchera dal vento della Storia, e suonano invece come violini che accompagnano le immagini di repertorio dell’ennesimo documentario sulla Shoah in seconda serata. Ecco perché di norma non li leggo. Visto che a pochi è concesso il dono di tramutare il dolore in poesia, meglio non tentare la sorte. Comunque, qualche giorno fa arriva un pacco Feltrinelli contenente quel che ha tutta l’aria di essere il nuovo Amos Oz. È strano il sentimento che suscitano certi nomi. Oz è uno dei pesi massimi della letteratura mondiale, un autore generoso e prolifico, un maestro della narrativa a cui devo molto. Ricordo ancora l’emozione con cui lessi Michael mio. Mettersi nel cuore di una donna in un modo così plausibile è un esercizio che riesce solo ai grandi scrittori (parlo dei maschi naturalmente). Eppure l’uscita di un suo libro non mi da più il brivido di un tempo. Forse perché credo di sapere quel che troverò; o forse perché — per quanto crudele possa sembrare ciò che sto per dire — non t’aspetti più molto da un autore ottantenne. E così che il suo romanzo dalla sgargiante copertina arancione è andato a infittire la pila di libri da leggere che non leggerò mai. Tutto questo avveniva martedì scorso. Ma come dicevo, la storia di un libro, il modo in cui entra nella vita di ciascuno di noi, prescinde dal suo valore e dalla nostra volontà di leggerlo e assimilarlo. Così una sera torno a casa con l’umore sotto i tacchi. Alle spalle una di quelle giornate bigie disseminate di intralci che rendono la vita faticosa, opprimente e insensata. Ho voglia di caffè americano, un bel bagno, un film della Marvel. Sono quelli i momenti in cui senti vacillare la fede nel potere ristoratore dell’arte. Mi chiedo se capiti anche ai commercialisti o ai magistrati. Se ogni tanto anche loro perdano fiducia nei numeri o nella giurisprudenza. A chi scrive per sbarcare il lunario capita continuamente. D’un tratto tutto ciò che ami diventa muto e repellente. Più o meno il mio stato d’animo quando — dopo uno scazzato zapping in accappatoio — ho posato la tazza di caffè per sfilare il libro di Oz dal cumulo di libri da leggere che non leggerò mai. Il malumore ha trovato nella terza di copertina pane per i suoi denti. La solita storia di una coppia di ebrei polacchi nell’inverno del 1939. Quante ne abbiamo lette? Se ne sentiva davvero la necessità nella primavera del 2017? Mi sono detto: tra i tanti colpi di genio di Philip Roth c’è anche quello di aver smesso di scrivere poche ore prima che potessi pensare altrettanto di lui o di un suo libro. Per capire l’entità del mio errore è bastata la seguente frase: «Finché una sera di Pasqua il taglialegna non si vantò con i contadini dicendo che, se l’avessero colpito forte in testa con un’ascia, questa si sarebbe spezzata. Ci provarono, e l’ascia rimase intatta». Non è degna di Groucho Marx? Da lì in poi non faccio che ricredermi, con Oz che mi sorprende quasi a ogni riga, e proprio sul campo su cui è più difficile sorprendermi: la persecuzione antisemita. Do di nuovo una scorsa al titolo, Tocca l’acqua, tocca il vento: fresco e ineffabile come i due formidabili eroi romanzeschi, i coniugi Elisha e Stefa, lui orologiaio con il pallino della matematica, lei avvenente intellettuale il cui ritratto sembra ricalcato sulla giovane Hannah Arendt. Divisi dalla guerra si ritroveranno molti anni dopo in Israele. In un attimo ecco svanire malumore, spleen, senso di gratuità. Mi rilasso, mi diverto, mi entusiasmo. La cosa più bella, mi dico, è come tratta il tempo e lo spazio. Tutto vola via delicatamente. Il peso è stato abolito. I personaggi corrono da un lato all’altro del pianeta senza bisogno di bagagli e salvacondotti. Elisha ci mette un paio di righe a emigrare in Israele, più o meno altrettanto impiega Stefa a diventare una spia russa. Questi giovani ebrei levitano in cielo come i rabbini di un dipinto di Chagall, misteriosi e implausibili come tutte le cose belle. La dicotomia tra il gelo mitteleuropeo e i venti caldi della Galilea crea un vortice corroborante di vita. Mescolando Bruno Schulz e Agnon, la prosa s’arricchisce di spunti smaglianti: «A Tiberiade c’era odore di pesce fritto, nel pomeriggio. E la notte era di pesce marcio. Quasi a ogni ora del giorno si percepiva un alito sottile ma ostinato di putrefazione marina». «Capitava che tutt’a un tratto gli tornasse in mente la neve. Di lì aveva l’impressione che la neve non fosse altro che una imitazione stralunata, inattendibile, un decoro di cartapesta buono per un’operetta di provincia». «Riparare gli orologi gli procurava una sensazione di gioia fredda, la graduale ripresa di un ordine delle cose. Era un’esperienza non dissimile da una convalescenza, un piacere quasi matematico, qualcosa di non distante dalla musica». Mi dico: questo è lo stile di un ragazzo prodigio, altroché. Solo allora mi accorgo che il libro è stato scritto nel 1973, un anno fondamentale per la storia di Israele, qualche mese dopo la strage all’Olimpiade di Monaco, in piena Guerra del Kippur. All’epoca Oz aveva trentaquattro anni. Il libro esprime tutta la nostalgia per l’utopia sionista mai così minacciata. Ripenso all’indiscusso capolavoro di Oz, Una storia di amore e di tenebra. Ebbene, in qualche modo, Tocca l’acqua, tocca il vento ne sembra il surreale presagio, capace com’è di illustrare lo straordinario cambiamento avvenuto nell’immaginario giudaico con la nascita di Israele: da allora l’ebreo è cambiato, non tanto nella percezione degli altri (chi se ne importa), ma nell’idea che ha di se stesso. Dando una scorsa alla mia libreria identifico subito il dorso verdino di Una storia di amore e di tenebra (grazie al cielo non sono molti gli scrittori con la «O»). Il caso vuole che lo apra proprio sulla pagina che cercavo, a suo tempo amorevolmente sottolineata: «Non ce ne facciamo più nulla, insomma, della letteratura da piagnistei, ci siamo stufati delle descrizioni di borghi ebraici, siamo sazi di quegli esemplari umani tutti accattoni e giovinotti, straccivendoli e fannulloni dalla lingua lunga, ora qui nella nostra terra abbiamo bisogno di una letteratura veramente nuova, una letteratura cui i protagonisti siano personaggi maschili e femminili attivi e non passivi, donne e uomini che non siano stereotipi di maniera ma persone in carne e ossa, dotati di istinti forti, di debolezze tragiche e anche di profonde contraddizioni interiori, figure di cui la nostra gioventù possa trarre entusiasmo, alla cui luce possa educarsi, attingere ispirazione dalle loro idee e dalle loro opere eroi ed eroine figli del nostro tempo o anche figure epiche o tragiche della storia antica del nostro popolo, che invitino al rispetto e all’immedesimazione, e non suscitino ribrezzo o distaccata pietà. Di personaggi letterari israeliti o europei abbiamo ora bisogno nella nostra terra, niente più sensali e giullari e fannulloni e ricchi e mendicanti esilico-folkloristici». Non ricordo il preciso contesto in cui cadono queste parole entusiaste, né se Oz vi aderisca completamente, o se le utilizzi in modo capzioso e parodistico. Ma so che esse si attagliano perfettamente a Elisha e Stefa, e anche a Ernest Cohen, il segretario del Kibbutz dove i due coniugi girovaghi si rincontrano; e a pensarci si adattano anche a suo figlio Yotam e le sue due concubine, Vera e Sarah; insomma valgono per tutti gli eroi di Tocca l’acqua, tocca il vento, scritto una ventina d’anni prima rispetto a Una storia di amore e di tenebra. Non a caso le ritrovo, almeno nello spirito, nel discorso di un personaggio che parlando della neonata Israele dice senza giri di parole: «II che significa che l’acqua si è giudaizzata su un pezzo di territorio, così come i boschi, i campi e le steppe, come se finalmente un dio avesse avuto pietà di noi e ora è tutto cambiato, d’ora in poi questa galassia è disposta a tollerarci, disposta a tollerare le nostre melodie, i nostri odori, le nostre battute di spirito, disposta a non scrollarci continuamente via da sé, anche se tutto sommato è un minuscolo angolo, un brandello lillipuziano di terra». Questo è un libro-ponte, o se preferite, un tappeto volante tra due mondi allo stesso tempo prossimi e inconciliabili. Non c’è ombra di patetismo, c’è solo gioia e melanconia, la gioia e la melanconia della narrativa che amo. Il modo in cui Oz assimila questi due universi, fin quasi a confonderli, è la magia. C’è un’atmosfera onirica, fiabesca, paradossalmente idonea sia alla vecchia Europa abbandonata che alla nuova patria ebraica. Ecco, il libro è finito. Lo chiudo soddisfatto. Riscatta una giornata così cupa e inutile. Stento a riporlo come accade sempre con i pochi libri che abbiamo amato. Lo carezzo come un peluche. Solo allora, guardando la copertina, noto ciò che mi era sfuggito. Il nome dell’autore è sbagliato. C’è scritto Amoz Oz. Non è poi così strano che me ne sia accorto solo ora. Per me i refusi non sono mai uno scandalo, difficilmente faccio caso ai miei, figurarsi a quelli degli altri. Del resto, ci sono libri talmente inerti e inutili che la sola traccia di vita è nei refusi. Ma non sono mica tutti come me. E immagino che, per un editore, sbagliare il nome di battesimo di una gloria del catalogo sia un bel guaio. Faccio una ricerca su Google e scopro che in effetti è scoppiato un piccolo scandalo, che il libro è stato ritirato dal mercato. Evidentemente me lo hanno spedito prima che ciò avvenisse. Mi scappa da ridere: Amoz Oz. Qualcosa a metà tra un’allitterazione e un’anafora. L’iterazione del monosillabo «Oz» mi sembra particolarmente adeguata a un libro del genere, un romanzo picaresco e stregato. Oz, come il celebre mago di Frank Baum, il vecchio impostore che si fa passare per ciò che non è. La controfigura perfetta di un grande scrittore, che per statuto deve farsi passare per ciò che non è. Prima di addormentarmi lieto mi dico che se fossi stato in uno della Feltrinelli avrei difeso il mio errore. No, avrei detto, questo libro bellissimo, questa splendida favola, non è di Amos Oz ma del suo stravagante, talentuoso cugino AMOZ.
Alessandro Piperno, Corriere La Lettura, 2 aprile 2017
