STORIA L’Ungheria dilaniata di Sándor Márai nel pamphlet perduto e ritrovato
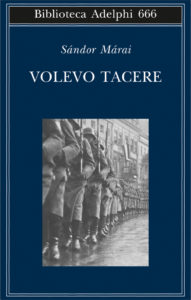 Sándor Márai / VOLEVO TACERE / Adelphi
Sándor Márai / VOLEVO TACERE / Adelphi
Sembrava la mattinata primaverile di una giornata qualunque, a Budapest, quel 13 marzo del 1938, sul viale bordato di castagni che conduceva alla Fortezza — scrive Sándor Márai in Volevo tacere (Adelphi, con la traduzione di Laura Sgarioto) — e poi anche su via dei Bastioni, lungo la quale si incontravano i pochi aristocratici veri e i molti borghesi che facevano la passeggiata prima di pranzo. Lui, Márai, giovane scrittore già affermato nonché giornalista per nulla vergognoso di accoppiare le due professioni, aveva già fatto la sua ora di tennis al circolo sull’isola, bevuto la spremuta d’arancia che la domestica gli aveva portato come sempre nello studio, e messo giù le abituali trentacinque righe quotidiane del romanzo al quale stava lavorando che, nella fattispecie, si occupava del Settecento italiano e di Casanova. Invece, non era una giornata qualunque. La sera precedente, e adesso le truppe tedesche avevano varcato il confine austriaco, le bandiere di Hitler sventolavano a Vienna. Tra poco sarebbe stata proclamata l’Anschluss, l’annessione, e quel mondo che adesso era nitido, rassicurante come lo viveva il romanziere metodico, possibile erede dell’Uomo senza qualità — e come lo rispecchiavano le facciate dei bei palazzi antichi, le vetrine dei ristoranti alla moda e dei caffè, nei quali gli intellettuali leggevano le poesie di Rilke e di Apollinaire o mettevano l’Odissea sul tavolino — si sarebbe sfarinato e poi dissolto nell’incertezza più oscura. Gli scrittori — non tutti — hanno il sesto senso, e queste cose le capiscono al volo. Ma quel giorno tutta Budapest «sentiva» che qualcosa stava capitando: negli uffici ministeriali regnava la confusione; i diplomatici erano di cattivo umore; i commercianti arrivavano nervosi nei loro negozi; gli ebrei, «con il loro antico istinto del pericolo — che è molto sottile, ma gli eventi hanno dimostrato che non sempre li porta a trarre le debite conclusioni — cominciavano a guardarsi intorno» o addirittura a fare i bagagli; i militari di carriera, con la segreta soddisfazione che nasceva dalla consapevolezza di non aver sprecato inutilmente la propria vita, drizzavano le orecchie. Il «grande corpaccione tedesco» s’era mosso. Nessuno — in quella piccola nazione di origine asiatica, stretta fra l’Occidente, gli slavi e i Balcani, tormentata dal feroce dominio turco — poteva ancora immaginare cosa sarebbe accaduto di lì a poco e negli anni successivi. Ma quella non era una giornata qualunque. Volevo tacere, scritto fra il 1949 e il 1950, ritenuto disperso e ritrovato fra le carte del Museo di Letteratura di Budapest, è un pamphlet storico e politico nel quale, senza alcuna ipocrisia e senza mezzi termini, si raccontano l’Ungheria e questi anni che vanno, appunto, dall’annessione dell’Austria allo scoppio della Seconda guerra mondiale, e si concludono con l’invasione dei sovietici del 1945. Anni stranissimi, per un certo verso. Nei quali, ad esempio, il feroce antisemitismo che da sempre scorreva nelle vene del sangue magiaro, pur tuttavia consentì agli ebrei — che poi in ottocentomila finirono nei campi di sterminio — un periodo di sopravvivenza senza l’obbligo della stella gialla. Anni nei quali la complicata stratificazione delle etnie produsse inusuali mescolamenti sociali. Anni nei quali il risentimento che alberga nel cuore dei più deboli o degli esclusi provocò un ottuso desiderio di ribellione contro tutti e contro tutto, un odio profondo antiborghese e di classe che finì per offrire ai sovietici la nazione inerme, violenta, alla deriva, sulla quale misero il cappello. È un libro di grande interesse, questo di Márai. Soprattutto se letto nell’ottica del presente. Denuncia l’attrazione della gran parte del popolo ungherese per l’ideologia hitleriana, e il successivo coinvolgimento nella guerra. La violenza fascista. L’osceno baccano della destra «intossicata dalla stampa nazista, fatta di urrà, di insulti antisemiti e di ingiurie lanciate indistintamente contro l’Occidente e l’Oriente».
Giorgio Montefoschi, Corriere della Sera, 2 giugno 2017
