NARRATIVA Il Bene e il Male si scambiano le parti
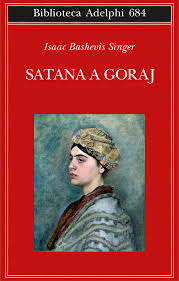 Isaac Bashevis Singer / SATANA A GORAJ / Adelphi
Isaac Bashevis Singer / SATANA A GORAJ / Adelphi
Nell’anno 1648, i cosacchi dell’atamano Bohdàn Chmel’nitskij, insieme a un esercito di contadini ribelli – racconta Isaac Bashevis Singer in Satana a Goraj — mossero alla volta della cittadina polacca di Goraj e la devastarono: scorticarono vivi gli uomini, violentarono le donne, sgozzarono i bambini. Morirono circa 100 mila ebrei. Quando poterono farvi ritorno, i pochi superstiti che si erano rifugiati a Lublino, trovarono un luogo cancellato dalla terra. Era stato, ed era, un orrore. Ma i grandi cabalisti della Polonia sostenevano che i giorni dell’esilio erano ormai contati e i massacri dei cosacchi erano le doglie che annunciavano la nascita del Messia; fatti eccezionali che confermavano la prossimità di questo evento si manifestavano ovunque (chi dichiarava di aver udito risuonare il grande corno d’ariete ad annunciare la fine del mondo, chi asseriva d’aver visto in cielo Israele uscire vittorioso dalla battaglia di Armageddon); le donne facevano straordinari sogni (chi sognava il profeta Elia proclamare che la redenzione stata per venire nel mondo, chi vedeva calare una grande nube che avrebbe condotto tutti gli ebrei a Gerusalemme); soprattutto, si parlava di un uomo, Shabbatay Tzevi, che, dopo 1.700 anni d’attesa avrebbe finalmente liberato il popolo ebraico dalla schiavitù e dalle sue pene. e Shabbatay Tzevi — personaggio storico sul quale Gershom Scholem ha scritto il suo libro più bello — era un ebreo di Smirne alto quanto un cedro. Su di lui correvano le voci più disparate. Chi diceva che abitava in un palazzo di Gerusalemme, chi diceva che viveva con i discepoli in una caverna. Chi lo aveva visto passare a cavallo vestito di seta, coperto di pietre preziose, preceduto da 50 valletti; chi sosteneva che digiunava da un sabato all’altro e sottoponeva il suo corpo ai più severi tormenti. Chi pensava fosse il precursore ultimo del Messia, chi invece si diceva convinto fosse il vero Messia. Chi diceva che era un eretico, chi un malfattore. Chi diceva che era il santo mandato da Dio perché, un giorno, in una piazza, aveva osato l’inosabile, e cioè pronunciare ad alta voce il nome impronunciabile di Dio e Dio non lo aveva punito. Shabbatay Tzevi, in realtà, era un mistico nutrito dall’idea cabalistica della creazione. Questa, in estrema sintesi, è la seguente. L’En sof — il principio divino inconoscibile che trascende la creazione — spinto da un impulso spontaneo e benefico, aveva voluto manifestarsi. Per farlo, per poter apparire nel cosmo, aveva dovuto limitare sé stesso, contrarsi. Dalla contrazione, si era diffusa un’energia luminosa che, come un liquido, si era raccolta in dei vasi. Senonché, i vasi superiori, quelli più vicini al principio dell’emanazione, furono in grado di sopportare quest’energia; quelli inferiori si ruppero e la luce tornò verso l’alto. Ma i frammenti dei vasi dispersi nell’universo — le cosiddette gelippot, le «scorze», origini del male — continuavano a tenere prigioniere delle scintille di luce. Per restaurare i primordi, e portare a termine la creazione, l’uomo doveva liberarle con le sue azioni pie e sante. Shabbatay Tzevi — tale la sua azzardata convinzione — pensava che le azioni pie e buone non bastassero, e che l’uomo, per annientarlo, dovesse entrare letteralmente nel male, farsi peccatore, scendere nel regno del demonio. Tutto questo, gli ebrei di Goraj non lo sapevano. A loro, impegnati a ricostruire le proprie abitazioni e le case di preghiera, a rimettere in piedi le botteghe e il mercato, a combattere una volta gli alluvioni, una volta la siccità, una volta le ondate di gelo, le voci che arrivavano da lontano non avevano alcuna sostanza teologica, prendevano esclusivamente la forma del miracoloso e dell’impossibile, coniugavano al più basso livello il dilemma della lotta, o della convivenza, del bene con il male. Finché, una mattina di gennaio, nella piazza principale della città si fermò una slitta. Ne scese un uomo con i peli della barba e i riccioli induriti dal ghiaccio. «Ebrei», esclamò, «vengo dalla Terra Santa. Sono stato mandato dai miei fratelli in esilio per dirvi che il Grande Pesce che si cela nel Nilo è morto per mano di Shabbatay Tzevi, il nostro Messia e santo re… Ben presto la sua regalità sarà rivelata ed egli strapperà la corona dal capo del sultano… Tenetevi pronti!». Le donne fremevano, gli uomini cadevano a terra svenuti. Ora, Goraj è sconvolta. Da una parte ci sono i rabbini ortodossi che non credono a questa novità ma solo alla vecchia Legge e ai Testi Sacri, e pensano che i cabalisti indagano cose che dovrebbero rimanere celate; dall’altra, quelli che credono ciecamente al nuovo Messia, e si esaltano. In un angolo, in un vero angolo dimenticato del mondo, vive una ragazza, Rechele, nata qualche, settimana prima del massacro del 1648. È orfana di madre; suo padre, un tempo ricco usuraio, è sparito e l’ha lasciata alle cure di una nonna pazza che l’ha terrorizzata raccontandole storie di briganti, cannibali, fantasmi che la notte girano nei cimiteri in cerca di cadaveri in cui rientrare; a 19 anni, non bella ma neppure brutta, è afflitta dalle più strane malattie, non si nutre, vomita bile, e ha una gamba irrigidita. Intanto, c’è stato l’arrivo di un altro emissario di Shabbatay Tzevi. È un ambulante, Itche Mates, e con sé ha una lettera scritta in aramaico, nella quale è spiegata la storia delle scintille divine racchiuse nelle scorze del male. Shabbatay Tzevi — dice l’ambulante agli uomini e alle donne che l’ascoltano sudando e tremando — è il Messia destinato a entrare nel Male, a liberare le scintille e a redimere Israele per sempre. Gli ebrei pendono dalle sue labbra. Lui va di casa in casa a controllare che in vista della redenzione ogni cosa sia pronta e incontra Rechele. La vede discinta. Se ne innamora. Vuole sposarla. Lei si rifiuta, ha paura, piange. Finché le donne non la convincono e ci sono le nozze, durante le quali Itche Mates balla pazzamente. Ma dopo 7 notti è ancora vergine, nonostante le parole dolci che riesce a balbettare nel letto. E non è finita. Anzi, siamo al culmine del conflitto e del romanzo. Perché c’è un ultimo arrivo, Reb Gedaliya, macellatore di professione, che annuncia come Shebbatay Tzevi, alla testa di un grandioso corteo, stia marciando verso Istanbul, ricevendo omaggi ovunque, da califfi e pascià. Goraj impazzisce. Gedaliya diventa capo assoluto della comunità, caccia via l’ambulante da casa di Rechele e ci si istalla. Convinti dalla narrazione che confonde Bene e Male, gli ebrei pregano, si purificano e, insieme, si abbandonano a ogni tipo di sconcezze: mogli che si concedono a tutti, mariti senza freno, pederasti che si accoppiano con animali. Gedaliya possiede Rechele ogni notte. Arriva un ulteriore notizia: «Il Messia si è messo il fez, si è fatto turco!». C’è chi non ci crede, chi teme questa vergogna, chi dice che non è vera affatto questa notizia, perché è stata la sua ombra a convertirsi all’islam. Rechele, fuori di sé, ascolta una voce che le dice: «Va’, e annuncia che il prossimo anno ci sarà la perfetta redenzione». II piano è pronto. E lei è la vittima: il corpo nel quale Satana ha preordinato di entrare per prenderne possesso. Infatti ci entra e la stupra. Noi lettori non capiamo se entra in lei nelle sembianze di uno spirito malvagio in cerca di un cadavere o in quelle terrene di quell’altro diavolo che è il macellatore. Singer ci lascia nel dubbio. Questo, comunque, non ha importanza. Rechele muore. E con questo colpo di genio che capovolge la situazione — non è un Santo a penetrare in un corpo impuro, bensì il Demonio a entrare in un corpo puro — il romanzo si conclude.
Giorgio Montefoschi, Corriere La Lettura, 8 luglio 2018
