NARRATIVA Il lato fiabesco di Albert Einstein
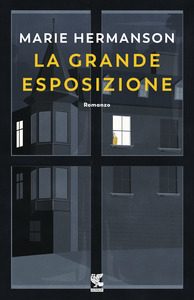 Marie Hermanson / LA GRANDE ESPOSIZIONE / Guanda
Marie Hermanson / LA GRANDE ESPOSIZIONE / Guanda
Il Nobel a Einstein, e non per la teoria della relatività, fu conferito nel’22, ma solo sei mesi dopo, e non a Stoccolma, egli tenne il discorso che gli permise di intascare il premio. Era l’11 luglio 1923, e lo ospitò per l’occasione Götheborg che celebrava con una grande esposizione i 300 anni della città. Einstein arrivò con due giorni di ritardo sulla tabella di marcia dei festeggiamenti e intorno a questi due giorni di mai spiegato ritardo si sviluppa la trama della Grande esposizione. Il romanzo di Marie Hermanson è una tessitura a più voci guidata da un narratore universale, con cui interferisce a tratti un testimone del tempo, un ottantenne che nel 2002 ricorda come fu coinvolto nella bagarre dell’expo e addirittura nel breve soggiorno di Einstein nel sud della Svezia. Tredicenne e orfano nel 1923, incaricato di condurre l’asina Bella (questa sì, vera presenza tra i divertimenti dell’esposizione) è la sola voce sopravvissuta a conservare la memoria, incompiuta per lui che ne ha colto solo un frammento, di un episodio drammatico della storia del grande fisico. È dentro e dietro tale episodio che si gioca la trama della Hermanson, incastrando personaggi reali a figure immaginate, tracciando i segmenti di un mondo in fermento per quel che dall’expo si intravede del futuro, su cui però aleggiano le pulsioni cupe che dalla Germania prenazista si fanno largo in Europa L’antisemitismo per esempio. I due eroi per caso della storia, la giovane giornalista Ellen Grönblad e il poliziotto Nils Gunnarssonn, sono i tipi classici questo genere di romanzi, ma nelle mani dell’autrice quel che è scontato nei loro ruoli si alleggerisce, i luoghi comuni si tingono di una sottile ironia. E poi c’è Einstein, cui la Hermanson si dedica con singolare tenerezza involontario seduttore dai modi gentili, famoso come una star del cinema nonostante non sia mai uscito dalla sfera della scienza, ha la capacità di sciorinare al mondo una sua ammaliante delicatezza che gli viene forse da una prossimità così pura con la scadenza Interessante in merito il dialogo tra lui e Jung, in cui lo psichiatra coglie il senso della vertigine felice in cui è vissuto lo scienziato al tempo del lavoro sulla relatività. E ha la semplicità della fiaba, insieme a un che di visionario, l’incontro tra il genio e il ragazzo che conduce Bella lo scienziato che con dolcezza parla all’asina in una situazione sospesa, evoca con il suo tedesco gentile la lingua materna del ragazzo, che nella stessa lingua gli risponde in un dialogo fatto di niente e però risolutore. Come dire: tra la massima altezza d’ingegno e l’assoluta ignoranza corre un filo, invisibile per chi sta nelle regioni di mezzo.
Marta Morazzoni, Il Sole 24 Ore Domenica, 17 febbraio 2019
