Gli 80 anni di Claudio Magris
“Singer, amicizia indelebile”

Compie 80 anni Claudio Magris, il grande intellettuale, studioso e scrittore triestino che è stato tra i primi a riscoprire il filone di matrice ebraica nell’ambito dei capolavori che hanno raccontato la grandezza e il dissolvimento della Mitteleuropa.
Dalla sua Trieste, che lo festeggerà questo venerdì con la presentazione del suo ultimo libro “Tempo curvo a Krems” pubblicato da Garzanti alla Libreria Minerva, a Milano, dove uno speciale evento al Teatro Franco Parenti organizzata dalla Fondazione Corriere permetterà lunedì sera di ripercorrere volti, personaggi, piccoli e grandi momenti di una vita ricca di sfumature.
“La prima cosa che guardo sul giornale la mattina è la temperatura del mare” ha detto Magris in una intervista realizzata dal quotidiano triestino Il Piccolo per celebrare l’anniversario. “Il mare – sottolinea ancora Magris – è l’abbandono, la felicità. Non ho stile, non ho mai fatto scuola di nuoto, ma amo lasciarmi andare nelle braccia del mondo”.
Proprio al mare, a Barcola, un giovane germanista destinato al successo porta con sé un libro di racconti di Isaac Bashevis Singer, destinato in futuro a vincere il Premio Nobel ma ancora, in quei giorni, non così conosciuto. L’impatto, racconterà a Pagine Ebraiche, fu dirompente. E segnò l’inizio di una grande amicizia con lo scrittore maestro della letteratura yiddish. “Dopo la folgorazione di quelle pagine – ricostruiva infatti Magris – non ho aspettato nemmeno di rivestirmi e tornare a casa. Ho attraversato la strada Costiera per raggiungere la tabaccheria più vicina e comprare una cartolina e un francobollo, poi al tavolino di un caffè ho scritto a Singer indirizzando all’editore newyorkese Farrar Strauss, che più tardi sarebbe diventato il mio editore negli Usa”.
Stringenti e talvolta laceranti i temi evocati nelle sue interviste con il giornale dell’ebraismo italiano: dalle ferite che l’Europa si trascina dal Novecento, alla peculiare caratteristica di Trieste quale laboratorio di incontro tra identità diverse, al decadimento progressivo della società italiana.
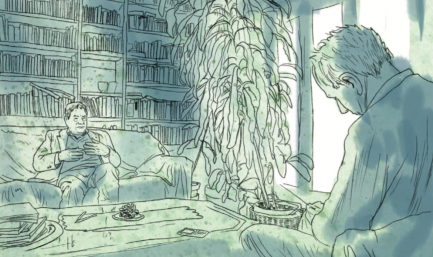 Una grande preoccupazione: “Che il dilagare della chiacchiera, il proliferare dei messaggi, il disperato accalcarsi di chi cerca visibilità, finisca per spegnere il valore della Parola”.
Una grande preoccupazione: “Che il dilagare della chiacchiera, il proliferare dei messaggi, il disperato accalcarsi di chi cerca visibilità, finisca per spegnere il valore della Parola”.
Chi non si è arreso prenda in mano anche quest’ultima sua fatica. Cinque i personaggi che ne sono protagonisti, raccontati con la consueta maestria. Ecco chi sono: “Il ricco e ormai vecchio industriale che inscena una beffarda ritirata dalla vita; il maestro di musica che dopo tanti anni rivede il proprio allievo in un incontro di ambigua ed elusiva crudeltà; il viaggiatore che, nella piccola e assopita cittadina di Krems, mosso da una coincidenza apparentemente insignificante, scopre il non tempo della vita e dell’amore in cui tutto è presente e simultaneo; il vecchio scrittore ospite d’onore di un premio che misura la propria estraneità al mondo e ai riti della letteratura; e infine il sopravvissuto della Grande Guerra e della grande stagione culturale della Trieste absburgica e irredentista che osserva le riprese di un film dedicato a una vicenda della sua giovinezza e di quella dei suoi amici stentando a riconoscere sé stesso e i propri compagni nei gesti e nelle battute degli attori che li interpretano”.
Una nuova prova di altissimo livello per il professor Magris e un compleanno da festeggiare insieme a tutti coloro che credono nei valori della cultura e dell’incontro. Anche attraverso le pagine di un libro.
Disegni di Giorgio Albertini
“I perseguitati hanno salvato la libertà del mondo”
 Fra le tante parole importate via terra o via mare o depositate dal vento in quel dialetto che si ostinano a parlare tutti, dai portuali agli scienziati, la parola “divorzio”, che dà nome a un intero trattato di Talmud, non poteva che venire dalle antiche terminologie ebraiche. E’ cosa naturale che alle porte di Trieste, nello stabilimento balneare più democratico del mondo, dove lungo le scogliere di Barcola che guardano a Miramare si mischia l’umanità più disparata, voli in tutta naturalezza sulle labbra delle casalinghe e degli impiegati in pausa di metà giornata, l’espressione “darghe el ‘ghet”. In mezzo a loro, per uno di quei mitici bagni cui non vuole rinunciare caschi il mondo, pare ne debba prendere un centinaio l’anno, c’era anche il professore. Mischiato alla folla che si contende un lembo di cemento per stendere l’asciugamano al sole, un grande germanista in costume da bagno lascia solo un segno che lo distingua dalla folla popolare: quello che si è portato da leggere. Isaac Bashevis Singer attendeva ancora il riconoscimento del Nobel e i suoi racconti, dove scorre in piena il fiume della grande letteratura classica, erano nelle mani di pochi intenditori. Sotto il sole di Trieste gli occhi di Claudio Magris si lasciarono incantare da uno di quei racconti “Colui che non era visto”, la storia di un ghet sbalorditivo, dove alla separazione seguirà l’impossibile e questa volta peccaminoso ritorno. L’emozione travolgente di un adulterio da vivere con la propria consorte. Nel raccontare queste pagine, nel ripercorrere l’intersecarsi delle sue strade di germanista e di letterato con le vie ebraiche della letteratura e della vita, Magris svela infine l’inizio di una importante amicizia con il grande scrittore yiddish.
Fra le tante parole importate via terra o via mare o depositate dal vento in quel dialetto che si ostinano a parlare tutti, dai portuali agli scienziati, la parola “divorzio”, che dà nome a un intero trattato di Talmud, non poteva che venire dalle antiche terminologie ebraiche. E’ cosa naturale che alle porte di Trieste, nello stabilimento balneare più democratico del mondo, dove lungo le scogliere di Barcola che guardano a Miramare si mischia l’umanità più disparata, voli in tutta naturalezza sulle labbra delle casalinghe e degli impiegati in pausa di metà giornata, l’espressione “darghe el ‘ghet”. In mezzo a loro, per uno di quei mitici bagni cui non vuole rinunciare caschi il mondo, pare ne debba prendere un centinaio l’anno, c’era anche il professore. Mischiato alla folla che si contende un lembo di cemento per stendere l’asciugamano al sole, un grande germanista in costume da bagno lascia solo un segno che lo distingua dalla folla popolare: quello che si è portato da leggere. Isaac Bashevis Singer attendeva ancora il riconoscimento del Nobel e i suoi racconti, dove scorre in piena il fiume della grande letteratura classica, erano nelle mani di pochi intenditori. Sotto il sole di Trieste gli occhi di Claudio Magris si lasciarono incantare da uno di quei racconti “Colui che non era visto”, la storia di un ghet sbalorditivo, dove alla separazione seguirà l’impossibile e questa volta peccaminoso ritorno. L’emozione travolgente di un adulterio da vivere con la propria consorte. Nel raccontare queste pagine, nel ripercorrere l’intersecarsi delle sue strade di germanista e di letterato con le vie ebraiche della letteratura e della vita, Magris svela infine l’inizio di una importante amicizia con il grande scrittore yiddish.
“Dopo la folgorazione di quelle pagine – racconta – non ho aspettato nemmeno di rivestirmi e tornare a casa. Ho attraversato la strada Costiera per raggiungere la tabaccheria più vicina e comprare una cartolina e un francobollo, poi al tavolino di un caffè ho scritto a Singer indirizzando all’editore newyorkese Farrar Strauss, che più tardi sarebbe diventato il mio editore negli Usa”.
Singer rispose? È nata così la vostra amicizia?
Certo, in pochi giorni ho avuto la risposta e in tempi brevi, prima negli Stati Uniti, poi durante le sue vacanze estive a Wengen, in Svizzera, abbiamo cominciato a incontrarci.
Cosa cercava in Singer?
All’inizio forse solo l’occasione di capire e di conoscere un grandissimo scrittore, ma forse anche la possibilità di comprendere quella cultura ebraica che ogni triestino ha in un modo o nell’altro l’occasione di incontrare.
Trieste capitale delle minoranze. È la particolarissima composizione sociale della città a favorire la conoscenza, o il suo immenso patrimonio culturale e letterario?
Nella mia esperienza in gioventù ha contato molto la conoscenza diretta, le amicizie, le persone incontrate al caffè. La cultura è venuta molto più tardi. Già da giovane sono stato un lettore appassionato. Ma come molti giovani triestini mi ero accuratamente tenuto a distanza dalla letteratura della mia città. Quando sono andato a studiare e insegnare a Torino mi occupavo della grande letteratura europea, ma lì ho preso in mano Svevo e Saba per la prima volta.
Perché solo allora?
Per la sofferenza di essere distante dalla mia città. Per il desiderio di comprenderla, ora che me ne ero distaccato.
Torniamo all’amicizia con Singer. Cosa vi siete detti?
Ho avuto l’impudenza di chiedergli come facesse a scrivere pagine indimenticabili, altissime, e altre, soprattutto in alcuni romanzi, talvolta noiose.
E lui?
Wittgenstein disse che esistono due categorie di scrittori, quelli che scrivono con il cervello e quelli che scrivono con la mano, in virtù di un dono naturale, di un istinto formidabile. Singer evidentemente scriveva d’istinto, scriveva con la mano, e mi rispose ridendo che lui non si domandava mai il perché del suo lavoro, scriveva quello che gli veniva e basta.
Eppure nei suoi primi saggi che hanno acceso anche in Italia la passione per il patrimonio letterario della Mitteleuropa, nel “Mito asburgico” e soprattutto in “Lontano da dove”, la chiave di lettura è Joseph Roth.
Roth è stato solo un pretesto, il tema di una grande riscoperta letteraria di quegli anni, la figura ideale dell’ebreo sradicato, in fuga. Ma in realtà era Singer che avevo in mente più di altri come modello letterario.
Come è entrato nel mondo culturale ebraico europeo che poi avrebbe finito per raccontare e insegnare?
A casa del mio maestro, il germanista torinese Leonello Vincenti. Sua moglie Frederike Guttman era un’ebrea tedesca che mi ha molto aiutato a comprendere lo stretto legame fra gli ebrei e i tedeschi. Lì ho cominciato a capire che l’antisemitismo tedesco, con quello che ne è seguito, è stato molto più di una bestialità. E’ stato un suicidio, la più profonda manifestazione di odio nei confronti di tutto quanto nel mondo di lingua tedesca rappresentasse un valore. E ho capito che attraverso il loro immenso sacrificio gli ebrei hanno salvato la libertà del mondo. Se il nazismo e il fascismo si fossero limitate ad essere una dittatura di destra, come per esempio il regime di Franco in Spagna, avrebbero probabilmente potuto godere della passività dell’Occidente e forse anche dell’appoggio degli ebrei reazionari. E sarebbero rimasti lì per chissà quanto tempo. Insomma, per queste vie ho imparato ad amare l’ironia e la libertà e a tenermi alla larga dall’idolatria.
Trieste è forse una delle città d’Europa che più hanno sofferto delle lacerazioni del Novecento. L’Europa in cui viviamo oggi, con la caduta delle barriere confinarie e monetarie, sembra un luogo più tranquillizzante?
Abbiamo compiuto grandi conquiste, ma anche fatto molti passi indietro. I propagandisti dell’odio rialzano la testa. I localismi strumentali sono strumentalizzati solo per alimentare le divisioni, mai le ricchezze culturali. “Una cosa è essere napoletano, una cosa è fare il napoletano”, mi ha detto una volta il mio amico Raffaele La Capria. La verità, cito l’autore bavarese Karl Valentin, è che “Il futuro non è più quello di una volta” e i giovani che possono godere di tanti progressi corrono il rischio di perdere il bene più prezioso, il gusto della speranza e degli ideali, l’idea che il mondo va cambiato e non solo amministrato.
L’Europa non può guarire dalle proprie ferite?
Una persona scarsamente consumista come me potrebbe consolarsi dicendo che Hitler è durato in definitiva meno del mio scaldabagno. Ma la verità è che l’Europa rischia di perdere il suo bene più prezioso, un sano senso di ipocrisia.
Professore, proprio lei che l’Italia pensante vede come una delle rare guide morali rimaste, vuole fare qui l’elogio dell’ipocrisia?
Certo. Vede, un mondo dove gli antisemiti tacciono le loro opinioni demenziali per il timore della riprovazione sociale è un mondo dove alcuni individui valgono davvero poco, ma la società nel suo complesso vale molto. Un mondo dove non sono portati a tacere è una società che non promette nulla di buono.
Gli ebrei italiani sono presenti continuamente sui giornali, ma quanti in effetti comprendono i loro valori e la loro cultura?
Gli ebrei italiani dovrebbero cercare amicizie certo in quella ristrettissima fascia della popolazione che conosce bene la loro storia e la loro identità e contemporaneamente nella grande componente dell’Italia che non li conosce per nulla. Il pregiudizio attecchisce dove aleggia la conoscenza superficiale, la nozione vaga, quello che si crede di sapere e che in realtà non si sa.
Presto sarà il Giorno della Memoria. Il suo recente intervento al Quirinale su questo argomento fu considerato da molti memorabile. Ma da allora su questo argomento lei ha preferito tacere. Perché?
È vero che ho declinato molti inviti a intervenire ancora. Quello che avevo da dire l’ho detto allora. Non voglio diventare l’oratore della Memoria che ogni anno va in giro a ripetere se stesso.
Se posso dare un suggerimento alle organizzazioni che si occupano di questi argomenti: siate selettivi, prendete poche iniziative e realizzatele con grande cura.
Lei è entrato in Senato nel 1994 eletto dalla coalizione triestina laica e progressista che cercò di contribuire all’opposizione al primo governo Berlusconi. La politica le manca? Ha pensato a ricandidarsi?
Accettare quell’incarico e vivere qualche tempo in quel mondo che non è il mio per me non è stato facile. Mi ci sono accostato da bravo scrittore triestino, con il complesso di Guglielmo Oberdan, che non voleva uccidere, ma morire. Sono come un omosessuale che per dare un suo contributo alla società fa violenza a se stesso e si sposa. Se poi per le circostanze della vita resta vedovo, non gli si può chiedere di risposarsi una seconda volta.
Che cosa teme?
Che il dilagare della chiacchiera, il proliferare dei messaggi, il disperato accalcarsi di chi cerca visibilità, finisca per spegnere il valore della Parola.
Guido Vitale, Pagine Ebraiche febbraio 2013
“Scrivo contro il trauma della Storia”
 Francoforte, ottobre 2009. Nel giorno in cui la Buchmesse, il massimo momento d’incontro dell’editoria mondiale, chiude i battenti, l’insigne germanista e scrittore Claudio Magris attraversa la piazza dove nel maggio del 1933 i nazisti bruciavano i libri, poi sale i gradini della Paulskirche, il tempio della democrazia tedesca, per accettare il Friedenspreis, primo italiano a ricevere il più prestigioso riconoscimento culturale europeo. Ai mille invitati che assieme al Nobel per la letteratura Herta Mueller lo accolgono calorosamente tocca un discorso d’accettazione del tutto inatteso, l’evocazione di un personaggio inquietante e per molti del tutto sconosciuto. “A Trieste – esordisce Magris – nei grandi capannoni e cortili di una vecchia caserma abbandonata, si possono vedere, affiancati o sparsi in disordine come carcasse di mostri marini lasciati su una spiaggia dal riflusso di un maremoto, carri armati, sommergibili squarciati, cannoni anticarro, autoblinde, aeroplani dall’ala fracassata; in altri vani si allineano relitti guerreschi più piccoli, gavette sfondate, cornette telefoniche da campo strappate, bossoli, elmetti, manifesti di guerra. Un tempo quello era il regno di un personaggio bizzarro, Diego de Henriquez…”.
Francoforte, ottobre 2009. Nel giorno in cui la Buchmesse, il massimo momento d’incontro dell’editoria mondiale, chiude i battenti, l’insigne germanista e scrittore Claudio Magris attraversa la piazza dove nel maggio del 1933 i nazisti bruciavano i libri, poi sale i gradini della Paulskirche, il tempio della democrazia tedesca, per accettare il Friedenspreis, primo italiano a ricevere il più prestigioso riconoscimento culturale europeo. Ai mille invitati che assieme al Nobel per la letteratura Herta Mueller lo accolgono calorosamente tocca un discorso d’accettazione del tutto inatteso, l’evocazione di un personaggio inquietante e per molti del tutto sconosciuto. “A Trieste – esordisce Magris – nei grandi capannoni e cortili di una vecchia caserma abbandonata, si possono vedere, affiancati o sparsi in disordine come carcasse di mostri marini lasciati su una spiaggia dal riflusso di un maremoto, carri armati, sommergibili squarciati, cannoni anticarro, autoblinde, aeroplani dall’ala fracassata; in altri vani si allineano relitti guerreschi più piccoli, gavette sfondate, cornette telefoniche da campo strappate, bossoli, elmetti, manifesti di guerra. Un tempo quello era il regno di un personaggio bizzarro, Diego de Henriquez…”.
Sei anni dopo, all’indomani della pubblicazione della sua più recente e probabilmente della sua più alta prova letteraria, il nostro incontro è ancora a Francoforte e ancora al margine della grande fiera dove l’editoria che conta si dà appuntamento. Il gruppo editoriale Mauri Spagnol, che controlla le edizioni Garzanti, sfoggia con orgoglio questo fresco di stampa Non luogo a procedere in cui Magris dà corpo all’ossessionante ombra del professor De Henriquez per poi prendere liberamente il largo della grande letteratura. Lasciamo ad altre pagine del giornale l’analisi di una prova letteraria di grande forza e di grande significato per il mondo ebraico e per tutti coloro che amano la libertà e la pace, e ascoltiamo il racconto dell’autore.
“La figura di De Henriquez che evocai allora a Francoforte – confessa Magris – mi assillava già al tempo e ha continuato a seguirmi in questi anni. Non luogo a procedere è dichiaratamente ispirato alla vita e al dramma di questo personaggio. Detto questo è però necessario chiarire che ho voluto scrivere un libro di creazione letteraria e di libero pensiero, non la biografia di un personaggio realmente esistito. Sarebbe arbitrario nei confronti di De Henriquez, che ebbe una vita estremamente complessa, e nei confronti di quello che ho scritto”.
Questo personaggio, professore, lei lo incontrò più volte.
Certo, l’ho incontrato. Mi veniva incontro negli ultimi anni della sua vita parlandomi in tedesco di tante sue ossessioni e di tante idee smisurate, del progetto di costruire un museo della guerra per la pace, di teorie scientifiche assai strampalate, della sua ossessione di annotare ogni dettaglio della vita reale. Quei dettagli che oggi si trovano nell’immenso corpus dei suoi diari.
Fu allora che cominciò a suscitare la sua curiosità?
A Trieste non è infrequente incontrare personaggi originali. Ma lui, che si occupava di collezionare armamenti pesanti e altre diavolerie, in realtà mi aiutò a comprendere meglio quello quello che aveva detto Svevo: non c’è nulla di più originale della vita. La vita è così originale che di inventare quasi ti passa la voglia.
Qualche esempio?
I Lager dell’Isola calva (Goli Otok) nell’alto Adriatico. Qui, a pochi passi dal confine italiano, nella Jugoslavia di Tito finirono non solo fascisti ustascia macchiatisi di orrendi crimini durante la Seconda guerra mondiale e alcuni delinquenti comuni, ma anche e soprattutto deportati politici e, quei comunisti, compagni nella lotta di resistenza partigiana contro nazismo e fascismo che, quando Tito nel 1948 ruppe con Stalin, erano rimasti fedeli, per fede nell’idea universale marxista, al comunismo ortodosso. Fra loro anche circa duemila italiani, militanti comunisti che avevano conosciuto le galere fasciste e i campi nazisti, che si erano battuti in Spagna contro Franco ed erano andati con entusiasmo in Jugoslavia per contribuire a edificare il socialismo nel Paese più vicino. In quell’inferno, sottoposti a maltrattamenti e torture, ignorati da tutti, resistettero eroicamente e paradossalmente in nome di Stalin, massimo inventore di Gulag. Quando, dopo alcuni anni, i superstiti furono liberati e tornarono in Italia, vennero tartassati dalla polizia quali pericolosi comunisti provenienti dall’Est e osteggiati dal Pci quali scomodi testimoni della politica stalinista del partito che si voleva dimenticare. Ma il supremo paradosso è che infine trovarono le loro abitazioni occupate dai profughi istriani, a loro volta giunti in Italia per fuggire alla dittatura.
Non è la sola terribile beffa del Novecento.
No di certo. E incessantemente la realtà mette in guardia la letteratura e travalica la fantasia. Nessuno avrebbe potuto inventare la conferenza di Wannsee e soprattutto chi avesse immaginato la Shoah sarebbe stato probabilmente preso per pazzo. È proprio la Shoah, l’orrore che non può essere assimilato ad alcun altro orrore, il punto più inimmaginabile dove la realtà ci ha condotti.
Eppure, come Non luogo a procedere mette in evidenza, neppure questo è bastato a metterci al riparo dall’odio e dalla guerra.
Proprio questa è la lezione che il Novecento ci ha riservato. La speranza tradita, l’ideale di una nuova umanità che avrebbe posto fine a ogni conflitto sono evidentemente idee destituite di fondamento. Anzi, direi che con lo scorrere del tempo viene a nudo una sempre maggiore mancanza di senso nelle cose. Parliamo di terza, di quarta guerra mondiale, ma non sappiamo più chi combatte contro chi. Assad, è un nostro nemico o un nostro amico? Le ondate di odio e distruzione cui stiamo assistendo, da cosa sono realmente originate? E dove possono condurci? E la filosofia, la letteratura tornano in gioco con i loro segnali inquietanti, dall’ideale dell’Ultrauomo di Nietsche alle catastrofiche previsioni di Svevo.
È il segno della fine degli ideali, delle speranze?
Una volta ho accompagnato alle porte di Trieste il grande storico austriaco Adam Wandruszka, in un cimitero militare austroungarico dove è sepolto suo padre, morto sul Carso per difendere i confini dell’Impero. Allora mi ha raccontato che partendo per il fronte il padre aveva lasciato alla moglie incinta il desiderio, se fosse nato un maschio, di dargli il nome del primo uomo. Da quella guerra, diceva con convinzione, sarebbe nato l’uomo nuovo, fraternamente amico di tutti gli altri, perché dopo quella guerra non ce ne sarebbero state mai più altre e il mondo sarebbe divenuto – o ritornato – un paradiso terrestre. Sappiamo tutti quello che è seguito.
E sappiamo che ancora e ancora di nuovo la realtà ha superato agevolmente la fantasia.
Se così non fosse non avremmo l’incubo del ritorno agli orrori del passato. Quello che avvenne cento anni fa con il primo conflitto mondiale portò direttamente alla Seconda guerra. Se la realtà non avesse sopravanzato la fantasia e il delirio hitleriano non avesse concepito il tentativo mostruoso e demenziale di distruggere il popolo ebraico, forse le dittature europee sarebbero rimaste al loro posto molto a lungo. La verità è che il popolo ebraico ha pagato per tutti e a costo di indicibili sofferenze il prezzo della nostra libertà portando da solo il peso della salvezza del mondo.
Si parla continuamente di Memoria, ma cosa dobbiamo davvero trasmettere ai giovani di quello che avvenne?
Dobbiamo dire loro che non si parla mai con chi ti punta il coltello alla gola. Non c’è posto per il pacifismo quando si affronta una minaccia mortale. Che quelli erano stati tempi, come ha spiegato Thomas Mann, in cui tutto era facile proprio perché tutto era difficile.
Che cosa intendeva dire, effettivamente, il massimo rappresentante dell’Altra Germania?
Mann disse ironicamente che gli anni della durissima opposizione alla dittatura furono i tempi più facili. Perché ogni scelta era chiara e chi voleva stare dalla parte della morale sapeva bene cosa scegliere.
Nei suoi recenti interventi proprio in relazione a Non luogo a procedere ha evocato i nomi di altri grandi personaggi ingiustamente dimenticati, come Elody Oblath, Enrico Rocca ed Ercole Miani.
È vero. Hanno rappresentato in pieno la tragedia di chi è costretto a scegliere fra la verità e la patria. La loro esistenza, il loro tragico destino, il conflitto insanabile fra amore per la patria, amore per la libertà, segno identitario. “Ogni nostra azione – scriveva Rocca, l’ebreo goriziano, forse il germanista più geniale e misconosciuto che ci fu donato e morì suicida nel 1944 di fronte alla vergogna della patria – è un seme di cui non si conosce il frutto”.
È questo il non luogo a procedere, l’enigma ultimo del libro?
Sul territorio della scrittura, per ripercorrere i nostri destini ho cercato di coniugare l’yiddish e il creolo. E in fondo volevo dire che la letteratura non è una parentesi nella vita, ma è una forza che cambia e trascina le esistenze. Può rappresentare la nostra ultima speranza, la nostra sola possibile via d’uscita, l’unica possibile derisione in faccia al male che ci opprime.
Guido Vitale, Pagine Ebraiche novembre 2015
(11 aprile 2019)
