Nomi
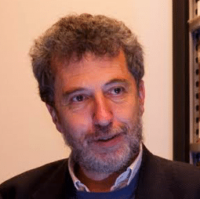 Fra le usanze di Yom Kippur nelle sinagoghe di Venezia (ma immagino ovunque) si recitano uno ad uno i nomi dei defunti che l’intera comunità decide di ricordare. Si inizia con i rabbini del passato, si continua con i parnassìm della sinagoga e con le personalità eminenti, per passare poi all’elenco dei nomi (chissà perché divisi fra maschi e femmine). Una volta erano anche scritti su fogli appesi ai grandi porta-ceri posti in loro ricordo di fronte all’Aron haKodesh, ma poi si è messo fine all’usanza per evidente pericolo d’incendio. Mentre il Hazàn, il cantore, legge quei nomi, la memoria si attiva, come accesa da un invisibile pulsante, e di fronte agli occhi si materializzano momenti vissuti, sorrisi, smorfie, figure con cappello (in sinagoga la kippà era un’eccezione!), voci. Più si va in là con l’età, più quei nomi provocano questo tipo di sensazione. Non dovrebbe essere una sensazione triste. Magari una sottile malinconia si intrufola qua e là perché si vorrebbe avere ancora l’occasione di incontrare gli amici e i conoscenti che nel passato hanno popolato quegli ambienti, si sono seduti sui banchi della sinagoga, hanno intonato in coro questa o quella melodia. Se la Sinagoga (come nel caso del Kippur che si è appena concluso) è ancora piena di persone e animata da bambini che corrono e giocano disturbando gioiosamente gli adulti in digiuno, la malinconia lascia il campo al realismo. Si vive la propria esistenza, si fa parte della Comunità, poi tutto passa. È la vita, si continua, fin dove si arriva. Ma resta quella sensazione bella di ricordo positivo di quelle figure evocate. Se si lasciano libere le redini alla fantasia, eccoli là quei nomi che ritornano in forme che strane connessioni delle nostre capricciose sinapsi ci permettono quasi di vedere. Il giovane rabbino dalla voce forte che cantava dalla Tevà; l’anziana signora che impastava i dolcetti di Pesach; le donne del coro che cantavano in coro anche quando il coro era stato abolito per decreto da non so quale Consiglio; lo Shammash che ancora portava la sua targa metallica a indicare il suo ruolo (i documenti d’archivio lo chiamavano lo “Scaccino”); l’infaticabile organizzatore e animatore del Séder di Pesach, la consigliera dell’ADEI, il segretario della Comunità, il Maestro e Hazàn che trovavi sia nelle grandi solennità, sia il venerdì sera nel tempietto della Casa di Riposo (che non c’è più). Potrei continuare all’infinito, ma sono immagini della mia mente e temo di annoiare. Quel che intendo dire è che quei nomi sono il segno di singolarità che hanno fatto nel passato quell’organismo collettivo che chiamiamo Comunità, Kehillà. Valorizzare quei nomi significa in qualche misura offrire un tributo alla continuità di quell’entità che ancora continua a vivere attorno all’esperienza comunitaria.
Fra le usanze di Yom Kippur nelle sinagoghe di Venezia (ma immagino ovunque) si recitano uno ad uno i nomi dei defunti che l’intera comunità decide di ricordare. Si inizia con i rabbini del passato, si continua con i parnassìm della sinagoga e con le personalità eminenti, per passare poi all’elenco dei nomi (chissà perché divisi fra maschi e femmine). Una volta erano anche scritti su fogli appesi ai grandi porta-ceri posti in loro ricordo di fronte all’Aron haKodesh, ma poi si è messo fine all’usanza per evidente pericolo d’incendio. Mentre il Hazàn, il cantore, legge quei nomi, la memoria si attiva, come accesa da un invisibile pulsante, e di fronte agli occhi si materializzano momenti vissuti, sorrisi, smorfie, figure con cappello (in sinagoga la kippà era un’eccezione!), voci. Più si va in là con l’età, più quei nomi provocano questo tipo di sensazione. Non dovrebbe essere una sensazione triste. Magari una sottile malinconia si intrufola qua e là perché si vorrebbe avere ancora l’occasione di incontrare gli amici e i conoscenti che nel passato hanno popolato quegli ambienti, si sono seduti sui banchi della sinagoga, hanno intonato in coro questa o quella melodia. Se la Sinagoga (come nel caso del Kippur che si è appena concluso) è ancora piena di persone e animata da bambini che corrono e giocano disturbando gioiosamente gli adulti in digiuno, la malinconia lascia il campo al realismo. Si vive la propria esistenza, si fa parte della Comunità, poi tutto passa. È la vita, si continua, fin dove si arriva. Ma resta quella sensazione bella di ricordo positivo di quelle figure evocate. Se si lasciano libere le redini alla fantasia, eccoli là quei nomi che ritornano in forme che strane connessioni delle nostre capricciose sinapsi ci permettono quasi di vedere. Il giovane rabbino dalla voce forte che cantava dalla Tevà; l’anziana signora che impastava i dolcetti di Pesach; le donne del coro che cantavano in coro anche quando il coro era stato abolito per decreto da non so quale Consiglio; lo Shammash che ancora portava la sua targa metallica a indicare il suo ruolo (i documenti d’archivio lo chiamavano lo “Scaccino”); l’infaticabile organizzatore e animatore del Séder di Pesach, la consigliera dell’ADEI, il segretario della Comunità, il Maestro e Hazàn che trovavi sia nelle grandi solennità, sia il venerdì sera nel tempietto della Casa di Riposo (che non c’è più). Potrei continuare all’infinito, ma sono immagini della mia mente e temo di annoiare. Quel che intendo dire è che quei nomi sono il segno di singolarità che hanno fatto nel passato quell’organismo collettivo che chiamiamo Comunità, Kehillà. Valorizzare quei nomi significa in qualche misura offrire un tributo alla continuità di quell’entità che ancora continua a vivere attorno all’esperienza comunitaria.
Per dare maggior concretezza a tutto ciò sono stati inventati degli strumenti che in qualche modo sopperiscono ai vuoti della memoria personale e collettiva, che spesso è fallace. Si chiamano Archivi. Non tutte le Comunità ne hanno uno, e comunque troppo spesso non destinano fondi per la loro conservazione. Ma esistono archivi più grandi e centralizzati. Io penso che se le famiglie ebraiche italiane facessero maggiore attenzione al patrimonio di documenti, fotografie, film, oggetti che hanno a disposizione e che sono appartenuti ai cari del passato, e se decidessero di depositare questo materiale in Archivi funzionanti e ordinati, compirebbero il più forte e significativo tributo alla memoria dei loro cari e aiuterebbero le nuove generazioni a conoscere meglio il recente passato. I nomi sono stati persone, e le persone si sono intrecciate in rapporti amicali, esperienze comuni, liti, amori e tutto quel che la vita produce. Nomi che hanno fatto le Comunità. Nomi che – se le loro foto e i loro documenti vengono catalogati in modo corretto – possono iniziare a comunicare fra loro, stabilendo connessioni sorprendenti che ci possono aiutare a vivere con maggiore consapevolezza il presente.
Gadi Luzzatto Voghera, Direttore Fondazione CDEC
