Anime, Neshamòth
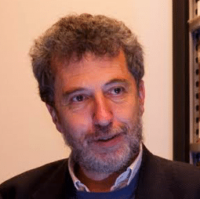 “E poi, quando ho toccato il fondo, mi hai mandato un raggio di sole. Non te l’ho chiesto io, non ti chiedevo più niente ormai, l’hai mandato Tu, di tua volontà, Tu e non un Serafino”. Sarebbe sufficiente questo breve, addolorato e furioso pensiero di Gimol che parla con Dio per cogliere la forza del romanzo Anime che ci ha regalato Roy Chen nella splendida traduzione di Bianca Ambrosio e Shulim Vogelmann (Giuntina 2022). La forza, ma anche la complessità dei linguaggi che si intrecciano con il ritmo incalzante della teatralità. Quel brano è un sottile ma potentissimo richiamo alla Haggadà di Pesach, là dove si scrive che fu Dio e non altri a compiere i miracoli per condurre gli ebrei fuori dall’Egitto. Lì è Dio che afferma fortemente la paternità dell’atto. Qui è l’Autore (impersonificato nella protagonista Gimol) a torcere verso Dio la stessa affermazione rinfacciandogli che è stato Lui, e non altri (tipo un Serafino, una tipologia di angeli che compare in Isaia VI, 1-2) a farle quel che ha fatto.
“E poi, quando ho toccato il fondo, mi hai mandato un raggio di sole. Non te l’ho chiesto io, non ti chiedevo più niente ormai, l’hai mandato Tu, di tua volontà, Tu e non un Serafino”. Sarebbe sufficiente questo breve, addolorato e furioso pensiero di Gimol che parla con Dio per cogliere la forza del romanzo Anime che ci ha regalato Roy Chen nella splendida traduzione di Bianca Ambrosio e Shulim Vogelmann (Giuntina 2022). La forza, ma anche la complessità dei linguaggi che si intrecciano con il ritmo incalzante della teatralità. Quel brano è un sottile ma potentissimo richiamo alla Haggadà di Pesach, là dove si scrive che fu Dio e non altri a compiere i miracoli per condurre gli ebrei fuori dall’Egitto. Lì è Dio che afferma fortemente la paternità dell’atto. Qui è l’Autore (impersonificato nella protagonista Gimol) a torcere verso Dio la stessa affermazione rinfacciandogli che è stato Lui, e non altri (tipo un Serafino, una tipologia di angeli che compare in Isaia VI, 1-2) a farle quel che ha fatto.
Anche non conoscendo la Haggadà, la potenza della scrittura di Roy Chen resta impressionante. Un percorso immaginifico che segue il mistico rotolamento delle anime (in ebraico suona meglio, “ghilgùl neshamòt”) che secondo una particolare visione mistica si reincarnerebbero nel corso delle generazioni in cerca di pace. Si tratta della storia di Ghetz e della sorella Ghittel che dalla Podolia del Seicento si trasferiscono a Venezia nel Settecento vestendo i panni di Ghedalia e Gheyle per poi trovarsi nel Marocco dell’Ottocento invertendo i generi e amandosi (in maniera incestuosa?) nei panni di Gimol e Gavriel. Per poi terminare nella Shoah con Gretchen. Il tutto dovrebbe essere scritto e pensato da Grisha a Giaffa nel 2000 (o forse è Gershon, deciderete voi), un ragazzo di origine russa decisamente disadattato nell’Israele contemporanea alle prese con una madre non ebrea che si comporta come la più perfetta delle “yiddishe mame”.
Una scrittura raffinata, derivata da un lungo lavoro sui testi di teatro, che interpella direttamente il lettore trasformandolo da subito in protagonista del libro. Anche noi siamo “anime” (ci chiama così, chiedendoci in maniera sorniona di rintracciare in noi stessi le profonde origini dell’Io di ognuno/a) e siamo chiamati a partecipare del vissuto scomodo del protagonista di questa storia che si dipana lungo quattro secoli. Perfino quando l’Autore si permette qualche cliché (il carnevale di Venezia o qualche spiegazione didascalica sulle usanze dell’ebraismo marocchino), lo sguardo viene strappato quasi a forza da avvenimenti improvvisi o da riflessioni profonde che lasciano trasparire una notevole capacità di maneggiare sia le Scritture sia la letteratura, quella russa in particolare (ho l’impressione che Bulgakov stia lì, appollaiato da qualche parte, a ridacchiare soddisfatto di questo bravo allievo israeliano del Ventunesimo secolo).
Il lettore o la lettrice possono anche decidere di smettere di leggere. La madre di Grisha ve lo impone con il suo ebraico stentato, nel tentativo di salvare il povero figlio allucinato (ci dà dei “pornografi delle anime”). “Quindi ora voi chiudete il libro come abbiamo detto, sì? – ci intima – Non apritelo più, è finita. Grazie che voi capite. E scusate”. Ma voi continuate a leggere, siete solo a pagina ottantaquattro, ne vale la pena.
Gadi Luzzatto Voghera, Direttore Fondazione CDEC
