La continuità ebraica
e il ruolo dell’educazione
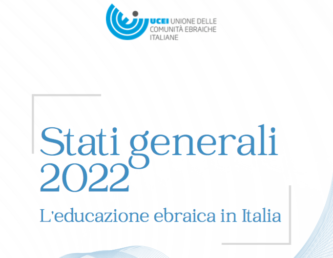 Si svolgerà a partire da domenica una nuova edizione degli Stati Generali dell’ebraismo italiano, interamente incentrata sul tema dell’educazione. Tra i temi che saranno affrontati “La continuità ebraica e il ruolo dell’educazione”, “L’approccio UCEI e la rete istituzionale”, “Il ruolo d’Israele nell’educazione ebraica nella Diaspora”, “Come adattare la conoscenza alle sfide di un mondo che cambia”, “Le scuole ebraiche: quale mission?”, “La formazione rabbinica e i percorsi di studi ebraici superiori”, “Giovani, formazione e identità ebraica”, “Percorsi di educazione e formazione ebraica”. Pubblichiamo di seguito un’anticipazione dall’intervento del rav Roberto Della Rocca, direttore dell’area Educazione e Cultura UCEI.
Si svolgerà a partire da domenica una nuova edizione degli Stati Generali dell’ebraismo italiano, interamente incentrata sul tema dell’educazione. Tra i temi che saranno affrontati “La continuità ebraica e il ruolo dell’educazione”, “L’approccio UCEI e la rete istituzionale”, “Il ruolo d’Israele nell’educazione ebraica nella Diaspora”, “Come adattare la conoscenza alle sfide di un mondo che cambia”, “Le scuole ebraiche: quale mission?”, “La formazione rabbinica e i percorsi di studi ebraici superiori”, “Giovani, formazione e identità ebraica”, “Percorsi di educazione e formazione ebraica”. Pubblichiamo di seguito un’anticipazione dall’intervento del rav Roberto Della Rocca, direttore dell’area Educazione e Cultura UCEI.
La continuità ebraica e il ruolo dell’educazione
VeShinnantam leVanekha VeDibarta bam… le ripeterai ai tuoi figli e ne parlerai con loro… (Deuteronomio 6, 7) veLimadtem otam ‘et benekhem leDaber bam… le insegnerete ai vostri figli parlandone stando in casa e andando per strada, quando sarai coricato e quando sarai alzato…(Deuteronomio 11, 19).
Nei due brani suindicati dello Shemà, il cui testo è parte integrale della Torà, ricorre l’imperativo di “insegnare”. In questa direttiva è racchiuso uno dei temi principali dell’ebraismo, l’educazione, ed in essa ravvisiamo uno dei cardini della “tradizione”. La tradizione, infatti, è necessariamente basata sull’insegnamento, ovvero la ripetizione di concetti, regole di comportamento e usi, finalizzata alla formazione di un’identità ebraica consapevole. La radice verbale di shinnantam è shanà, vale a dire ripetere per ricordare; la radice di limadtem è invece lamad, che nella forma intensiva ha proprio il significato di insegnare. Ciò che va assolutamente sottolineato è come questa disposizione dello Shemà sia rivolta ai genitori, elemento base della società e primo anello della catena della tradizione.
L’educazione ebraica passa dunque per lo studio, che ha il duplice fine di conoscere la Torà e i suoi dettami, e nel contempo di insegnare ciò che si impara, perché la conoscenza non sia un privilegio di pochi, e perché nell’istruzione generale si cresca nel rispetto sociale e umano. È peraltro importante comprendere come l’obbligo dello studio sia legato alla natura complessa e particolare della struttura religiosa, la quale conduce a una sorta di intellettualismo etico per cui “l’ignorante non può essere pio”. Non bastano il sentimento, la fede e la pratica, ma è indispensabile la continua verifica intellettuale. Ed è in questa linea che la tradizione ebraica, mentre pone lo studio a norma fondante, conclude con il principio che, in rapporto ai precetti, “lo studio della Torà vale come tutti gli altri messi insieme”.
Tornando ai versi dello Shemà sopra indicati, vogliamo evidenziare come l’imperativo di ripetere – insegnare (Deuteronomio 6, 7 e Deuteronomio 11, 19) è seguito in ambedue i passaggi dall’espressione vedibarta bam (e ne parlerai con loro), che pone l’accento su un insegnamento mnemonico (ripetere per ricordare) caratterizzato dal dialogo, e sull’invito a fornire un’istruzione aperta all’interrogativo da parte dei figli. In questo modo si rende chiara la differenza fra istruzione e insegnamento: non si trasmettono ai figli solo una serie di informazioni e di nozioni, ma si parla con loro dell’essere ebreo, fornendo nel contempo gli strumenti perché comprendano, attraverso il dialogo, stimolando l’elaborazione autonoma di ciò che viene raccontato, delineando quel passaggio importante e necessario dall’insegnamento alla cultura. Difatti si comanda di insegnare per parlare con i figli, ovvero per confrontarsi, perché l’educazione impartita divenga matura per il confronto, altro aspetto cardinale dell’educazione ebraica. Inoltre si evidenzia così come nell’ebraismo la cultura non è fissità, non è un rigido dogma, ma è convivenza e raffronto fra le contraddizioni, punto di partenza e stimolo per la ricerca di nuovi significati, un invito a proseguire. Questa prosecuzione, questo anello fondamentale della catena della tradizione si appoggia in modo importante sul passaggio genitori–figli, scegliendo come argomento preferito di dibattito le parole della Torà. Uno studio dinamico che si svolge “…Stando in casa e andando per strada…” (Deuteronomio 6, 7), ovvero partendo da una dimensione statica, che fornisce punti fissi, i quali – attraverso un processo evolutivo – trovano la propria validità nel dinamismo, che si esprime nel confronto con la strada, nell’incontro con la società circostante. E ancora: “…quando sarai coricato e quando sarai alzato…(Deuteronomio 11, 19), cioè sia nei momenti di crisi che in quelli di benessere, ove la crisi di valori può essere latente.
L’ebraismo è un sistema di vita basato tutto sull’azione, una cultura che si esprime attraverso dei comportamenti; è difficile poter comprendere pienamente questo tipo di cultura, se l’approccio si ferma ad una valutazione esterna teorica.
Anche la solidarietà e la giustizia sociale devono iniziare nelle nostre mura. Non possiamo pretendere rispetto dagli altri se non siamo capaci di rispettare noi stessi. La solidarietà è una cosa concreta e quotidiana, presente nei piccoli gesti.
Infatti l’ebraismo non vede una dicotomia tra forma e sostanza, ma ogni forma è veicolo di sostanza. Quest’ultimo è uno dei punti centrali del sistema educativo ebraico, che prevede un approccio empirico e pragmatico per la comprensione piena dei valori che vengono trasmessi. Non si parte dal presupposto della condivisione intellettuale di ciò che viene insegnato, ma questa si realizza attraverso la personale esperienza del concetto etico. In tal modo si comprende il valore educativo e morale dell’azione, attraverso la sua stessa messa in atto. È in questo prospettiva che va intesa la risposta corale del popolo alle falde del monte Sinai, quando di fronte alla promulgazione della Torà affermò: “Faremo e ascolteremo” (Esodo 24, 7).
Nel Talmud (Bavà Batrà, 116a) troviamo scritto: “Non esistono libri migliori dei figli istruiti nella Torà”. Vale a dire che il testo scritto non è dotato in sé di parola o forza di azione, non è realmente vivo, perché è attraverso l’uomo che lo realizza mettendolo in pratica e studiandolo, che se ne manifesta la vitalità, identicamente come la vita dei figli prosegue quella dei genitori. Nei rapporti tra genitori e figli nessuna mitzwà, precetto, è più importante di quella di insegnare ai figli Torà, patrimonio che ha permesso al popolo ebraico di mantenersi tale nel corso dei secoli. Essa, venendo trasmessa di generazione in generazione, prende forma concreta nelle azioni dell’individuo, dando luogo a un prodotto educativo comune. Il continuo rinnovarsi è visibile nello stesso studio della Torà, che per l’ebraismo è ricerca continua, la quale mai pretende di dire l’ultima parola definitiva; una ricerca in cui nulla è acquisito per sempre.
Un midrash, parabola rabbinica racconta che fino al momento della nostra nascita conosciamo interamente la Torà, poi – mentre usciamo dal grembo materno – un angelo ci colpisce sulla bocca e ci fa dimenticare tutto. Questo ci dice che se in parte la Torà è per noi qualcosa di innato, è pur vero tuttavia che ancora più importante è lo sforzo che dobbiamo fare giorno per giorno per riacquisire tale patrimonio; pertanto la nostra vita sarà all’insegna della ricerca di questa memoria.
Rav Roberto Della Rocca, direttore area Educazione e Cultura UCEI
(24 novembre 2022)
