SCAFFALE – Il forno di Akhai e la ricostruzione
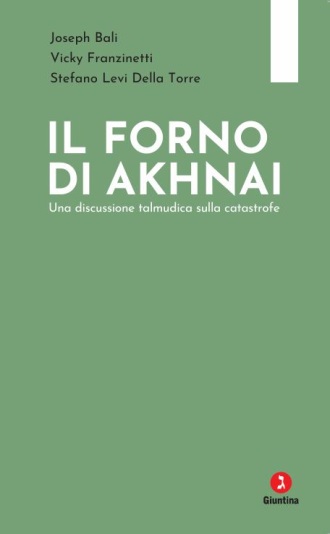 Uno dei passi talmudici più conosciuti, citati e commentati, anche tra i non specialisti, è quello relativo alla disputa tra i due rabbini Eliezer e Yehoshua, tramandato nel Talmud Babilonese (Baba Metzia [“la porta di mezzo”]59b). Il racconto è noto. Tra i due saggi studiosi nasce una discussione riguardo alla possibilità di utilizzare un forno, di proprietà di un tale Akhnai, tagliato in formelle sigillate con sabbia. È puro o impuro? Può essere utilizzato per cuocere gli alimenti? Yehoshua, insieme alla maggioranza degli altri saggi, ritiene che sia impuro, ma Eliezer è di parere opposto. Non riuscendo a convincere gli altri, cerca di piegarne l’opinione con l’evidenza di qualche evento prodigioso, che si ritiene capace di ottenere. «La mia ragione sia dimostrata da questo albero di carrubo». E l’albero di carrubo, effettivamente, si sposta. Eliezer immagina di avere quindi vinto la disputa, ma Yehoshua e gli altri non demordono: «Perché un albero di carrubo dovrebbe farci cambiare idea?». Eliezer insiste: «La mia ragione sia dimostrata da questo ruscello». E il ruscello inverte la sua corrente. Ma ciò non basta a Yehoshua e agli altri: «Perché un ruscello dovrebbe farci cambiare idea?». Allora Eliezer chiama a “testimoni” della sua “verità” le pareti della stanza in cui si trovano i rabbini, le quali si inclinano effettivamente, perdendo calcinacci e minacciando di crollare sui presenti. Ma neanche questo basta a fara cambiare idea ai suoi avversari, e Yehoshua intima alle pareti della stanza di non immischiarsi in una disputa che non le riguarda. Allora Eliezer, presumibilmente esasperato, chiama a testimoniare in suo favore una non meglio specificata “voce dal cielo”. La voce dal cielo parla, e gli dà ragione, ma neanche questo convince Yehoshua: «Cosa c’entra una voce dal cielo?». Dal cielo non può arrivare nessuna voce “vincolante”, perché, come scritto nel Deuteronomio (30.12), lo bashamàim hi, “essa (la Torah) non è (più) in cielo”.
Uno dei passi talmudici più conosciuti, citati e commentati, anche tra i non specialisti, è quello relativo alla disputa tra i due rabbini Eliezer e Yehoshua, tramandato nel Talmud Babilonese (Baba Metzia [“la porta di mezzo”]59b). Il racconto è noto. Tra i due saggi studiosi nasce una discussione riguardo alla possibilità di utilizzare un forno, di proprietà di un tale Akhnai, tagliato in formelle sigillate con sabbia. È puro o impuro? Può essere utilizzato per cuocere gli alimenti? Yehoshua, insieme alla maggioranza degli altri saggi, ritiene che sia impuro, ma Eliezer è di parere opposto. Non riuscendo a convincere gli altri, cerca di piegarne l’opinione con l’evidenza di qualche evento prodigioso, che si ritiene capace di ottenere. «La mia ragione sia dimostrata da questo albero di carrubo». E l’albero di carrubo, effettivamente, si sposta. Eliezer immagina di avere quindi vinto la disputa, ma Yehoshua e gli altri non demordono: «Perché un albero di carrubo dovrebbe farci cambiare idea?». Eliezer insiste: «La mia ragione sia dimostrata da questo ruscello». E il ruscello inverte la sua corrente. Ma ciò non basta a Yehoshua e agli altri: «Perché un ruscello dovrebbe farci cambiare idea?». Allora Eliezer chiama a “testimoni” della sua “verità” le pareti della stanza in cui si trovano i rabbini, le quali si inclinano effettivamente, perdendo calcinacci e minacciando di crollare sui presenti. Ma neanche questo basta a fara cambiare idea ai suoi avversari, e Yehoshua intima alle pareti della stanza di non immischiarsi in una disputa che non le riguarda. Allora Eliezer, presumibilmente esasperato, chiama a testimoniare in suo favore una non meglio specificata “voce dal cielo”. La voce dal cielo parla, e gli dà ragione, ma neanche questo convince Yehoshua: «Cosa c’entra una voce dal cielo?». Dal cielo non può arrivare nessuna voce “vincolante”, perché, come scritto nel Deuteronomio (30.12), lo bashamàim hi, “essa (la Torah) non è (più) in cielo”.
Il brano è sempre citato come emblematica e definitiva dimostrazione dell’assoluta libertà della interpretazione umana della volontà divina. Tale volontà è stata comunicata agli uomini con la Torah, ma nessuno, neanche una “voce dal cielo”, può vincolarne l’interpretazione, perché essa, appunto, “non è più in cielo”, è stata affidata alla libera coscienza e intelligenza degli uomini, di ogni singolo uomo.
A tale famoso racconto, e ai molteplici significati che da esso si possono evincere, è dedicato un libro di grande interesse, appena ripubblicato – in considerazione del successo raggiunto dalla precedente – in una nuova edizione: Il forno di Akhnai. Una discussione talmudica sulla catastrofe, di Joseph Bali, Vicky Franzinetti e Stefano Levi Della Torre, nuova ed. la Giuntina, Firenze, 2025, con illustrazioni di Levi Della Torre, pp. 252, euro 18).
La chiave di lettura principale offerta dal volume è quella di collegare il passo talmudico all’epoca storica nella quale la disputa si sarebbe verificata, ossia i tempi immediatamente successivi alla caduta di Gerusalemme del 70 E.V. Secondo la tradizione, com’è noto, il saggio studioso Yochanan ben Zakkai, vittima, insieme al suo popolo, dell’assedio della città santa da parte dell’esercito romano, ma ostile alla scelta degli zeloti di sfidare la potenza di Roma, presago della fine imminente, avrebbe chiesto e ottenuto dal futuro imperatore Vespasiano di lasciare la città assediata, per fondare un’accademia di studi a Yavne. Ottenuto il permesso dal comandante nemico, per ingannare i suoi connazionali, avrebbe lasciato la città, come il Conte di Montecristo, nascosto in una bara, portata fuori le mura dai suoi due discepoli Eliezer e Yehoshua, protagonisti della disputa. Il racconto, quindi, è collocato cronologicamente subito dopo una catastrofe, ed è in questa dimensione che viene interpretato dagli autori: «Lo sfondo su cui si svolge questo racconto è una mutazione storica, e il problema che abbraccia tutti gli altri problemi che andremo dipanando è il seguente: che via pendere dopo una catastrofe, come garantire la continuità attraverso una trasformazione imposta da una sconfitta disastrosa?» (p. 9).
In genere la disputa tra di due saggi, e la risposta di Yehoshua, vengono lette come emblematico suggello del libero pensiero e dell’insindacabilità dell’umana interpretazione della Legge. Essa “non è più in cielo”, e quindi nessuno, neanche una voce celeste, può renderne obbligatorio e vincolante un determinato significato ad essa attribuito. Il libero confronto tra le varie opinioni non è solo segno di libertà, ma anche premessa di futuro, perché è proprio sul dialogo e la contraddizione che si fonda il domani, laddove la fedeltà acritica alla tradizione cristallizza sul passato e sulla ripetizione: «Nel dare tutte le risposte, rabbi Eliezer non si era già posto al di fuori dell’ambito dell’interpretazione, del suo movimento, della sua variazione?» (p. 31).
Se avesse prevalso l’opinione di Eliezer, non ci sarebbe più stato nulla da discutere “dor le dor”, “di generazione di generazione”. In questo senso, Eliezer sembra quasi un “protocristiano”, dal momento in cui “chiude” la discissione richiamando una superiore e inappellabile volontà celeste, laddove Yehoshua avrebbe rappresentato la fedeltà a un principio di “laicità” che avrebbe prevalso, diventando per secoli l’essenza del pensiero rabbinico.
Naturalmente, la pagina talmudica è stata scritta in un’età successiva a quella della catastrofe. Ma è tuttavia significativo che il dialogo sia collegato alla sciagura, della quale non sminuisce certo la portata distruttiva, ma offre una via di elaborazione. È proprio la catastrofe a imporre uno sforzo di ricostruzione, che chiama l’uomo a spiegare, nella sua finitezza e solitudine, la propria libertà, autonomia e responsabilità.
Francesco Lucrezi, storico
