Sacks e la ragionevole speranza nel futuro

A cinque anni dalla morte sono in uscita altrettanti libri per condividere il lascito spirituale e filosofico di rav Jonathan Sacks (1948-2020) in quanto «figura religiosa riconosciuta a livello mondiale, un filosofo e una voce morale del nostro tempo». È la sfida dell’operazione editoriale Alleanza e conversazione promossa da Giuntina, che ha tradotto le interpretazioni distillate dall’ex rabbino capo d’Inghilterra e del Commonwealth attorno ai cinque libri della Torah con l’idea che rappresentino «uno dei contributi più significativi al pensiero ebraico contemporaneo».
Sacks è stato autore di oltre 25 libri, molti di successo, due dei quali già nel catalogo dell’editore: Non nel nome di Dio, sui pericoli dell’estremismo religioso, in cui l’autorevole Maestro ricordava come «troppo spesso nella storia della religione le persone hanno ucciso nel nome del Dio della vita, mosso guerra nel nome del Dio della pace, odiato nel nome del Dio dell’amore e praticato la crudeltà nel nome del Dio della compassione». E Moralità, tra le cui pagine Sacks si interroga su come ristabilire il bene comune in un tempo di fratture e lacerazioni, promuovendo un messaggio non di ingenuo ottimismo ma di ragionevole speranza nel futuro. La Torah fu in questo senso la sua stella polare.
E la nuova collana, secondo Giuntina, esprime il cuore del suo approccio: «L’alleanza come legame che unisce l’essere umano a un principio superiore, la conversazione come il dialogo continuo tra le generazioni e tra visioni diverse del mondo». Alleanza e conversazione è quindi un invito a leggere la Torah «non solo come testo fondativo della tradizione ebraica, ma come parte di una più ampia riflessione sull’etica, sulla responsabilità e sul significato dell’esistenza».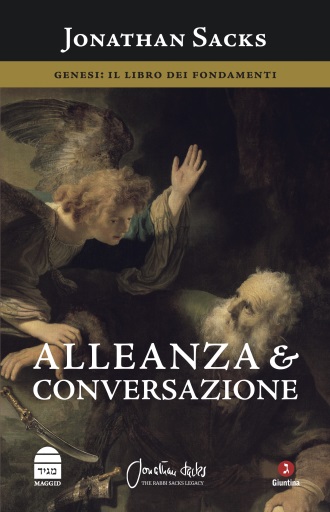 Il progetto si apre naturalmente con Genesi, in libreria da venerdì 12 settembre. Seguiranno, con uscita cadenzata ogni tre mesi, gli altri quattro libri: Esodo (12 dicembre), Levitico (13 marzo), Numeri (12 giugno) e Deuteronomio (di nuovo un 12 settembre). «L’idea di pubblicare questi cinque volumi nasce dalla percezione che, nel mondo ebraico italiano, e non solo, ci sia un già consolidato rapporto tra i lettori e Sacks. Un rapporto che definirei quasi affettivo», spiega a Pagine Ebraiche l’editore Shulim Vogelmann. «Sacks era una voce morale, in grado di parlare con chiarezza; da un lato esprimendo un’identità forte, dall’altro attraverso una formidabile capacità di universalizzare i propri messaggi per un pubblico ampio». Secondo Vogelmann, «in questo periodo oggettivamente difficile la sua voce manca al dibattito, soprattutto alla luce della frattura che si osserva tra il mondo ebraico e una parte della società; a un certo punto ci sarà il bisogno di ricostruire dei ponti e almeno a livello editoriale questo è un tassello in quella direzione». Anche perché «la Genesi, come tutta la Torah, è un testo condiviso e quindi un tramite per la riconciliazione».
Il progetto si apre naturalmente con Genesi, in libreria da venerdì 12 settembre. Seguiranno, con uscita cadenzata ogni tre mesi, gli altri quattro libri: Esodo (12 dicembre), Levitico (13 marzo), Numeri (12 giugno) e Deuteronomio (di nuovo un 12 settembre). «L’idea di pubblicare questi cinque volumi nasce dalla percezione che, nel mondo ebraico italiano, e non solo, ci sia un già consolidato rapporto tra i lettori e Sacks. Un rapporto che definirei quasi affettivo», spiega a Pagine Ebraiche l’editore Shulim Vogelmann. «Sacks era una voce morale, in grado di parlare con chiarezza; da un lato esprimendo un’identità forte, dall’altro attraverso una formidabile capacità di universalizzare i propri messaggi per un pubblico ampio». Secondo Vogelmann, «in questo periodo oggettivamente difficile la sua voce manca al dibattito, soprattutto alla luce della frattura che si osserva tra il mondo ebraico e una parte della società; a un certo punto ci sarà il bisogno di ricostruire dei ponti e almeno a livello editoriale questo è un tassello in quella direzione». Anche perché «la Genesi, come tutta la Torah, è un testo condiviso e quindi un tramite per la riconciliazione».
La collana dedicata a Sacks ha il sostegno del progetto di traduzione del Talmud babilonese in italiano «e si colloca pertanto in un filone di pubblicazioni per portare all’attenzione di lettori non solo ebrei i pilastri di questa cultura e tradizione», prosegue l’editore. «Sacks l’ha fatto per tutta la sua vita in modo magistrale e ne sono una prova le numerose attestazioni ricevute per la profondità del suo pensiero e la sua capacità di essere sempre attuale». Capacità riconosciuta anche da ben 16 lauree honoris causa e dal titolo di barone conferitogli da parte della regina Elisabetta.
Parlando con Pagine Ebraiche in occasione di una sua visita a Roma nel dicembre del 2011, il rav aveva ricordato come nella tradizione ebraica la parola abbia sempre avuto un ruolo centrale. Come in Bereshit/ Genesi, per l’appunto, «quando si parla della celebre Torre di Babele e la confusione delle lingue». O ancora quando nella Torah «si fa riferimento all’odio dei fratelli verso Giuseppe e viene sottolineata la necessità di “Ledaber be shalom”, parlare in modo pacifico». Il linguaggio e le parole, sottolineava il rav, «fanno parte del destino degli ebrei».
Sono le parole della Genesi in primo luogo, il principio di tutto secondo la Tradizione ebraica. Nel primo dei cinque libri della Torah, il rav definisce il celeberrimo passaggio «Dio creò l’uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li creò»come l’idea «forse più rivoluzionaria nell’intera storia del pensiero morale e politico»: si tratta, infatti, di un principio alla base della civiltà occidentale «con la sua enfasi unica sull’individuo e sull’uguaglianza», ripreso non a caso nella Dichiarazione d’Indipendenza americana. Le affermazioni rivoluzionarie, spiega ancora Sacks citando La guida dei perplessi di Maimonide, «non compiono la loro magia» dall’oggi al domani, ma con gradualità.
La Torah stessa ne è un esempio. Non abolì la schiavitù, ma diede il via a una serie di sviluppi, in particolare lo Shabbat, quando tutte le gerarchie di potere furono sospese e gli schiavi ebbero un giorno di libertà a settimana, «che erano destinati a portare alla sua abolizione nel corso del tempo».
Adam Smulevich
