Memoria 4 – ‘Dopo l’ultimo testimone’ Non basterà dire: “Mai più!”
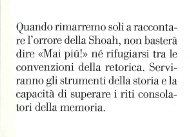 Arriva in questi giorni nelle librerie l’ultimo libro di David Bidussa. “Dopo l’ultimo testimone” (Einaudi, 132 pagine, 10 euro) costituisce un’opera breve ma preziosa, straordinariamente densa e ricca di indicazioni e stimoli per comprendere e ridefinire il rapporto fra la Shoah e noi. Nelle prossime settimane sarà certamente al centro del dibattito, sul fronte ebraico e su quello di tutta la società civile. Per offrire al lettore un primo spunto di conoscenza abbiamo scelto alcuni brani:
Arriva in questi giorni nelle librerie l’ultimo libro di David Bidussa. “Dopo l’ultimo testimone” (Einaudi, 132 pagine, 10 euro) costituisce un’opera breve ma preziosa, straordinariamente densa e ricca di indicazioni e stimoli per comprendere e ridefinire il rapporto fra la Shoah e noi. Nelle prossime settimane sarà certamente al centro del dibattito, sul fronte ebraico e su quello di tutta la società civile. Per offrire al lettore un primo spunto di conoscenza abbiamo scelto alcuni brani:
Tratto dal secondo capitolo “L’età della postmemoria”
(…)Nell’atto di testimonianza all’epoca della sua visualizzazione ciò che prevale è l’estetica. Su quest’aspetto ha posto l’accento Annette Wieviorka quando ha sottolineato come il ruolo della testimonianza in relazione alle vicende legate al genocidio ebraico abbia subito lente trasformazioni nel corso del tempo.
Dapprima il testimone si colloca nella posizione di depositano della storia «a futura memoria». Non si tratta solo di raccontare la resistenza o la cronaca della spoliazione dei ghetti e poi della loro distruzione, ma anche di descrivere i conflitti interni al mondo delle vittime. Ci vorranno decenni perché lentamente si prenda coscienza delle articolazioni della zona grigia, ma il fatto che oggi siamo in grado di vedere la dinamica della distruzione degli ebrei d’Europa è anche dovuto all’opera dei memorialisti che nello stesso momento in cui avveniva lo sterminio, tra il 1942 e il 1944, hanno cercato di costruire a «futura memoria» anche la propria autodifesa.
Dunque il testimone di primo tipo è un testimone oculare, e di solito la sua testimonianza è un testo scritto, perché egli è stato fisicamente travolto con il crollo del mondo stesso che sta descrivendo.
C’è poi un secondo tipo di testimone, secondo Wieviorka, rappresentato dal sopravvissuto. Si tratta di un testimone oculare coinvolto nel processo di distruzione a cui però è sopravvissuto. Questo secondo tipo di testimone ha essenzialmente i problemi del reinserimento e della dissimulazione. Quei temi che caratterizzano il testimone del primo tipo — ovvero la consapevolezza della distruzione collettiva e del «crollo di un mondo» —, emergono successivamente. Solo coi tempo i temi e i segni del disadattamento riaffioreranno e saranno le storie e le riflessioni di Jean Améry, Primo Levi, Paul Celan.
Ma perché questo malessere insorga devono operarsi una separazione e una contrapposizione sul problema della testimonianza. E il terzo livello o la terza figura del testimone. Questa volta il testimone non è più una voce del passato, ma è contemporaneamente la voce di un’esperienza vissuta — e dunque finita — e la narrazione di una «nuova vita». E ciò che Wieviorka denomina con il termine di « americanizzazione» e che a suo giudizio include un doppio passaggio: un sistema della comunicazione in cui la testimonianza non è più un processo selettivo ma accumulativo e l’astoricità della narrazione. Quest’ultimo aspetto ha una caratteristica essenziale ai fini del ragionamento che stiamo svolgendo in queste pagine.
Entrambi gli aspetti, infatti, definiscono una «nuova storia» costruita sull’accumulazione di storie di f a- miglia verticali, non comunicanti tra loro, non trasmesse neppure tra membri della stessa famiglia che hanno attraversato la stessa esperienza, ma definita solo sulla linea della discendenza, per cui il capofamiglia è lo scampato che produce un nuovo albero genealogico.
Il testimone, in questa versione, non è più prevalentemente lo scampato o il sopravvissuto, ma diviene, da una parte, il suo discendente, coinvolto e investito di un’eredità traumatica e radicale della propria identità e, dall’altra, il competente, l’esperto. Di solito lo storico. E ciò che è successo, secondo Wieviorka, con il processo a Maurice Papon (r997-98), allorché, con la sua discesa in campo in un procedimento giudiziario, Io storico ha di fatto perduto la propria «innocenza»: ha assunto la dimensione del giudice e si è accreditato come il garante della verità inconfutabile.
Tuttavia, per quanto pertinente e certamente fondamentale, quest’osservazione coglie solo in parte il processo in atto con la vicenda Papon. Al di là della questione giudiziaria e del rapporto tra storiografia e diritto, ciò che è sotteso alla discesa in campo degli storici nell’arena dell’amministrazione della giustizia pone un problema molto più ampio e generale. In gioco, infatti, non è l’attendibilità documentaria degli storici o la loro competenza a giudicare di una vicenda, ma la credibilità che questa loro funzione pubblica determina. La vera partita non è più l’uso pubblico della storia ma la funzione pubblica degli storici.
Oggi agli storici, soprattutto ai contemporaneisti, è demandata una funzione in cui non è prevista una professionalità storiografica, ma solo la mobilitazione dell’opinione pubblica e il sostegno politico. L’effetto del loro presenzialismo è quello di sostituire la precedente vulgata con una nuova, altrettanto acritica o aproblematica, e soprattutto egualmente schematica. In breve, la costruzione di un nuovo testo retorico, magari persuasivo, ma spesso discutibile, se non inconsistente, suI piano della solidità storiografica.
Si aprono così due possibili strade nella valutazione del ruolo pubblico degli storici. La prima porta a considerare la riflessione storiografica come un atto di meri chierici che si misurano talora con il vasto pubblico dei laici, e quindi si attrezzano a intervenire extra moenia, dando luogo a una dimensione «edulcorata» o «drogata» della storia. La seconda, invece, allude a una possibile connessione fra storia e storiografia e al fatto che quel rapporto privilegiato vada comunque salvaguardato.
Non trovo convincente nessuna di queste due conclusioni ed è su questo piano che mi sembra di percepire un limite nella riflessione proposta da Annette Wieviorka.
Allorché il confronto con la storia non avviene più prevalentemente attraverso saggi scritti, che richiedono una lettura silenziosa e individuale, bensì attraverso cd, mostre, fiction, seria!, ipertesti… la trasmissione dei fatti diviene più problematica, ma anche versatile.
La scrittura storiografica vive di uno scarto fra descrizione degli avvenimenti e loro ricostruzione, per cui tra comprensione e comunicazione si collocano diversi filtri concettuali. La testimonianza è uno di questi. In particolare essa vive di un doppio registro: da una parte è il continuo divario fra la consapevolezza delle cose che il sopravvissuto aveva al momento della conclusione della sua esperienza e ciò che conosce ora, nel momento in cui parla; dall’altra è un contratto fra chi parla e chi ascolta.
La testimonianza è anche la percezione da parte del testimone dell’incompletezza e della parzialità di ciò che rievoca. Ciò accade in molti casi. Riprenderà la suddivisione proposta da Hilberg, vale per lo «spettatore» Ingmar Bergman, quando ripensa alle sue passioni giovanili, e vale per la «vittima» Jorge Semprun, quando esterna il proprio sconcerto per la discrepanza tra i suoi ricordi di prigioniero a Buchenwald — ciò che «aveva visto» — e ciò che 11 accadeva «davvero»: : lo scarto tra ciò che egli ricordava di aver vissuto e ciò che diveniva la sua memoria attraverso la visione dei film girati dalle truppe americane all’ingresso nel campo.
Allo stesso tempo il testimone parla della propria esperienza e competenza, ne parla con la sua lingua o servendosi del suo cosmo referenziale e concettuale, ma deve misurarsi con l’apparato cognitivo del suo interlocutore se vuole che la sua testimonianza risulti comprensibile e venga accolta. La testimonianza non è mai né una mera esposizione di eventi, né una semplice esternazione di ciò che si sa e di ciò che si pensa. E, invece, un continuo corpo a corpo tra ciò che si sente e ciò che si suppone i nostri interlocutori siano in grado di comprendere, e di accogliere. Se la testimonianza fosse solo comunicazione di ciò che si sa, non sarebbe altro che una sorta di confessione e non entrerebbe nell’ambito delle cose da discutere e da cui trarre informazioni, ma solo di quelle da ascoltare in nome di un galateo sociale, della «buona educazione ».
Le metamorfosi della testimonianza, su cui insiste Annette Wieviorka, rende comprensibile il legame tra colui che racconta, ciò che racconta e a chi lo racconta. La testimonianza si costruisce intorno a vari moduli che concernono il veicolo linguistico con cui viene comunicata: il lessico adottato, le immagini su cui si costruiscono i passaggi concettuali, i concetti e le parole su cui la voce si sofferma. La testimonianza appartiene a un ambito specifico della comunicazione di memoria e come quella vive della stessa morfologia. Si struttura come atto e non come fatto. Non è una sorta di promemoria per altri o una comunicazione impersonale. Essa si carica di un surplus che è dato dall’emozione del racconto, dalle pause, dai silenzi (anch’essi parte essenziale del testo). E una performance e vale proprio per la sua carica di emotività, per le domande alla storia che induce.
Il problema non è la saturazione indotta dai racconti, ma la capacità di leggerli e di collocarli in una galleria di immagini qual è, del resto, il fondamento del nostro senso comune. La partita intorno alla testimonianza rimane allocata sul piano dei dati che si raccontano fino a che la leggiamo all’interno di una serie, ma allorché essa si accredita come l’atto costruttivo di una vicenda di vita, assume anche altri connotati.
La testimonianza permette di cogliere altri aspetti di una storia che valgono per la loro singolarità, ma che ci restituiscono un contesto: ci consentono di ritrovare un passato fatto di relazioni, contrasti e conflitti, anche se quel passato è stato carico di dolore, angoscia e disperazione.
In questo senso occorre distinguere tra autobiografia e testimonianza. Se la pratica autobiografica libera e rende coscienti che i ricordi non sono espropriabili, quella testimoniale è esattamente il contrario: chiede che quel passato sia condiviso, che quei ricordi entrino nel bagaglio collettivo del sapere e che di essi rimanga traccia. Non come storia evenemenziale, ma come comunicazione del sentimento.
A quel livello inizia a porsi il problema della gestione della memoria, della comparazione fra testimonianze — non solo emesse da voci diverse, ma anche rilasciate nel tempo dalla stessa voce narrante — Politica e cultura del Giorno della memoria della funzione dello storico che si incarica di individuarne
e descriverne le stratificazioni, le forme narrative,
l’organizzazione del racconto. Lì si giocherà il futuro della testimonianza in quanto fonte per la storia. Ma anche quello del Giorno della memoria che in quelle testimonianze ha uno dei suoi fondamenti.(…)
Tratto dal terzo capitolo “Politica e cultura del Giorno della memoria”
(…) Un aspetto mi sembra rilevante: la convinzione che il Giorno della memoria riguardi solo la comunità ebraica e non sia un’occasione di riflessione pubblica sull’antisemitismo e sul razzismo. E un argomento che da allora si è più volte ripresentato nella discussione pubblica. E che costituisce un segnale significativo dei «non detti» che sottostanno alla pratica del Giorno della memoria.
Significativamente, infatti, essi si ripresentano il 27 gennaio 2001 per la celebrazione del primo Giorno della memoria. In quell’occasione si stabiliscono e si definiscono le forme della riflessione pubblica, i luoghi del «pellegrinaggio», la struttura delle manifestazioni e dei cortei (percorsi, ripartizione degli oratori, voci, scenografia e parole) che determinano nel giro di breve tempo la costruzione di una tradizione.
Quella spaccatura che si presenta nelle manifestazioni è confermata dalla tipologia della partecipazione e si manifesta soprattutto con le parole pronunciate nella discussione pubblica, durante le giornate di approfondimento nelle scuole e le mostre storiche che accompagnano i programmi di formazione scolastica ed extrascolastica.
A questa prima caratteristica se ne aggiunge un’altra. Nei luoghi pubblici la presenza della destra è sporadica affidata al personaggio locale, spesso solo in qualità di amministratore (sindaco, presidente della Provincia o presidente della Regione), mentre il «popolo della destra» semplicemente diserta l’occasione. L’opinione pubblica di destra non aderisce alle manifestazioni del 27 gennaio perché il Giorno della memoria è vissuto — tanto a destra come a sinistra — come una data che ripropone in forma monotematica lo schema culturale del 25 aprile. E questo perché, per motivi diversi, sia la destra sia la sinistra — e in Italia anche il mondo cattolico — non fanno i conti con una parte consistente del proprio bagaglio culturale.
Una parte della destra non si misura con il razzismo che ha segnato profondamente la sua fisionomia politica e culturale nel Novecento; l’altra parte fa finta di non sapere che quando si parla di «zona grigia», di mondo dell’indifferenza, è di lei che si parla. Entrambe pensano di risolvere il problema del genocidio ebraico ricorrendo alla retorica del «ben altro» ed evocando il Gulag. La sinistra pensa che sia sufficiente includere l’antisemitismo nell’antifascismo per risolvere il problema, evitando cosi di affrontare le questioni che da più di un trentennio hanno minato alcune fondamenta essenziali del suo schema mentale in merito a eguaglianza e differenza (peraltro senza mettere nel conto un confronto serrato con il suo antisemitismo, che non è nato casualmente, ha più di un secolo di vita sia nelle file dei riformisti che in quelle degli intransigenti).
Il mondo cattolico, in una porzione che in questi anni è sempre più aumentata, pensa che sia sufficiente predicare e praticare il perdono per risolvere il problema culturale del suo antigiudaismo, senza contare il fatto che, al suo interno, una minoranza numericamente consistente ha in mente di pensare Auschwitz come un luogo del martirio cristiano.
Nessuno in realtà mette in discussione il proprio profilo culturale e politico. E soprattutto nessuno percepisce il fatto che il proprio vocabolario non è capace di essere universalistico, da solo, se vuole riflettere su quell’evento.
Tutto questo non toglie, tuttavia, che fuori da quelle piazze, e per certi aspetti in contrapposizione a esse, prevalgano il linguaggio e il gergo del revisionismo storico, che spesso ripropone consumati luoghi comuni, i quali fanno dell’Italia delle leggi razziali un paese senza responsabilità, spostando il discrimine all’8 settembre 1943, al momento della cosiddetta «morte della patria», quando inizia la deportazione, evento che sarebbe avvenuto senza una responsabilità italiana, appunto, quindi interamente attribuibile al tedesco occupante e perciò «estraneo» allo spirito italiano.
Quello che si intendeva affrontare attraverso il Giorno della memoria tende immediatamente a tradursi in «uso politico del passato». Ossia un’operazione che propone una lettura del presente attraverso la scelta di un particolare del passato, ma in relazione agli interessi che si hanno qui e ora.
E significativo che sul Giorno della memoria nessuno polemizzi, anche perché criticare il genocidio ebraico nei fatti equivale a riaprire la questione del possibile negazionismo. In questo senso tanto a destra come a sinistra, ma anche nel mondo cattolico, il Giorno della memoria è riferito a un atto né scusabile, né contrattabile, e dunque percepito e presentato come barriera ultima non valicabile.
Ma questo aspetto apre tuttavia un problema a chi voglia proporre culturalmente una riflessione pubblica sul Giorno della memoria e sui suoi possibili contenuti. Il tema è come si discute della storia del genocidio ebraico, in che forme, in che modo e con quali domande. Più precisamente, affrontare la storia del genocidio ebraico richiede di indagare la storia politica, culturale, civile della società italiana. Non solo gli aspetti generali, ma anche le singole storie di vita.
Si deve tentare di descrivere e di affrontare la fotografia in movimento di una società o di uno spaccato di ambiente, confrontarli con altri, cercare di vederli come risultanti di tante singole storie o di vicende sospese tra pubblico e privato, dove il dato di vita non deve essere osservato con spirito voyeuristico, bensì con la delicatezza che richiede l’entrare per la prima volta nell’intimità e nel privato altrui. In questo senso, si potrebbe dire, la storia del genocidio ebraico rispetto alle domande che dovrebbe sollecitare il Giorno della memoria riguarda i molti modi possibili di affrontare una «microstoria» attuale, al cui centro stanno i sentimenti, i sistemi di relazione, i legami e i conflitti locali che tante volte hanno riguardato le singole vicende e il loro intrecciarsi.
Tuttavia la vicenda del genocidio ebraico analizzata dal punto di vista del Giorno della memoria non dovrebbe essere solo questo. Essa sollecita contemporaneamente una storia di «medio periodo» e una di «corta durata». Sono due velocità diverse ma che si uniscono e consentono due percezioni complementari degli avvenimenti.
Avere uno sguardo di «medio periodo» nel fare la storia del genocidio ebraico richiede uno studio sulla vita quotidiana di un quartiere, di una comunità, al cui centro stanno le relazioni tra individui lungo un ciclo di vita. Proporre un’analisi di «corta durata» significa mettere in evidenza la costruzione in tempi stretti di un corpo dileggi, atteggiamenti, sentimenti, opinioni, che consentano di isolare una fase della storia di una società in modo da poterla studiare e analizzare come un segmento compiuto all’interno di un più lungo periodo.
La questione delle leggi razziali in Italia è stata studiata spesso come lenta fuoriuscita da un sistema costruito troppo in fretta. Il problema tuttavia è che quella velocità allude a un sistema per certi individuabile nel paradigma già proposto da Hilberg a proposito della dinamica della Germania nazista, ovvero un meccanismo che non nasce intenzionalista, già definito a-priori, ma che si definisce attraverso progressivi aggiustamenti, correzioni, con l’ausilio di un archivio fatto di frasi, parole, concetti costruiti e consolidati nel tempo.
Così, affrontare la storia del genocidio ebraico significa comporre contemporaneamente delle storie di vita, ricostruire ambienti, ma anche proiettare quelle storie in un contesto e in un processo molto più lunghi, cercando nel passato la formazione di elementi a diverso titolo strutturanti il lessico dell’Italia delle leggi razziali. Un lessico che spesso è anche molto precedente a quello dell’Italia fascista e delle politiche seguite dal regime per la creazione non solo di uno «stile», ma di un linguaggio nazionale. (…)
Conclusioni
Dunque che cosa accade della testimonianza quando scompaiono i testimoni diretti? Restano dei racconti e la capacità o la volontà di attivarli da parte di un pubblico che nella sua maggioranza è costituito da spettatori. Rimangono le domande, la curiosità, la capacità di osservare, di riflettere, di rappresentare. E rimane il «mestiere di storico», fatto di scavo nei documenti per ricostruire nella forma più dettagliata la scena, sapendo che comunque permane un margine di non detto e che nessun documento fornirà una versione esaustiva e definitiva di com’è andata. Naturalmente quando non si intende usare la storia per ridisegnare un passato di comodo. Se invece è proprio questo l’obiettivo nel comporre il discorso pubblico, allora prevale una ricostruzione che non «turba il sonno», che consola ed esalta e che consente di salvarsi. Il passato diventa un racconto docile non tanto perché fondato sull’oblio, ma piuttosto sull’indifferenza e l’irrilevanza. Oppure sulla retorica che dice « mai più». E bene sapere che in quella retorica scompaiono molte cose: il contesto, l’analisi degli atti, lo scavo nella mentalità. In sostanza la società concreta. Il passato diventa banale — e dunque insignificante — o misterioso, appunto come il residuo cui allude la conclusione del racconto di Kafka con cui abbiamo aperto queste riflessioni.
Con il processo ad Adolf Eichmann, nel 1961 a Gerusalemme, si è aperta la partita sulla testimonianza come fonte per la storia. La replica degli scienziati sociali è stata quella di considerare quella nuova voce come un’opportunità per ripensare la coscienza storica contemporanea, una volta che si prendeva atto che fare i conti col Novecento richiedeva considerare nuove fonti e dotarsi di una sensibilità culturale e professionale molto più ampia rispetto a quella tradizionale.
Tuttavia sarebbe sbagliato e anche banale pensare che tutto sia una questione di metodo. Essenzialmente il «mestiere di storico» è maturare una diversa consapevolezza di che cosa vogliamo che sia il racconto della storia e Io scavo intorno aI passato. La questione del testimone, e del destino della sua testimonianza, alla lunga interroga la capacità degli storici di fare il loro mestiere oppure no. Ovvero di sapere che cosa sia il «loro mestiere». E esattamente quello che oggi mi sembra più a rischio, in particolare in Italia.
«Dopo l’ultimo testimone» ci sono molte figure: gli operatori culturali, il sistema mediatico, il mondo della politica… Ma una sola, per statuto, è chiamata a occuparsi del passato. Ed è lo storico. Vorrei essere molto chiaro, perché a questo proposito in Italia si spendono molte parole, senza produrre né certezza né chiarezza.
La stagione della testimonianza, con tutte le problematiche testuali, culturali, sociali ed emozionali che suscita, ha definito un rapporto fecondo e problematico con la riflessione storica. In ogni caso ha costretto a prendere le misure con una dimensione della narrazione del passato che a lungo era stata vissuta come «non storia». Sono le persone, i sistemi di relazioni, i conflitti, i sentimenti (e anche i risentimenti) che entrano in gioco e diventano fonte per la storia.
La questione della memoria come forma del ricordo e come struttura in cui il ricordo si organizza è un’acquisizione culturale recente. All’inizio degli anni ‘8o, quando ancora la memoria non costituiva un luogo culturale strutturale del linguaggio pubblico e della riflessione storica, Pierre Nora, uno storico cui si deve la messa a fuoco del rapporto inquieto e problematico tra storia e memoria scriveva in forma chiara della loro opposizione-cooperazione.
Memoria e storia: lungi dall’essere sinonimi noi ci rendiamo conto che tutto le oppone. La memoria è la vita, sempre prodotta da gruppi umani e perciò permanentemente in evoluzione, aperta alla dialettica del ricorso e dell’amnesia, inconsapevole delle sue deformazioni successive, soggetta a tutte le utilizzazioni e manipolazioni, suscettibile di lunghe latenze e improvvisi risvegli. La storia è la ricostruzione, sempre problematica e incompleta, di ciò che non c’è più. La memoria è un fenomeno sempre attuale, un legame vissuto nell’eterno presente; la storia una rappresentazione del passato. In quanto carica di sentimenti e di magia, la memoria si consolida con dettagli che la confortano; essa si nutre di ricordi sfumati, specifici o simbolici, sensibile a tutte le trasformazioni, filtri, censure o proiezioni. La storia in quanto operazione intellettuale e laicizzante, richiede analisi e discorso critico. La memoria colloca il ricordo nell’ambito del sacro, la storia Io stana e lo rende prosaico. La memoria fuoriesce da un gruppo che essa unifica, ciò che equivale a dire che ci sono tante memorie quanti gruppi; che essa è, per sua stessa natura, molteplice e riduttiva, collettiva, plurale e individualizzata. La storia, al contrario, appartiene a tutti e a ciascuno, aspetto che le conferisce una vocazione all’universale. La memoria si radica nel concreto, nello spazio, nel gesto, nell’immagine, in un oggetto. La storia si installa nelle continuità temporali, nelle evoluzioni e nei rapporti tra le cose. La memoria è un assoluto mentre la Storia non conosce che il relativo.
Dunque la memoria singolarizza, la storia tende a universalizzare? Sì e no. Non è solo un problema di metodi o di fonti. E anche un modo di lavorare con le stesse fonti.
Una fotografia, per un sopravvissuto, o comunque per qualcuno che abbia una relazione con ciò che essa raffigura, induce domande diverse rispetto a quelle che si pone uno storico. Il primo cercherà tracce del proprio passato, ricollocherà quel frammento dentro una scena, riaprirà un segmento di tempo e della propria vita. Il secondo si interrogherà a partire dal fatto che un documento da solo non dimostra niente e comunque non comunica molto. Vorrà perciò sapere perché si trovasse nel luogo in cui è stato reperito — niente è «naturale» nella dinamica della conservazione documentaria — e, più specificamente, in quale punto critico della serie documentaria si trovi; se sia accompagnato da segni o annotazioni esterne. E inoltre, nel caso del documento fotografico in particolare, se vi siano note sul luogo dello scatto, sulla data, sul contesto, sull’occasione, su chi abbia scattato quella ripresa e quante copie siano state diffuse. E inoltre si chiederà come quell’immagine si sia conservata, se sia stata usata e da chi. In breve quale uso ne sia stato fatto prima che giungesse nelle sue mani e come e perché vi sia arrivata.
La testimonianza sul contesto della foto evoca al testimone un flusso di ricordi, mentre allo storico genera un flusso di domande. Per lo studioso, infatti, è importante comprendere e analizzare — sempre nel caso del documento fotografico, ancora di più di quel-
lo cinematografico — le tecniche di ripresa, i tempi, 1’ angolatura, 1’ inquadratura, la scelta dell’ esposizione. Per il testimone quel documento è un frammento che evoca un’esperienza, racconta la sua storia; per lo storico il tassello di un mosaico che occorre ricostruire e che da solo non è in grado di parlare: deve comprendere attori esterni al documento, anche se coinvolti nella vicenda.
Il testimone è interessato a una storia che faccia perno sulla sua esperienza; lo storico deve considerare i molti attori sulla scena e perciò produrre una ricostruzione che abbia anche una funzione universalistica. Ovvero si rivolga anche a chi non c’era.
Tutto questo mette lo studioso in una posizione né opposta né alternativa rispetto al testimone. Ma uno storico è tale se è capace di coniugare due registri tra loro diversi. Come osserva Enzo Traverso:
Per un ebreo polacco, Auschwitz significa qualcosa di terribilmente unico: la dissoluzione dell’universo umano, sociale e culturale all’interno del quale è nato. Uno storico che non arriva a comprendere questo non potrà mai scrivere un buon libro sulla Shoah, ma il risultato della sua ricerca non sarebbe migliore se egli concludesse che il genocidio ebraico sia l’unico della storia.
In breve le voci testimoniali sono una traccia, un documento che dobbiamo prendere in carico, ma che dobbiamo rendere autonomo dalla loro metamorfosi in quanto prove. Per farlo occorre che contemporaneamente si avvii una nuova stagione di riflessione e di pratica sulla e della storia in grado di uscire tanto dal sensazionalismo come dall’«uso politico del passato». E l’idea della riflessione sulla storia passata come «lezioni da trarre», una mentalità che ha connotato sinistra e destra, e che, comunque, come ha sottolineato lo storico Langer, visti gli effetti in Rwanda, in Darfur e nella ex Iugoslavia, non sembra essere stata particolarmente efficace, anzi pare abbia insegnato come disumanizzare l’avversario. Quel racconto, dunque, non ha impedito che complessivamente la scena si ripetesse.
Tuttavia, non è solo una questione di « utilizzazione», ma di mentalità. Ovvero di ciò che chiediamo alla storia e di cosa pensiamo che siano gli storici.
«Dopo l’ultimo testimone» può aprirsi l’era del disincanto e della disaffezione. Ma potrebbe anche generarsi la possibilità di costruire una consapevolezza storica attenta alle molte fonti che utilizza e avvertita del fatto che la verità non le appartiene. Le è propria, al massimo, la possibilità della penultima parola, ovvero una narrazione e una ricostruzione documentata in cui l’obiettivo è un’approssimazione per difetto alla descrizione di «ciò che è avvenuto per davvero». Come sottolineava Arnaldo Momigliano «fra noi (in quanto storici) e i fatti sta la documentazione ».
Niente è già scritto. Dipenderà come si costruisce una riflessione civile sul rapporto tra storia e memoria. Perché ciò avvenga occorre che maturi una diversa consapevolezza del loro mestiere da parte degli storici e un modo consapevole e non spettacolaristico di raccontare.
Ciò che caratterizza la storiografia è l’essere una disciplina scientificamente fondata, consapevole dei propri limiti, pronta a riconsiderare l’intero dossier della propria ricerca quando altre fonti si presentino e rimettano in discussione le conclusioni; inoltre in grado di analizzare fatti e documenti anche con nuove metodologie. Da questo punto di vista il problema, come pure in Schindler’s List, non è solo raccontare tutta la storia, ma piuttosto come anche la sua
rappresentazione risponda a regole e suggestioni, e come ciò che viene comunicato non sia il passato soltanto, ma il modo in cui ciascuno se lo porti dietro e lo viva interiormente, lo risistemi e lo comunichi.
Per questo Schindler’s List, pur non costituendo un manuale per il xxi secolo di ciò che è accaduto nella metà del xx, è comunque un ottimo esempio di come oggi si parli di quel passato e si rappresenti il modo in cui è stato « archiviato» nella nostra mente.
C’è un senso comune che delega alla storia il compito di raccontare la verità. Non mi fiderei mai di una disciplina così potente e di professionisti detentori del mandato di scrivere l’ultima parola in merito a «come sono andate le cose del passato». Solo la verità di Stato viene presentata come l’ultima parola. Di solito la produzione storiografica che la omaggia, su qualsiasi supporto venga proposta e consumata, non ha aiutato a far crescere uomini e donne liberi.(…)
Memoria 1 – Annette Wieviorka: La Storia serve per agire nella società
Memoria 2 – Loewenthal: Una Storia ebraica senza lo sfregio della Shoah
Memoria 3 – Anna Foa: Attenti ai rischi di istituzionalizzare quello che è stato
Memoria 5 – Alessandro Schwed Dobbiamo ricostruire le emozioni
Memoria 6 – “La stella di Esther”, la persecuzione raccontata in un fumetto
Memoria 7 – Renzo Gattegna: “Aiuta tutti a non dimenticare”
Memoria 8 – Claudio Magris: “Gli ebrei parlano a nome di tutti”
Memoria 9 – Marcello Pezzetti: “In Italia manca ancora una presa di coscienza”
Memoria 10 – “Il libro della Shoah italiana”. Lo sguardo dei perseguitati e il loro sentire
Memoria 11 – Furio Colombo “Il 27 gennaio serve ancora?”
Memoria 12 – Helen Epstein. Il trauma delle generazioni successive
Memoria 13 – Quelle parole che tornano in vita
Memoria 14 – Alberto Cavaglion. Il prezioso diario di Hélène Berr
